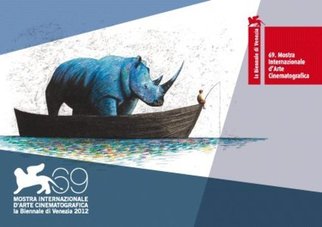In questo special, le recensioni di alcuni dei migliori film della 69. Mostra del cinema di Venezia.
|
Bella Addormentata
diretto da Marco Bellocchio. Molto prima della sua uscita, questo film di Bellocchio era praticamente e principalmente conosciuto come più o meno “il film su Eluana Englaro”, sulle sue vicende. Ma dai primi minuti (anzi, addirittura dalle prime, caotiche inquadrature) è facile comprendere come in realtà tale affermazione sia in buona parte inesatta. |
k |
Il perno di Bella addormentata è certamente costituito dalla situazione di Eluana Englaro, dal caso politico che questa è diventata, dall’atmosfera (a dir poco inquinata) creata dalla politica su questi avvenimenti, ma non soltanto. E’ chiaro, insomma, che l’origine di questo film è il caso Englaro, ma non si può dire che sia un film su Eluana Englaro. In esso infatti Bellocchio non si “si mette a osservare” unicamente la storia (o meglio dire parte della storia) di Eluana e dei "dintorni politici" che questa ha generato (né il padre di Eluana né quest’ultima vengono infatti mostrati, se non, per quanto riguarda la donna, attraverso fotografie), ma parla anche (e, forse, soprattutto) di altro: uno dei meriti di questo film è infatti la capacità di intrecciare quasi a incastro vicende pubbliche con vicende private, i cui protagonisti sono, più o meno, persone della vita di tutti i giorni. Bellocchio, insomma, ricostruisce per la precisione gli ultimi sei giorni di Eluana in coma (e in stato vegetativo da diciassette anni) attraverso tre episodi che mettono in evidenza, appunto, tre storie diverse fra loro: abbiamo una madre, grande attrice teatrale (Isabelle Huppert), che rinuncia alla propria carriera per la disperazione che prova nel vedere la figlia Rosa ridotta a un vegetale (e, soprattutto, assolutamente contraria a interrompere questa sua condizione); un medico (Pier Giorgio Bellocchio) che fa di tutto per salvare una giovane tossicodipendente (Maya Sansa) dal suicidio; Maria (Alba Rohrwacher), un’attivista ultracattolica che protesta davanti alla clinica dove si trova Eluana e figlia di un deputato del Pdl (Toni Servillo) non in linea con il proprio partito per il voto al provvedimento Sacconi per il mantenimento in vita di Eluana.
La “forza” della dimensione privata, almeno in certi momenti del film, sembra addirittura avere la meglio su quella pubblica: durante le manifestazioni dei cattolici contrari all’interruzione delle cure di Eluana, infatti, Maria viene in contatto con Roberto (Michele Riondino), un contro manifestante (laico) di cui si innamora ricambiata.
La “forza” della dimensione privata, almeno in certi momenti del film, sembra addirittura avere la meglio su quella pubblica: durante le manifestazioni dei cattolici contrari all’interruzione delle cure di Eluana, infatti, Maria viene in contatto con Roberto (Michele Riondino), un contro manifestante (laico) di cui si innamora ricambiata.
|
La tenerezza e la sensualità emanate dal rapporto (anche intimo, come dimostrano le scene in albergo) fra queste due persone così diverse ma così capaci di stare bene insieme sembra addirittura sospendere per qualche debole minuto la “situazione Englaro”; una sorta di “episodio” su un contatto fra due corpi così potente da essere capace di eliminare differenze di pensiero a dir poco ingombranti.
|
Nei primi minuti del film il montaggio sembra essere il padrone dello stile, un montaggio abbastanza concitato, quasi da thriller, un montaggio “indaffarato” a manifestare la propria presenza, a esprimere la tensione - specialmente quella degli inizi - dei diversi accadimenti. Un montaggio che, soprattutto, da un punto di vista narrativo mostra da subito la compresenza delle tre storie, tutte unite però dal “fil rouge visivo” (e a dir poco significativo) dei vari televisori che mostrano i politici in parlamento che discutono sul caso Englaro e dei telegiornali che ne parlano.
E ancora, dal punto di vista stilistico, risulta rilevante anche il rapporto espressivo che viene a crearsi fra il contenuto di ciò che i televisori trasmettono (sia che si tratti di dirette dal parlamento o di semplici visioni private) e i pezzi di realtà delle tre storie. La storia della grande attrice interpretata da Isabelle Huppert che insiste nel voler tenere viva la propria figlia Rosa ormai in stato vegetativo sembra racchiudere un significativo esempio in tal senso. A circa metà del film, infatti, viene mostrata attraverso un campo totale una porzione del salotto della severa casa della grande attrice all’interno del quale, sulla sinistra, si trova un televisore che trasmette un’immagine di alcuni ippopotami che lentamente, quasi immobili, si aggirano sul fondo di un ambiente acquatico (forse un documentario). Proprio questa immagine sembra fungere in maniera indiretta da metafora, triste e spietata allo stesso tempo, della condizione abbastanza improponibile di Rosa in stato vegetativo e, di conseguenza, ovviamente, di Eluana.
In queste condizioni da vegetali, infatti, le “vite” di queste donne (e, ovviamente, di chiunque sia costretto a “vivere” in tal modo) sono come sott’acqua, quasi in formalina, ormai impossibilitate a uscire da questa dimensione per tornare a vivere normalmente.
La contrarietà alla (cieca) prigionia dell’accanimento terapeutico sembra venire fortemente espressa visivamente anche in altre occasioni. Il volto di Rosa distesa sul letto che ci viene mostrato improvvisamente con un mezzo primo piano sembra davvero dire tutto nella sua spietata semplicità: quasi perfetto nella sua bellezza chiara ma che, allo stesso tempo, rende evidente il suo stato vegetativo che la fa assomigliare a una bambola che sembra trovarsi in qualsiasi punto che non abbia a che fare con la vita. Tale contrarietà al forzato mantenimento in vita viene espresso anche senza metafore visive, in maniera diretta, attraverso il discorso contro l’accanimento terapeutico di Eluana che il senatore del Pdl (Toni Servillo) prova da solo nel proprio studio il giorno prima della votazione.
E ancora, dal punto di vista stilistico, risulta rilevante anche il rapporto espressivo che viene a crearsi fra il contenuto di ciò che i televisori trasmettono (sia che si tratti di dirette dal parlamento o di semplici visioni private) e i pezzi di realtà delle tre storie. La storia della grande attrice interpretata da Isabelle Huppert che insiste nel voler tenere viva la propria figlia Rosa ormai in stato vegetativo sembra racchiudere un significativo esempio in tal senso. A circa metà del film, infatti, viene mostrata attraverso un campo totale una porzione del salotto della severa casa della grande attrice all’interno del quale, sulla sinistra, si trova un televisore che trasmette un’immagine di alcuni ippopotami che lentamente, quasi immobili, si aggirano sul fondo di un ambiente acquatico (forse un documentario). Proprio questa immagine sembra fungere in maniera indiretta da metafora, triste e spietata allo stesso tempo, della condizione abbastanza improponibile di Rosa in stato vegetativo e, di conseguenza, ovviamente, di Eluana.
In queste condizioni da vegetali, infatti, le “vite” di queste donne (e, ovviamente, di chiunque sia costretto a “vivere” in tal modo) sono come sott’acqua, quasi in formalina, ormai impossibilitate a uscire da questa dimensione per tornare a vivere normalmente.
La contrarietà alla (cieca) prigionia dell’accanimento terapeutico sembra venire fortemente espressa visivamente anche in altre occasioni. Il volto di Rosa distesa sul letto che ci viene mostrato improvvisamente con un mezzo primo piano sembra davvero dire tutto nella sua spietata semplicità: quasi perfetto nella sua bellezza chiara ma che, allo stesso tempo, rende evidente il suo stato vegetativo che la fa assomigliare a una bambola che sembra trovarsi in qualsiasi punto che non abbia a che fare con la vita. Tale contrarietà al forzato mantenimento in vita viene espresso anche senza metafore visive, in maniera diretta, attraverso il discorso contro l’accanimento terapeutico di Eluana che il senatore del Pdl (Toni Servillo) prova da solo nel proprio studio il giorno prima della votazione.
|
Comunque, sembra esserci un modo di indignarsi anche attraverso il filtro affilato dell’ironia, sia, ad esempio, grazie ai discorsi sui politici del senatore psichiatra interpretato da Roberto Herlitzka sia, ancora una volta, attraverso lo stile. Nella seconda parte del film, ad esempio, una rapida inquadratura è unicamente occupata dalla scritta bianca su sfondo rosso riferita alla discussione del caso Englaro in parlamento:
“Lunedì 9-2-2009 seduta pubblica”. |
L’inquadratura immediatamente successiva, che apre la nuova scena, è costituita da un campo totale che mostra uomini immersi comodamente in alcuni punti di una fumosa sauna mentre osservano un televisore che trasmette le immagini del parlamento.
Il collegamento fra le due inquadrature sembra abbastanza lampante: per molti politici presenti nel parlamento italiano, infatti, la seduta (o, meglio ancora, le sedute in generale) non sono che soltanto, appunto, semplici... sedute. Sedute durante le quali non fare niente, durante le quali non apportare niente di positivo (in questo caso per Eluana). Un modo questo forse, da parte del regista, di mettere in comunicazione le due inquadrature per mostrare come molti politici (in Italia, in questo caso) prendano il Parlamento per una sorta di sauna dove, appunto, non fare niente, dove vengono pagati per riposarsi fingendo di fare qualcosa.
Dunque un film, sia stilisticamente che tematicamente, più movimentato e concitato rispetto al precedente Sorelle mai, che trae ovviamente la sua ispirazione e origine dal caso Englaro, argomento che però permette allo stesso tempo a Bellocchio di mettere ancora una volta in campo temi che lo hanno sempre interessato e nutrito (e che lui stesso ha sempre nutrito attraverso i suoi film) come la religione, il fanatismo religioso, la politica e l’azione sovversiva (o almeno un tentativo di azione sovversiva) contro buona parte di questa.
Il collegamento fra le due inquadrature sembra abbastanza lampante: per molti politici presenti nel parlamento italiano, infatti, la seduta (o, meglio ancora, le sedute in generale) non sono che soltanto, appunto, semplici... sedute. Sedute durante le quali non fare niente, durante le quali non apportare niente di positivo (in questo caso per Eluana). Un modo questo forse, da parte del regista, di mettere in comunicazione le due inquadrature per mostrare come molti politici (in Italia, in questo caso) prendano il Parlamento per una sorta di sauna dove, appunto, non fare niente, dove vengono pagati per riposarsi fingendo di fare qualcosa.
Dunque un film, sia stilisticamente che tematicamente, più movimentato e concitato rispetto al precedente Sorelle mai, che trae ovviamente la sua ispirazione e origine dal caso Englaro, argomento che però permette allo stesso tempo a Bellocchio di mettere ancora una volta in campo temi che lo hanno sempre interessato e nutrito (e che lui stesso ha sempre nutrito attraverso i suoi film) come la religione, il fanatismo religioso, la politica e l’azione sovversiva (o almeno un tentativo di azione sovversiva) contro buona parte di questa.
Daniel Montigiani
Altre recensioni di questo numero speciale 69. Mostra del cinema
|
|
Chi ha visitato questa pagina ha letto anche:
Revue Cinema
diretta da D. Montigiani - Sezione Storici Il servo, diretto da Joseph Losey Teorema, diretto da P. P. Pasolini Il raggio verde, diretto da Eric Rohmer Bella di giorno, diretto da Louis Bunuel Rashōmon, diretto da Akira Kurosawa |
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati