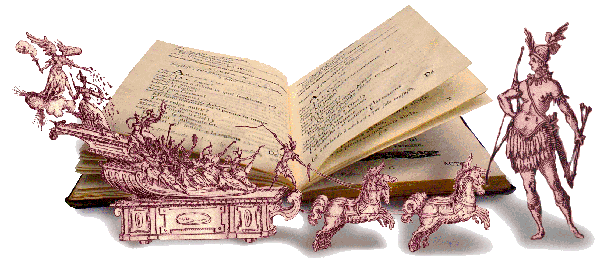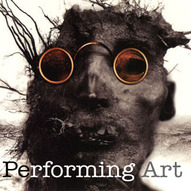Sezione Ecosofia Alphaville Sezione diretta da Silverio Zanobetti
Rubrica Conferenze e tavole rotonde
. Per una Ecosofia del futuro
Il sedicesimo numero della rivista PASSPARnous
presenta la “Sezione Ecosofia”.
presenta la “Sezione Ecosofia”.
Che cos’è una conversazione?
«Laddove non si discute, bensì si conversa, il fine dichiarato della riflessione è quello di non aver fine, di riuscire cioè a passare ad altro, di venir fuori dall’ordine imposto delle questioni, fattore di una sempre nefasta (pseudo)rassicurazione identitaria: nella conversazione, in cui non si parte e non si arriva da nessuna parte, si tracciano dei divenire, si cattura e si è catturati, si realizza una cattura molteplice, che tutto cambia. C’è una formula affascinante, tratta da un commentatore di Mozart e che Deleuze ripete con convinzione: la conversazione è una “confidenza”, senza però un “interlocutore possibile”, il che restituisce il suo tracciato di divenire come qualcosa di non riferibile a processi di assimilazione o di imitazione, non riducibile all’unico momento della “territorializzazione”- coloro che conversano, si incontrano, per così dire, “sul percorso di una deterritorializzazione comune, ma disimmetrica”, non inquadrabile dal regime dello scambio e però percepibile come formazione di un “blocco”, di una sorta di evoluzione a-parallela”. Conversare è insomma sempre un po’ una fuori-uscita di testa, un uscire fuori della/dalla testa (quella fuga che si ritrova nei dipinti di Bacon), che imbarazza gli assetti e le configurazioni – i “voli” e i risvolti intimi, sapientemente ri-vissuti e rappresentati – della nostra personalità, di quella “istituzione” che vale, come scriveva A. Gehlen, soltanto “per un caso” (e forse anche per caso)»[1].
Questa conversazione, di cui vi proponiamo in questo numero la prima parte (inseriremo la seconda in un prossimo numero), nasce da una domanda: come continuare a “fare filosofia” laddove «il peso di un filosofo dipende dal suo grado di consapevolezza della difficoltà di pensare e, soprattutto, dalla capacità di porre questa difficoltà a oggetto principale della filosofia stessa»?[2] Qual è il rapporto tra il pensiero e il sistema filosofia nel consolidarsi della sua istituzione?
Per cominciare a capire la portata di queste domande è innanzitutto necessario fare una cartografia delle operazioni strategiche politiche attuali che la filosofia sta operando. Pensare non significa più, dopo Nietzsche, attuare uno sguardo essenziale, un esercizio riflessivo. Diviene azione, pratica strategica, esercizio politico[3].
Prima ancora si tratta di capire come iniziare a trattare di questi problemi: il problema dell’inizio da Hegel fino a Derrida (passando per Heidegger) è sempre in gioco. Ma questa conversazione non inizia…e non finisce.
Si insiste ancora oggi con quell’inutile civetteria che sostiene l’“inutilità della filosofia”; ma la filosofia non può porsi al di là dei conflitti che la producono. Laddove si illude di farlo la filosofia non può far altro che produrre poteri (mascherati dalle buone maniere “professorali”, dalla solidarietà dei “colti”, dalle chiuse “comunità di pensiero”) e dominare il pensiero: dove e come questo avviene? Come funziona il potere che la filosofia continua a detenere e a usare nel momento in cui si trasforma nel consulente teorico in “Cosmopolis” di Don De Lillo?
Uno dei nodi della conversazione consiste nel concetto di istituzione, fin da subito al centro dell’interesse di Deleuze; concetto utilissimo nel momento in cui egli attua quel passaggio dal diritto alla politica[4] da lui stesso confessato. L’istituzione non è qui intesa nel suo senso meramente conservativo: se anche continuiamo a parlare di conservazione l’oggetto della conservazione è «ciò che “muove” l’istituzione, nell’istituzione»[5]. Ciò significa che il desiderio non è sovversivo ma opera attraverso istituzioni? Aldo Pardi e Rosella Corda si confronteranno su questo, sulla possibilità che una politica del desiderio possa essere colta nei suoi sterminati potenziali di istituzionalizzazione, come delineazione possibile di spazi di mediazione, di soddisfazione ulteriore[6], laddove l’istituzione diventa mortifera quando si distacca totalmente dalle tendences: «La tendenza, insegna Hume, si realizza solo nelle istituzioni, pertanto la legge non viene “prima” ma rinvia all’istituzione che delimita: la società non è un complesso di obbligazioni bensì un composto di convenzioni fondato sull’utilità»[7]. La potenza spinoziana aumenta o diminuisce a seconda della capacità di creazione di “costrutti istituzionali da apprezzare nella loro costitutiva provvisorietà/revocabilità”[8].
|
Dal film Cosmopolis
di David Cronenberg: VK: Bisogna riflettere sull’arte di produrre capitali. I greci usano una parola: Krymatistikos. Ma va usata con maggiore elasticità. Va adattata alla situazione attuale, perché è cambiato il significato di denaro. I grandi capitali esistono solo fine a sè stessi; non c’è nessun altro tipo di ricchezza. |
Ormai il denaro ha perso la sua forza narrativa, come l’ha persa la pittura tanto tempo fa. Parla a sè stesso, ormai. E questa macchina, che io adoro: la luce dei monitor, io adoro i monitor, è la luce del cyber-capitale, radioso e accattivante. Io non ci capisco nulla. Non si ferma mai? Non rallenta? Certo che no. Perché dovrebbe? È fantastico. Ma tu sai quanto io diventi sfrontata di fronte a tutto ciò che si auto-definisce “idea”: l’idea è tempo. È vivere nel futuro. Guarda tutti quei numeri che scorrono: mettono in moto il tempo. Una volta invece era il contrario. Gli orologi hanno accelerato l’ascesa del capitalismo, la gente ha smesso di pensare all’eternità e si è concentrata sulle ore, quantificando le ore, ore lavoro, per rendere più efficiente il lavoro. È il cyber-capitale che crea il futuro. Tu sai quanto è il valore di un nanosecondo?
EP: È dieci alla meno nove.
VK: E quanto sarebbe?
EP: Un miliardesimo di secondo.
VK: Il concetto non lo afferro. Ma questo mi dimostra quanta precisione sia necessaria per misurare il mondo attorno a noi.
EP: Esistono gli zeptosecondi. Gli ioctosecondi. Un settilionesimo di secondo.
VK: Perché il tempo è un bene aziendale oggi. Appartiene al sistema del libero mercato. Il presente è più difficile da trovare; lo stanno risucchiando fuori dal mondo, per far posto a un futuro di mercati incontrollabili ed enormi potenziali di investimento. Il futuro diventa insistente. Ecco perché presto accadrà qualcosa, forse oggi stesso, per correggere l’accelerazione del tempo, e per riportare la natura alla normalità.
(all’esterno scoppia progressivamente la protesta, una folla inferocita assalta l’auto)
[...] Afferra il concetto: più è visionaria l’idea, più persone rimangono indietro. Questo è il motivo della protesta: illusioni di tecnologia e ricchezza, la forza del cyber capitale che spedirà la gente a vomitare e a morire nelle fogne.
EP: È dieci alla meno nove.
VK: E quanto sarebbe?
EP: Un miliardesimo di secondo.
VK: Il concetto non lo afferro. Ma questo mi dimostra quanta precisione sia necessaria per misurare il mondo attorno a noi.
EP: Esistono gli zeptosecondi. Gli ioctosecondi. Un settilionesimo di secondo.
VK: Perché il tempo è un bene aziendale oggi. Appartiene al sistema del libero mercato. Il presente è più difficile da trovare; lo stanno risucchiando fuori dal mondo, per far posto a un futuro di mercati incontrollabili ed enormi potenziali di investimento. Il futuro diventa insistente. Ecco perché presto accadrà qualcosa, forse oggi stesso, per correggere l’accelerazione del tempo, e per riportare la natura alla normalità.
(all’esterno scoppia progressivamente la protesta, una folla inferocita assalta l’auto)
[...] Afferra il concetto: più è visionaria l’idea, più persone rimangono indietro. Questo è il motivo della protesta: illusioni di tecnologia e ricchezza, la forza del cyber capitale che spedirà la gente a vomitare e a morire nelle fogne.
Conversazione fra Aldo Pardi e Rosella Corda:
ALDO PARDI: Da dove si comincia a discutere? Un inizio è fulcro creativo, uno spunto che scaturisce come un’eccezione affermando l’esistere dove non c’era. Un cominciamento dona tutto l’essere a ogni suo avvenire. È un gesto divino, per definizione, o, ammettendo un’intenzione cieca a tale ingiunzione ad essere comandata da un capacità assoluta di fondazione, una sacra vertigine del volere. Ma una creazione d’essere è proiezione solitaria. La realtà totale creata rimanda all’Uno che la genera. E una discussione è dispersa in una dimensione plurale. E non comincia. Continua a produrre discorso dal molteplice che la compone. La singolarità di un dire è condizione dell’incontro tra enunciazioni parziali. Ogni locuzione porta una porzione di contenuto, investe un segmento esistente del significare. Il nostro, dove c’incontriamo, incrociando esperienze di parola estrinseche, in un contatto teso alla parola, è la filosofia: la condizione in cui si attiva il suo sviluppo, i suoi apparecchi, i suoi meccanismi, il senso che pone funzionando nell’attualità del neoliberismo globale, in cui si affermano specifiche modalità di determinazione della teoria rispetto a una generale, particolare disposizione della società.
Questa conversazione non inizia. Continua un movimento che coinvolge la filosofia fin nelle sue radici più profonde, fin nelle piegature delle operazioni di connotazione semantica che toccano il concetto e i suoi significanti. In sintesi, facendo affidamento dei passaggi di Foucault, si potrebbe dire che se nell’antichità il problema della filosofia era il “ dire il vero”, in epoca romana il “dire il governo” e in epoca medioevale il “dire il comandamento”, l’epoca moderna ha visto la teoresi impegnata a “dire la norma”, e a nominare il suo portatore primo, il “soggetto”. In questa filiera di definizione generale di termini di legalità e di modalità normativa, si è proceduto all’organizzazione secondo facoltà - fatto salvo i loro conflitti - delle procedure di concet-tualizzazione. La filosofia si proprone come istituzione garante e titolare della legittimità del pensiero, e organizza i suoi uffici secondo la distribuzione gerarchica di ruoli di un organismo statuale. L’architettura teorica che vede una successione scalare di discipline con al vertice un principio di verifica dalla cui totalizzazione tutte le altre applicazioni di pensiero derivano e dipendono, in quanto fondate sull’assenso di una condizione di ultima istanza. Quello che il “soggetto” è per la teoria, la “filosofia teoretica” è per l’istituzione. Il tentativo del post-moderno non ha fatto altro che ampliare, attraverso la confusione di ambiti e gradi gerarchici, la funzione giudicatrice del fondamento essenziale, la soggettività ponente, e la preminenza della concettualizzazione uniformatrice che prende le vesti disciplinari della teoretica - mascherata da settore minore: estetica, filosofia morale, ecc. Questo impianto, di natura crociana, ancora struttura le pratiche teoriche e l’organizzazione dell’università. Oggi, esso prende però una natura fondamentalmente diversa, che ne detta una mutazione di forma. La filosofia si ridisloca secondo un quadro dei poteri del segno che cambia in relazione a una congiuntura mutata. In un altro scenario, la normazione filosofica, cui si può dare il nome di “Ragione illuministica”, si è attivata per assoggettare pratiche refrattarie al disciplinamento. L’arte e la storia, soprattutto, come la strategia di Kant mostra in modo esplicito, in parte la scienza, in particolar modo quella medico-psichiatrica. Marx ha, per esempio, reagito alla sussunzione all’ideale usando la conoscenza storica come arma di eversione nel concetto. O potremmo citare il lavoro d’emancipazione dall’autorità della norma compiuto dalla pittura, o dalla poesia - dal romanzo bisognerà attendere Poe e gli scapigliati -. Queste pratiche, nello scacchiere della costruzione del moderno vissute come estranee, sono in questa congiuntura assorbite nei processi di totalizzazione. La filosofia le riconosce, le accorpa ai suoi procedimenti, si lascia impiegare in virtù di una identità profonda che riguarda moduli logici come elementi segnici. È il sintomo che la disposizione e il significato del filosofare hanno cambiato di orientamento. La filosofia cambia di posizionamento, nel campo di battaglia del segno in cui esercita le sue azioni totalizzatrici. Il potere che la filosofia continua a detenere e a usare, sovranità indiretta e proprio per questo quanto mai stringente - il personaggio del “consulente teorico” in Cosmopolis di Don De Lillo ne é la figura compiuta - non conosce le stesse misure e le stesse modalità. Questo dialogo, si svolge come sintomo della presa imperativa proveniente da questo potere. Chi parla qui sono schegge schizzate dall’intervento di una forza filosofica che usa il concetto in modo nuovo, reinventandone, sulla base di asserti già codificati, gli ordini e la finalità. Questi frammenti si staccano e vagano sul cozzo prodotto dall’intervento disgregatore ed escludente dell’elaborazione teorica. La filosofia moderna impone il Soggetto come categorema primario e terminale, forma dell’universale integrazione alla regola. Anche Heidegger, al di là delle sue formule, non esce da questa formazione. L’“evento” non è che una soggettivazione all’ennessima potenza, talmente assoluta da sfuggire a ogni concettualizzazione. La “totalità” della capacità legislatrice è il problema della teoresi a base trascendentale. Il Soggetto ha prodotto assorbimento e identificazione, ancor più che manifestazioni generative. Nella congiuntura teorica in cui siamo presi, la Soggettivazione estende le sue devoluzioni normalizzanti resecando, smembrando ed espellendo segmenti concettuali non integrabili. Quello che in generale accade nel pensiero anglosassone, in cui é la teoria “analitica” a incarnare tale manovra, nella revanche del cattolicesimo fenomenologico francese, le esaltazioni infatuate del post operaismo negrista, ne fanno da riscontro puntuale. Da espulsi, a partire dal movimento di estromissione da cui siamo portati, e che ci sta mettendo in dialogo, la filosofia sembra mettersi in moto per assemblare macchine soggettive che non dettano norme generali, ma espletano compiti di occupazione di spazi di pensiero per impadronirsene, assumerne il governo e quindi svolgervi mansioni di polizia. Uno schieramento dato da esigenze di imperialismo possessivo ma escludente, conduce e monta gli impieghi del concetto, e la loro architettura interna, L’Ego consumatore e possidente. Questo comporta un organigramma filosofico centrato su tre significanti motori: il bisogno, come concetto della totalizzazione dell’Io, il desiderio, come categoria dell’azione appropriativa, e il narcisismo, come idea della rimozione della singolarità estrinseca a favore del dominio esclusivo dell’individualità accentratrice, unico principio di conduzione e condizione fenomenica del soggetto. L’istituzione filosofica, la facoltà che ne realizza gli apparati di gestione e controllo, diviene per conseguenza non “organismo di legge”, ma “impresa”, investimento possidente per ricavare proprietà in uno scenario di conflitto tra possessori autocentrati. Le guerre che questo provoca, i tagli che ne scaturiscono, e le risposte che cercano di controbattere contendendo posizione per posizione, credo siano al centro di questo incontro, e ne assembleranno la parola.
ROSELLA CORDA: Da dove si inizia? È spesso una domanda occasionata a partire da un imbarazzo di relazione. Capita talvolta, per esempio, quando ci si sente toccati da qualcosa che, nel suo rivolgersi a noi, ha già prodotto l’esitazione di un’interpellazione, rispetto a cui, chiamati a replicare, non sappiamo esattamente come comportarci. Maggiore è l’effetto toccante della condizione di essere toccati, minore è la capacità di pronta risposta. Un’interdizione è il preliminare di un inizio. O meglio, trattandosi di una condizione di incertezza rispetto a una variazione di stato, questa domanda sull’inizio, che fa problema, è già una risposta al dato grossolano e pulviscolare insieme, di un incidente affettivo – o di una incisione affettiva. L’interferenza e l’incrocio, l’attraversamento che intercetta, l’ostacolo segnato nell’istante – tremendamente qualsiasi e privo di uno statuto e di una veste, ancora troppo “nudo” – costituisce l’antecedente illogico di un inizio, che quando inizia è già risposta – retrospezione.
Sicché, paradossalmente, quando ci si trova a parlare di “inizio”, si è spesso alla fine. Bisognerebbe forse dire: da dove abbiamo iniziato, con tono di stupore e di meraviglia o con piglio polemico del tipo: non t’avessi mai incontrato! Da dove si inizia. Risponderei: da qualcosa che ci tocca, che ci prende, che ci ri-guarda. E non nei termini di un già noto episodio, ricordato come un fatto risolto, pacifico, da rimodulare in facili retoriche; bensì nei termini di quella originaria, ahimé quasi sempre “maledetta”, interdizione all’azione abituale: riprendere la parola da balbuzienti. Tentare la parola perché tentati dagli/negli affetti. Alterazioni inaggirabili e moltiplicate per piani paralleli: una parola tentata procede per la sua via di richiami ad altre parole forse più stabili, meno improvvisate, più docili. Così come, per altre carni, un affetto rivolto, simile a una zolla di terra rivoltata, richiama per sé affetti più sodi, di presa più facile.
Si parla dell’inizio e spesso le parole sono tracce di cenere, di fuochi sacri ormai spenti. Si parla dell’inizio e le parole cospargono di cenere l’iniziabile che si annida nell’inizio. Certo, allora si parla da morti e di morte. Si parla del niente in quanto niente. Si fa del nulla – portandolo in processione come un santo (o un santone, se nulla-zombie), rivestito da sincretismi più o meno stratificati e pittoreschi. Si tratta di inizi altisonanti, in genere commemorazioni pubbliche, perfino spudorate, e non rimemorazioni a uso privato, riservato, sobrio ed emozionato.
Dell’inizio - però. Non della fine.
Si parla dell’inizio laddove l’inizio è nel non-appena dell’iniziabile e dunque quello scarto dall’infarto dell’incontro è terra che sfugge da sotto ai piedi. Si corre e si rincorre, e il percorso rimane tanto più incommensurabile quanto più le distanze sono minute, piccole, brevi. È vivo il materiale dell’inizio. E una retrospezione in rima a questa vita – rima sgranata – non segna mai la fine come non può segnare un inizio che non sia anche un iniziato: un avviato-a, un toccato – forse anche un poco folle, fuori di un senno scaduto – rispetto all’iniziabile.
Da dove inizio? Da una piccola cosa che ho a cuore e che mi ha nel cuore – sembra una corrispondenza di reciprocità e in vero si è sempre più d’uno, direi si è sempre smezzati nella condizione del problema dell’inizio, e fra multipli “frazionari”. Si è sempre “comunità” (uso prudenza): ma in comune circola una differenza, quella scintilla che accende e scalda e ravviva la vicinanza, la prossimità. Il comune è istigato, molestato, perfino tormentato dai suoi intimi scarti. Disappartenenze essenziali al comune relazionale che fa dell’inizio un problema: un problema aperto. E della domanda, appunto, una domanda strategica e non ideologica: che fare? Come agire. Si pensa a una risposta come a una soluzione tattica. Parto da qui e vado lì: e sono nel mezzo. Nel mezzo di un grande casino che mi tocca da tutti i lati, mi comprime, mi tasta, mi situaziona, e che ho necessità di dominare. Faccio una mappa. Definisco direzioni. Mi oriento a cartografare. Le parole sono indicative di dove si vuole andare e come si vuole procedere. Sono la configurazione di un impegno reale, vivo, motivato. Sono nel mezzo e dunque devo capire come muovermi muovendo cosa. Da soggetto all’inizio, “iniziato”, devo farmi soggetto che inizia e per far ciò si ha bisogno, continuamente, di tutta la propria capacità inventiva, di tutta la positività di cui il proprio profilo porta le millesimali orme e cicatrici, di tutte le risorse che abbiamo, di tutta la virtualità, la forza, l’energia di cui siamo capaci. È necessario: produrre forme di vita per vivere, in una biochimica immunitaria il cui comando in contrappunto si articola in attuazioni di senso antropo-poietiche.
Si inizia un poco alla volta, un poco per uno, un poco divisi. Entrambi, io e te, leggevamo che si inizia tra-due. E sappiamo che non si alludeva all’impossibilità dell’inizio. Anzi. Si scavava talmente in quel frattempo incendiario dell’inizio, a velocità sicuramente disumane, che se ne rivoltavano le condizioni contro se stesse in un reset radicale, rispetto a cui non si può non riprendere, appunto, l’avvio.
Tu mi dicevi del trascendentale.
E mi torna alla mente un motivo: “l’inconscio è orfano”. Detto tra amici, a proposito dell’inizio. Quanto e di cosa vogliamo popolare ciò che è in produzione, in combustione? Il fuoco o si alimenta o si spegne. Mantenerlo è alimentarlo. Dalla parte del fuoco si è prima orfani e poi si genera un padre – riconoscimento dissimmetrico. Il figlio genera/costruisce il padre: ed è simultanea produzione differenziale. Ma non si smette di alimentare la fabbrica del fuoco, se non nella morte – che del resto è solo un ulteriore passaggio di stato. Insomma, sappiamo bene, non c’è fine come non c’è inizio, se dobbiamo immaginarli come stazioni di un rullo cosmico del tempo omogeneo; e sappiamo che le condizioni a priori, da rinvenire in ragione della posizione di una questione, non si danno se non alla luce di singolarità sparpagliate e non soggetti presupposti che vanno, infine, a nullificare e vanificare qualunque teoresi autenticamente ispirata al trascendentalismo.
Dell’illuminismo, oggi, vale ancora la pena rinnovare l’impulso (alla piena affermazione); ma questo è tanto più praticabile se si farà tesoro di una lezione, variamente composta, venuta dopo e presente nei nostri reciproci richiami. Così come oggi è necessario ribadire con forza che pensare è un’azione: l’ordine teoretico e l’ordine etico, pur essendo distinti, significano per momenti diversi quella stessa risposta di produzione di senso implicata nell’inizio. Necessità di un’emancipazione del soggetto dal Soggetto: del plurale dall’Unico.
Le nostrane cronache politiche (o dissimulazione del tale e quale show per ogni parte identica all’altra) sono state sature di echi di cadute e decadenze. Il pensiero come azione si prefigge un impegno, a partire dall’inizio. Questo impegno, al di là di assoggettabili militanze, non è arruolabile e non arruola. L’impegno, allora, è nel cartografare le risorse necessarie a diagnosticare quegli arroccamenti di potere che inficiano la crescita, lo sviluppo, la realizzazione di “affetti di gioia” – ci potrebbe piacere di ricordare.
Non ci placa l’abbattimento di un simbolo, così come si è orfani nell’inconscio.
Non ci placa l’ideale di una rivoluzione futuribile. Né ci soddisfa la necrofagia della violenza. Gli spiriti malati ammalano – è la loro prerogativa. Un loro bacio è morso di un vampiro. Non si alimenteranno “affetti-tristi”. Si lavora piuttosto alle più piccole svolte, alla pratica del senso da sismografi del potere e degli affetti da non arrestare ma da liberare. Si lavora per produrre orizzontalità, pluralità, perché da sempre e ovunque il Potere irreggimenta nella sua propria produzione di verità, pesando e pestando i corpi come fossero sassi, per farne un niente polverizzabile e riutilizzabile.
Sicché la vedo ardua.
Qui si vuole iniziare quello che sempre ricomincia. Si vuole istituire il pensiero sempre d’accapo, laddove viene continuamente destituito. Diciamo che si vuole rilanciare ciò che infine vuole riposare afflosciandosi su di sé, ricadendo in pose artefatte. Forse è una lotta contro se stessi: vincere le trappole del proprio particolare risentimento invalidante. Contro il proprio stesso bisogno di fermarsi e cercare riparo. Contro la propria stessa vocazione all’illibertà. Ma quando una condizione esistenziale vibra inesorabilmente, la corsa può essere arrestata solo dall’ultimo cattivo incontro – eppure, si tratterà in ogni caso di un passaggio di consegne. Seminare per contagio, dunque e ovunque, la vitalità di quel sapere aude in rima a cosa può un corpo.
ALDO PARDI: In questa deviazione che ha scomposto lo stato ci siamo dunque trovati a derivare rimbalzando dall’inizio. Un rinvenire di movimenti s’intrica stacco per stacco e segue. Questa è la parabola, è porta con le sé le impulsioni del peso che le ha condotte a sbilanciarsi insieme. La traiettoria porta la gravità dei suoi problemi. Nel nostro caso, per me, sono domande in sospensione. Questioni non occasionali né ondivaghe, ma centrate propriamente nell’in-clinazione preliminare da cui hanno mosso. La consistenza che dà loro forza sta nel dominio di cui sono parte: parliamo di pensiero e di configurazioni di pensiero. La direzione dell’intrico è data dalle problematiche che fanno la loro disposizione specifica. Faccio io da pressione movente, e ti pongo delle domande. Il pensiero e la filosofia attivano compagini avverse. Riprendendo un’asserzione spinoziana, il pensiero è estrinseco a resezioni normative, e a totalizzazioni a forma piramidale. Ancora, e soprattutto in Italia, la filosofia domina il pensiero, sia rimuovendolo, sia combattendolo. Severino e Agamben sono i portatori eccellenti di un posizionamento imperativo e dispotico del filosofare, che ha i suoi apparati di comando in schiere universitarie dalle tendenze distinte ma alla fine solidali: dal cattolicesimo heideggerista, all’agostinianesimo tomista kantiano, all’hegelismo dialettizzante e spiritualista del caleidoscopio di frazioni marxisteggianti. Potremmo discutere su come tutte queste postazioni non siano che epigone di un pervicace crocianesimo che è il vero inconscio teorico dell’accademia filosofica italiana, e non solo. Potremmo analizzarne le manovre, tra glossa anodina e commentario pedante. Ma qui ora, la questione ci porta a scorrere alla ragione del suo prodursi: negli interstizi laschi e nelle zone estranee della filosofia, si compongono segmenti di pensiero. Ma che traiettorie, e per quali modalità di costruzione, assumono? Dove avvengono secessioni, in che direzioni si tendono? Che assetti e che diagrammi tracciano?
Uno spostamento in secessione non accade senza rottura. Da circa 60 anni, a parte pochissime eccezioni, al di là del loro orientamento, e sempre pressoché emarginate dalla vulgata ufficiale – Costanzo Preve, Nicola Massimo De Feo, Gianfranco La Grassa, per non citarne che tre – la filosofia dominante esercita un potere diretto attraverso i dispositivi di gestione, controllo e riproduzione del sapere di cui possiede l’imperio. La filosofia si distende, diversa e contigua, sui poteri prevalenti nella nostra condizione socio - storica schierandosi in ordinamento di comando: filosofia è “facoltà”. Faccio chiaramente riferimento a una famosa analisi di Derrida sull’uni-versità, distorta da Rovatti. in apologia del sapere “critico” e “aperto”, nel senso liberale di potestà individualistica sul “proprio” intelletto. Ti domando, già scostato dal tuo spostarsi per la questione che ritorna anche su di me come moto d’interrogazione, dov’è che la produzione del pensare in scissione attacca e lacera l’istituto dominatore che ne governa il contesto? In che modo, secondo quali spunti offensivi, “invettive” direbbe Carlo Emilio Gadda, il concetto entra in rotta con il corpo del potere filosofico e lo colpisce uscendone per aggregarsi in complessi a – categoriali, abdicando ogni proprietà normativa giudicante e le sue “facoltà”?
ROSELLA CORDA: Ritrovandoci d’accordo sul momento asimmetrico dell’inizio, il resto non può seguire se non esplicandosi da questo “fuori del dentro”. Si tratta di intrecciare linee di fuga: avvolgere nastri di forze e svolgere nastri di potere. La questione è chiara: fare e produrre pensiero non è identico al sistema filosofia nel consolidarsi della sua istituzione. Il punto è quanto di necessario si dà, in termini di sedimentazione dei tessuti di forze in potere, nel consolidarsi di una istituzione (l’istituzione non vuole morire e neanche durare, bensì conservarsi nello stesso suo ordine prestabilito) o se c’è, nell’essenza dell’istituzione, una scintilla di quel fuoco che sposterebbe più in là il gioco della staffetta dei saperi.
Che l’immanenza della linea di fuga sia stata tradita a partire da Kant e mutata in muraglia di facoltà, producendo vuoto arbitrio autoreferenziale per parti e fazioni e non autodeterminazione creativa, questo potrebbe essere un effetto e non una causa. Bisogna fare chiarezza e soprattutto capire se e come le energie buone possono rimettersi in circolo al di là di questo tramonto - compimento di una metafisica a comparti strumentali da ancien regime. Non solo per nutrire speranze di vita ma anche per assegnare di nuovo un senso a quell’impegno di cui si diceva: l’impegno integrale di un intellettuale che rinasca dalle ceneri di un vile vassallaggio da corte (universitaria), riassumendo su di sé lo scopo di un turno di parola non orientato alla futile parcellizzazione del plurilinguismo tecnico-scientista, ma finalizzato a un dialogo aperto con il mondo. E non si tratta, qui, di prestare il fianco a scarne e pretestuose polemiche circa la presunta difficoltà di un linguaggio, quello pensato, che scoraggerebbe di per sé la partecipazione. Non c’è lingua di massa. La lingua è sempre forza sedimentata in potere. La lingua batte spesso stanca: pulsando come luce di stelle già morte. La lingua viva è differenziale, è minuta e fa la differenza. Non si avrà timore, dunque, di un linguaggio minore, pensato e forse ostico. Una profonda fiducia deve animare queste riflessioni e gli slanci che verranno. Una fiducia in una antropologia affermativa posta in quello stesso cominciamento logo-patico. Distinguendo il semplice dal facile e il sentire dal cieco soffrire , si può sfidare chi parla e chi ascolta.
Dicevamo che occorre riflettere su questo, se il contesto disciplinare della filosofia, ripartita in autorità autoreferenziali senza alcuna cogenza di reale autorevolezza intellettuale nel mondo, arroccate nelle casseforti di ricchezze già dissipate da altri, sia il destino o sia solo uno dei rigagnoli che, per falsa prospettiva, appaiono fiumi in piena. E, beninteso, non si tratterà di forzare nulla nell’ennesima prepotenza di merito – gerarchizzare, secondo una trama assiologia, un ordito di tracce, per produrre il solito canovaccio da scimmiottare (allievi come figli di un unico padre signore e padrone, per fazione). La questione è ancora e sempre: scardinare il potere. Perché se c’è un nemico del pensiero, questo è nel suo doppio di cera rappresa: il potere, il più basso grado di potenza.
Quando, allora, un soggetto istituzionale rallenta in potere? a cosa e a chi conviene questo rallentamento fino allo stallo? Si evince che dal mio punto di vista non necessariamente un’istituzione è portatrice di un negativo sottrattivo rispetto alle singolarità individuali. L’istituzione (culturale nel nostro caso), infatti, potrebbe e dovrebbe costituire un acceleratore di particelle, a partire da una ripartizione multidisciplinare, condivisa, orizzontale e interculturale dei saperi. Dovrebbe offrire, nella ridondanza della sua diversa posizione di scala rispetto al singolo (o presunto tale, parliamo sempre di “frazioni” e non di fazioni, per noi), un potenziamento delle risorse, dirigendo le forze verso la loro affermazione. Direzione delle forze è cartografia delle linee di fuga (così come si può cartografare una trama di poteri) e non immediatamente irreggimentazione statica. Più che un freno, dunque, nella sinergia che agevola mettendo in rete le energie, è un catalizzatore.
Laddove, infatti, le università funzionano, producono queste straordinarie condizioni di crescita. Dove non funzionano, invece, si continua a morire di un fading indefinito. Una costellazione di presidi di stampo feudale, dove il parlato delle lingue maggiori sussume il resto in una smorfia di scherno, ad attestare l’assoluto di posizioni la cui specificità è, invece, sempre di un peso relativo. E ci scansiamo anche da falsi movimenti come improprio terreno di confronto: non ci interessa alcun piano di scontro-confronto generazionale. Bisogna, piuttosto, intendersi sui principi e sulle dinamiche: sulle regole del gioco, aperte a tutti i concorrenti, indipendentemente dalle coordinate di provenienza. E sulle finalità responsabili di questa impresa. La crisi che viviamo, millantata, strumentalizzata in una retorica tanto sottile quanto lasciva (seduttiva fino al suicidio), è pur sempre una crisi culturale e su questo nessuno è al riparo dalla esposizione in prima linea – non ci sono seconde linee sul piano della realtà perché queste sussistono solo negli indietreggiamenti dissimulatorii di quelle metafisiche ipocrite di cui sopra: ognuno il suo orticello.
La prima linea è nell’incontro con l’altro e nella occasione di riflettere e lavorare insieme che già questo offre, nella sua piccola incidenza, come nel nostro caso.
ALDO PARDI: Non c’é una richiesta di speranza, da individui da una parte reclamanti un diritto che si fa natura prima e dall’altra latori di una esigenza di garanzia, nel domandare all’istituzione di scindersi tra gestione e controllo – come una sorta di anima decaduta o determinazione maligna - , e promozione e inclusione? Eppure, un’istituzione funziona attraverso entrambi questi snodi di accorpamento. L’università, le sue facoltà, sono dispositivi istituzionali: non solo svolgono funzioni giuridiche, ma soprattutto di governo. Da una parte l’istituzione delibera: esercita azioni di organizzazione, gestione, controllo. Dall’altra, pone le regole e i principi che ne conducono le procedure interne: stabilisce e ingiunge norme alla sua compagine e ai membri che la compongono. In entrambe queste azioni, un’istituzione si stabilisce secondo due coordinate d’attivazione: incorporazione ordinante degli elementi di cui costituisce il contesto e l’orizzonte pragmatico; totalizzazione della forma delle relazioni che ne pongono la specifica configurazione. Un’istituzione stabilisce un sistema di bisogno che chiama l’intenzione, un ventaglio di “desideri”, rendendo fine dell’applicazione la conferma e la ripetizione della sua architettura. Un’istituzione si estrinseca in facoltà, cioè ponendo e sostenendolo un dominio di possibilità, e facendone, potenzialmente all’infinito in quanto valido per ogni funzione ed elemento, il processo giudicante motivante il gesto. Per questo l’istituzione è sintesi posizionale e imperativo tetico. L’istituzione si avvale del sovrano arbitrio di dettare dati di fatto, cioè di condurre la verità ad esistere, e di farne le determinazioni a priori di una universale volontà di reale, cioè di forma e materia dell’intenzione. Se mai può esistere un’entità “desiderante”, questa è l’istituzione, poiché è sempre Soggetto che si trascende verso il mondo che si figura nelle sue devoluzioni intrinseche.
L’istituzione colloca un ordine accorpando parti per inglobamento. Questo significa esercizio di direzione e capacità di assoggettamento. Significa avere il potere di appropriarsi di parti per farne funzioni di proprietà: fattori di uso, rendimento e beneficio da cui l’organismo nel suo complesso si assicura biologicamente la sopravvivenza. Questo, secondo quanto ben definito da Deleuze, è sussistere come dispositivo. L’istituzione è un dispositivo. Dispone dei segmenti subordinati per riprodurre assoggettamento, ne conforma le declinazioni, ne uniforma le linee e i presupposti, fino ad amministrare la superficie sensibile in cui l’epidermide si elettrizza nello sfregamento con le cose. L’istituzione è regolamentazione, canone pragmatico e affabulazione dell’immaginario. L’immaginazione sogna, pensa, agisce nei suoi membri. Non lo fa come entità separata. L’istituzione non è un contenitore astratto, esterno ai suoi membri e vacuo in sé. L’ordinamento del possibile, secondo le connotazioni poste dalla diversità delle sue materie, è effetto di un potere. Il potere è la facoltà sintetica su cui s’innestano tutte le altre, nel complesso efficace di un apparato. Per questo ha come predicato essenziale la gerarchia. L’istituzione è potere, capacità sovrana di comando. Un ordine non viene dal nulla. Implica la massa severa e crudele di un braccio che prende o colpisce, e il volto altero che minaccia o corrompe. È sempre una o più parti prevalenti che, vincendo un conflitto, costituiscono una formazione sociale. Un’istituzioni non esiste senza padroni. Questa padronanza che è costituzione di un regime fa dell’istituzione un’entità statuale, corpo di Stato e organo amministrativo. “Facoltà” è dunque l’altro nome dei titoli, delle condizioni e delle potestà di un dominio: fazioni che sussumono fazioni occupandone lo spazio e sottomettendolo alla loro autorità. È vero, come dici, che la deriva della facoltà è un effetto. Ma non di una successiva degenerazione che ha corrotto una pratica prima intatta nella sua purezza. È che l’istituzione che sia la polis, o il feudo, il comune medioevale o la monarchia, la schola o l’università, si compone sulla specificità, sulla determinatezza di un incontro tra componenti sociali, che dal loro confronto vanno a disporre una determinata morfologia della dominanza. Kant non ha fatto altro che codificare, riprendendo ed estendendo un gesto cartesiano, l’infinita attitudine normativa e governamentale della soggettività, definendone gli uffici e le loro forme legislatrici: le facoltà, appunto.
Con la modernità il carattere d’ingiunzione tetica, soggettivamente dispotica della facoltà è andato estendendo la sua presa. Non è un caso che questa affermazione sia stata teorizzata agli albori dello Stato moderno, da Machiavelli, e poi pienamente definita in termini di trascendenza di una capacità d’ingiunzione prima da Hobbes, e poi, rispetto alla centralità della funzione di universale “messa a norma”, da Kant. Sono astrazioni, tutte queste, indubbiamente. Un’as-trazione sfugge il vissuto. Non lo nega, s’istalla altrove. La ricognizione dell’imporsi forzoso dell’istituzione è un movimento avverso: rifiutandosi al potere, separa un fronte e ne incide il corso, spingendo le fazioni a farsi riconoscere. In qualunque modo si sia dato, anch’esso frutto di conflitti e perciò di congiunture, questa scissione – che nulla a che fare con alcuna “riap-propriazione” o richiesta di “diritto” - , identifica un apparato nei suoi termini di dominanza. Una secessione nella teoria demarca fazioni teoriche. Nella istituzione filosofica italiana esse sono comandate da dispositivi totalitari che fanno capo al cattolicesimo liberale, al liberalismo pragmatista, all’hegelismo destinale, all’efficientismo epistemologico, al moralismo laico e all’onnipotenza desiderante. In ognuna di queste frazioni le categorie di “soggetto”, “sog- gettivazione” e legalità soggettiva stanno alla testa: la lettura trascendente - distorta - di Heidegger e l’uso della fenomenologia sono appunto il breviario filosofico che celebra le liturgie universitarie della chiesa del Soggetto. Allo stesso modo, in quanto vertici di un istituto di governo, come “facoltà” esse s’impongono ai “soggetti” governati come regime del pensiero e strumentario dell’azione. Nelle “facoltà” universitarie non s’insegna nulla, né si “ricerca”, in senso rigoroso: si applica un principio di obbedienza conforme su cui vigila la polizia del pensiero e della parola. Questo dispositivo di sussunzione è la ragione di sussistenza della facoltà. Non prevede spazi di libero pensiero nei suoi stessi presupposti. Per questo non si tratta di recuperarlo a una disponibilità alla circolazione di idee ed esperienze. Nel momento in cui il pensiero agisce come apparato istituzionale, già lì è in atto un comando e un interdetto. Ciò che nelle università si chiede è di “essere conformi”, cioè di dare prova di obbedienza e rispetto. Né basta riportare tutto questo ai “professori”, magari ordinari, distribuendo responsabilità POLITICHE secondo i gradini della gerarchia. In questo senso, come dicono molte vulgate d’impronta marxista, lo studente sarebbe la parte esterna, poiché esterno e estrinseco al potere, dell’apparato universitario: una mente vergine qualificata per questo dalla purezza dei suoi intendimenti. Non è così. Tutte le componenti prese in un organismo di comando partecipano alla sua riproduzione. Quello che si vede accadere nei dipartimenti, il servilismo, la prostituzione, l’ipocrisia, la miseria di un sapere ingurgitato come un comandamento o un decalogo, non sono altro che fenomeni di una generale pragmatica del dominio. La totalizzazione dell’istituzione detta modalità e compiti a ognuna delle sue sezioni, differenziandoli per funzione, non per finalità. E questa organizzazione non è a sua volta distinta dal contesto generale in cui l’istituzione prende posto accanto ad altre istituzioni, con i cui elementi dominanti stringe rapporti di alleanza così da instaurare i poteri in una compagine complessiva. Anche tra sezioni dominanti esistono relazioni gerarchiche, che li dividono in diverse capacità di determinazione strutturale. I contenuti totalizzanti del pensiero stanno al fianco, in questa congiuntura, della totalizzazione dominante l’università come le altre istituzioni: la prevalenza dei processi di riproduzione del capitale globalizzato. Il pensiero lavora, come pensiero, per un’università-impresa. Il pensiero, non come funzione direttamente economica, ma come teoria, agisce per sottomettere idee a un ordine di comando con a capo il Soggetto. Il termine che nel pensiero una secessione si è data, a mio parere, è quando una stringa concettuale, svincolata per una falla nell’apparato o per una rottura verificatasi in seguito a un qualsiasi urto, si connette e lavora in senso estraneo e avversativo al discorso al comando. Questo significa pensare “altro”, disporre il pensiero in un “altro” modo – che poi è un pezzo della ricerca su cui si sono confrontati Deleuze e Derrida – e, soprattutto, sfuggire alla sintesi mettendo al centro il darsi all’“altro”. Al chiacchiericcio dotto e supponente dell’istituzione, sempre assertoria e dogmatica nel suo eterno blaterare, far prevalere l’ascolto, proprio per le sue capacità svianti, squilibranti, trasformative, che spingono il concetto in basso, nel piano degli incroci tra eguali dove il pensiero costruisce deviando, invece che elevarsi in linea verticale per svettare, soggetto supremo, sulle schiere dei “soggetti”.
Restano comunque molte cose da chiarire: cosa significa, specificamente, esercitare una “scissione”? Tu parlavi di “via di fuga”: ma siamo sicuri che il semplice star fuori l’istituzione non sia in fondo un riconoscerne la potenza assoluta? Un pensiero che lavora secessione, effetto di rotture, non è di per sé una frazione combattente che avversa una forza di comando nel momento stesso in cui costruisce un organismo pensante del tutto diverso? E se questo è lo schema generico di un pensiero straniero, quali ne sono le proprietà? Sempre se possiamo dirci d’accordo, naturalmente.
Rosella Corda: Partire dall’inizio, così come si è fatto, rischiara su di un’assunzione teorica preliminare e determinante: l’empirismo radicale e la sua declinazione in empirismo tra- scendentale, proprio secondo la lezione impartita da Deleuze.
A seguito di questa assunzione, emerge una prima decisiva questione: non c’è già un soggetto, e tuttavia è falso ammettere che non ci sia niente. La grana delle potenze, la risoluzione di immagine a livello della contiguità variante degli affetti, bene rende la pseudo idea di una virtualità positiva in produzione e profusione. Il passaggio problematico, se accettiamo queste premesse, inerisce la degradazione della potenza in potere e non la resistenza a un potere dato in forza di un soggetto presupposto – ed è questo il secondo e più centrale rilievo, rispetto al nostro discorso. In questo momento viene a manifestarsi quale sia il paradigma di riferimento per pensare il problema delle istituzioni. Siamo posti di fronte un bivio teorico. Accettata questa premessa, l’alternativa di un bisogno-del-soggetto è essenzialmente esclusa, a meno che non la si voglia intendere, come a breve dirò, in quanto dissimulazione disonesta; al contrario, risulta evidente come si configuri una materia desiderante-il-soggetto. Il taglio vivente delle forze non può che delineare delle incurvature, delle piegature che segnano e consegnano delle emergenze. La virtualità precipita in soggetto: precipita più soggetti. Tanti per quanti tagli interessati si possono produrre. Questa pluralità di soggetti che tengono e tendono alla propria tenuta, al limite si identificano nella propria differenza (di potenziale) volendo vivere, sono resistenze prima di cifra eccedente-affermativa e poi, in rimando e ricezione, di cifra negativa. Si tratta, dunque, di soggetti diversi: in conflitto perché in immediata relazione differenziale. Sulla soglia della presenza si affacciano costellazioni di coaguli identitari in movimento. Identità che è l’effetto critico di una autopercezione differenziale. La chimica degli affetti, il sostrato dei vissuti, ha le sue velocità: accelerazioni e lentezze. Maggiore è l’eccitazione-eccitabilità della materia desiderante del soggetto, maggiore è la sua velocità e, al limite, la sua inafferrabilità per se stesso; viceversa, man mano che si produce un rallentamento della vitalità, si produce una degradazione della potenza in potere. Il potere vuole se stesso: conservarsi nel suo fading indefinito, vivere nella crepa della sua morte immortale. Il potere resiste di quella resistenza che la potenza non conosce. Al modo di un qualunque soggetto, l’istituzione, che è complessifizazione del desiderio di soggetto del desiderio di soggetto (individuale), partecipa a questo destino. Si percepisce luce di stelle ormai morte: così talvolta si parla (sebbene in maniera pertinente e analitica) di istituzioni da tempo consumate dal loro stesso declino. Si scarifica la luce e si misconosce una questione fondamentale: non si resiste contro un’istituzione morta, non si resiste contro il potere. Si milita, piuttosto, per la potenza: si lavora per la produzione del nuovo. Questa l’anima del costruttivismo. Resistere contro il potere comporta una dinamica sostanziale di mistificazione: farsi assorbire in quelle logiche di rallentamento e assoggettamento proprie di una traduzione del desiderio in bisogno e della ricchezza della virtualità in un nulla omogeneo, tanto mortifero quanto gestibile – dissimulazione disonesta esercitata dal potere per mantenersi saldo, dando luogo a un divenire-zombie di contagio. Il punto non è stare fisicamente dentro o fuori: il punto è il profilo di una postura etica, ovvero alimentare il massimo fuori del dentro, la linea di fuga appunto, a qualunque latitudine esistenziale ed esistentiva. Esercitare lo scardinamento interiore disciplinando quello che Borges chiamava il labirinto peggiore (in linea retta), la rima di un tempo che non ritorna, destabilizza ma certamente non annoda e strozza.
Spesso le istituzioni hanno finito da molto di corrispondere a quelle velocità desideranti da cui hanno pur tuttavia tratto origine; sicché, invece di facilitare e sollevare, esonerare dal continuo dover inventare soluzioni di soddisfacimento, diventano ostacolo. Si traduce il sollevare nella seduzione finalizzata al dominio (come l’istituzione ipostatizzata di «Uomo» è stata mortifera per l’uomo stesso). Per intenderci, potremmo concepire questi due momenti di vita e di morte delle istituzioni (tra potenza e potere) come le due modalità di lettura della volontà di potenza nietzscheana: una volta in senso deleuziano, in quanto volontà differenziale e vivente; una volta in senso heideggeriano, secondo il vessillo del negativo e della morte, in quanto volontà per lo stesso, per la ripetizione annichilente.
Il potere, dunque, va combattuto alimentando la potenza: producendo altro che, di conseguenza, distrugga l’inadeguato. Rispetto alla seduzione-trappola di un sollevarsi dall’onere della potenza alienandosi nel riconoscimento concesso dal potere (e svilirsi morendo con esso), superare questa dialettica da servi per riappropriarsi della dialettica di un superamento affermativo.
ALDO PARDI: Da dove si comincia a discutere? Un inizio è fulcro creativo, uno spunto che scaturisce come un’eccezione affermando l’esistere dove non c’era. Un cominciamento dona tutto l’essere a ogni suo avvenire. È un gesto divino, per definizione, o, ammettendo un’intenzione cieca a tale ingiunzione ad essere comandata da un capacità assoluta di fondazione, una sacra vertigine del volere. Ma una creazione d’essere è proiezione solitaria. La realtà totale creata rimanda all’Uno che la genera. E una discussione è dispersa in una dimensione plurale. E non comincia. Continua a produrre discorso dal molteplice che la compone. La singolarità di un dire è condizione dell’incontro tra enunciazioni parziali. Ogni locuzione porta una porzione di contenuto, investe un segmento esistente del significare. Il nostro, dove c’incontriamo, incrociando esperienze di parola estrinseche, in un contatto teso alla parola, è la filosofia: la condizione in cui si attiva il suo sviluppo, i suoi apparecchi, i suoi meccanismi, il senso che pone funzionando nell’attualità del neoliberismo globale, in cui si affermano specifiche modalità di determinazione della teoria rispetto a una generale, particolare disposizione della società.
Questa conversazione non inizia. Continua un movimento che coinvolge la filosofia fin nelle sue radici più profonde, fin nelle piegature delle operazioni di connotazione semantica che toccano il concetto e i suoi significanti. In sintesi, facendo affidamento dei passaggi di Foucault, si potrebbe dire che se nell’antichità il problema della filosofia era il “ dire il vero”, in epoca romana il “dire il governo” e in epoca medioevale il “dire il comandamento”, l’epoca moderna ha visto la teoresi impegnata a “dire la norma”, e a nominare il suo portatore primo, il “soggetto”. In questa filiera di definizione generale di termini di legalità e di modalità normativa, si è proceduto all’organizzazione secondo facoltà - fatto salvo i loro conflitti - delle procedure di concet-tualizzazione. La filosofia si proprone come istituzione garante e titolare della legittimità del pensiero, e organizza i suoi uffici secondo la distribuzione gerarchica di ruoli di un organismo statuale. L’architettura teorica che vede una successione scalare di discipline con al vertice un principio di verifica dalla cui totalizzazione tutte le altre applicazioni di pensiero derivano e dipendono, in quanto fondate sull’assenso di una condizione di ultima istanza. Quello che il “soggetto” è per la teoria, la “filosofia teoretica” è per l’istituzione. Il tentativo del post-moderno non ha fatto altro che ampliare, attraverso la confusione di ambiti e gradi gerarchici, la funzione giudicatrice del fondamento essenziale, la soggettività ponente, e la preminenza della concettualizzazione uniformatrice che prende le vesti disciplinari della teoretica - mascherata da settore minore: estetica, filosofia morale, ecc. Questo impianto, di natura crociana, ancora struttura le pratiche teoriche e l’organizzazione dell’università. Oggi, esso prende però una natura fondamentalmente diversa, che ne detta una mutazione di forma. La filosofia si ridisloca secondo un quadro dei poteri del segno che cambia in relazione a una congiuntura mutata. In un altro scenario, la normazione filosofica, cui si può dare il nome di “Ragione illuministica”, si è attivata per assoggettare pratiche refrattarie al disciplinamento. L’arte e la storia, soprattutto, come la strategia di Kant mostra in modo esplicito, in parte la scienza, in particolar modo quella medico-psichiatrica. Marx ha, per esempio, reagito alla sussunzione all’ideale usando la conoscenza storica come arma di eversione nel concetto. O potremmo citare il lavoro d’emancipazione dall’autorità della norma compiuto dalla pittura, o dalla poesia - dal romanzo bisognerà attendere Poe e gli scapigliati -. Queste pratiche, nello scacchiere della costruzione del moderno vissute come estranee, sono in questa congiuntura assorbite nei processi di totalizzazione. La filosofia le riconosce, le accorpa ai suoi procedimenti, si lascia impiegare in virtù di una identità profonda che riguarda moduli logici come elementi segnici. È il sintomo che la disposizione e il significato del filosofare hanno cambiato di orientamento. La filosofia cambia di posizionamento, nel campo di battaglia del segno in cui esercita le sue azioni totalizzatrici. Il potere che la filosofia continua a detenere e a usare, sovranità indiretta e proprio per questo quanto mai stringente - il personaggio del “consulente teorico” in Cosmopolis di Don De Lillo ne é la figura compiuta - non conosce le stesse misure e le stesse modalità. Questo dialogo, si svolge come sintomo della presa imperativa proveniente da questo potere. Chi parla qui sono schegge schizzate dall’intervento di una forza filosofica che usa il concetto in modo nuovo, reinventandone, sulla base di asserti già codificati, gli ordini e la finalità. Questi frammenti si staccano e vagano sul cozzo prodotto dall’intervento disgregatore ed escludente dell’elaborazione teorica. La filosofia moderna impone il Soggetto come categorema primario e terminale, forma dell’universale integrazione alla regola. Anche Heidegger, al di là delle sue formule, non esce da questa formazione. L’“evento” non è che una soggettivazione all’ennessima potenza, talmente assoluta da sfuggire a ogni concettualizzazione. La “totalità” della capacità legislatrice è il problema della teoresi a base trascendentale. Il Soggetto ha prodotto assorbimento e identificazione, ancor più che manifestazioni generative. Nella congiuntura teorica in cui siamo presi, la Soggettivazione estende le sue devoluzioni normalizzanti resecando, smembrando ed espellendo segmenti concettuali non integrabili. Quello che in generale accade nel pensiero anglosassone, in cui é la teoria “analitica” a incarnare tale manovra, nella revanche del cattolicesimo fenomenologico francese, le esaltazioni infatuate del post operaismo negrista, ne fanno da riscontro puntuale. Da espulsi, a partire dal movimento di estromissione da cui siamo portati, e che ci sta mettendo in dialogo, la filosofia sembra mettersi in moto per assemblare macchine soggettive che non dettano norme generali, ma espletano compiti di occupazione di spazi di pensiero per impadronirsene, assumerne il governo e quindi svolgervi mansioni di polizia. Uno schieramento dato da esigenze di imperialismo possessivo ma escludente, conduce e monta gli impieghi del concetto, e la loro architettura interna, L’Ego consumatore e possidente. Questo comporta un organigramma filosofico centrato su tre significanti motori: il bisogno, come concetto della totalizzazione dell’Io, il desiderio, come categoria dell’azione appropriativa, e il narcisismo, come idea della rimozione della singolarità estrinseca a favore del dominio esclusivo dell’individualità accentratrice, unico principio di conduzione e condizione fenomenica del soggetto. L’istituzione filosofica, la facoltà che ne realizza gli apparati di gestione e controllo, diviene per conseguenza non “organismo di legge”, ma “impresa”, investimento possidente per ricavare proprietà in uno scenario di conflitto tra possessori autocentrati. Le guerre che questo provoca, i tagli che ne scaturiscono, e le risposte che cercano di controbattere contendendo posizione per posizione, credo siano al centro di questo incontro, e ne assembleranno la parola.
ROSELLA CORDA: Da dove si inizia? È spesso una domanda occasionata a partire da un imbarazzo di relazione. Capita talvolta, per esempio, quando ci si sente toccati da qualcosa che, nel suo rivolgersi a noi, ha già prodotto l’esitazione di un’interpellazione, rispetto a cui, chiamati a replicare, non sappiamo esattamente come comportarci. Maggiore è l’effetto toccante della condizione di essere toccati, minore è la capacità di pronta risposta. Un’interdizione è il preliminare di un inizio. O meglio, trattandosi di una condizione di incertezza rispetto a una variazione di stato, questa domanda sull’inizio, che fa problema, è già una risposta al dato grossolano e pulviscolare insieme, di un incidente affettivo – o di una incisione affettiva. L’interferenza e l’incrocio, l’attraversamento che intercetta, l’ostacolo segnato nell’istante – tremendamente qualsiasi e privo di uno statuto e di una veste, ancora troppo “nudo” – costituisce l’antecedente illogico di un inizio, che quando inizia è già risposta – retrospezione.
Sicché, paradossalmente, quando ci si trova a parlare di “inizio”, si è spesso alla fine. Bisognerebbe forse dire: da dove abbiamo iniziato, con tono di stupore e di meraviglia o con piglio polemico del tipo: non t’avessi mai incontrato! Da dove si inizia. Risponderei: da qualcosa che ci tocca, che ci prende, che ci ri-guarda. E non nei termini di un già noto episodio, ricordato come un fatto risolto, pacifico, da rimodulare in facili retoriche; bensì nei termini di quella originaria, ahimé quasi sempre “maledetta”, interdizione all’azione abituale: riprendere la parola da balbuzienti. Tentare la parola perché tentati dagli/negli affetti. Alterazioni inaggirabili e moltiplicate per piani paralleli: una parola tentata procede per la sua via di richiami ad altre parole forse più stabili, meno improvvisate, più docili. Così come, per altre carni, un affetto rivolto, simile a una zolla di terra rivoltata, richiama per sé affetti più sodi, di presa più facile.
Si parla dell’inizio e spesso le parole sono tracce di cenere, di fuochi sacri ormai spenti. Si parla dell’inizio e le parole cospargono di cenere l’iniziabile che si annida nell’inizio. Certo, allora si parla da morti e di morte. Si parla del niente in quanto niente. Si fa del nulla – portandolo in processione come un santo (o un santone, se nulla-zombie), rivestito da sincretismi più o meno stratificati e pittoreschi. Si tratta di inizi altisonanti, in genere commemorazioni pubbliche, perfino spudorate, e non rimemorazioni a uso privato, riservato, sobrio ed emozionato.
Dell’inizio - però. Non della fine.
Si parla dell’inizio laddove l’inizio è nel non-appena dell’iniziabile e dunque quello scarto dall’infarto dell’incontro è terra che sfugge da sotto ai piedi. Si corre e si rincorre, e il percorso rimane tanto più incommensurabile quanto più le distanze sono minute, piccole, brevi. È vivo il materiale dell’inizio. E una retrospezione in rima a questa vita – rima sgranata – non segna mai la fine come non può segnare un inizio che non sia anche un iniziato: un avviato-a, un toccato – forse anche un poco folle, fuori di un senno scaduto – rispetto all’iniziabile.
Da dove inizio? Da una piccola cosa che ho a cuore e che mi ha nel cuore – sembra una corrispondenza di reciprocità e in vero si è sempre più d’uno, direi si è sempre smezzati nella condizione del problema dell’inizio, e fra multipli “frazionari”. Si è sempre “comunità” (uso prudenza): ma in comune circola una differenza, quella scintilla che accende e scalda e ravviva la vicinanza, la prossimità. Il comune è istigato, molestato, perfino tormentato dai suoi intimi scarti. Disappartenenze essenziali al comune relazionale che fa dell’inizio un problema: un problema aperto. E della domanda, appunto, una domanda strategica e non ideologica: che fare? Come agire. Si pensa a una risposta come a una soluzione tattica. Parto da qui e vado lì: e sono nel mezzo. Nel mezzo di un grande casino che mi tocca da tutti i lati, mi comprime, mi tasta, mi situaziona, e che ho necessità di dominare. Faccio una mappa. Definisco direzioni. Mi oriento a cartografare. Le parole sono indicative di dove si vuole andare e come si vuole procedere. Sono la configurazione di un impegno reale, vivo, motivato. Sono nel mezzo e dunque devo capire come muovermi muovendo cosa. Da soggetto all’inizio, “iniziato”, devo farmi soggetto che inizia e per far ciò si ha bisogno, continuamente, di tutta la propria capacità inventiva, di tutta la positività di cui il proprio profilo porta le millesimali orme e cicatrici, di tutte le risorse che abbiamo, di tutta la virtualità, la forza, l’energia di cui siamo capaci. È necessario: produrre forme di vita per vivere, in una biochimica immunitaria il cui comando in contrappunto si articola in attuazioni di senso antropo-poietiche.
Si inizia un poco alla volta, un poco per uno, un poco divisi. Entrambi, io e te, leggevamo che si inizia tra-due. E sappiamo che non si alludeva all’impossibilità dell’inizio. Anzi. Si scavava talmente in quel frattempo incendiario dell’inizio, a velocità sicuramente disumane, che se ne rivoltavano le condizioni contro se stesse in un reset radicale, rispetto a cui non si può non riprendere, appunto, l’avvio.
Tu mi dicevi del trascendentale.
E mi torna alla mente un motivo: “l’inconscio è orfano”. Detto tra amici, a proposito dell’inizio. Quanto e di cosa vogliamo popolare ciò che è in produzione, in combustione? Il fuoco o si alimenta o si spegne. Mantenerlo è alimentarlo. Dalla parte del fuoco si è prima orfani e poi si genera un padre – riconoscimento dissimmetrico. Il figlio genera/costruisce il padre: ed è simultanea produzione differenziale. Ma non si smette di alimentare la fabbrica del fuoco, se non nella morte – che del resto è solo un ulteriore passaggio di stato. Insomma, sappiamo bene, non c’è fine come non c’è inizio, se dobbiamo immaginarli come stazioni di un rullo cosmico del tempo omogeneo; e sappiamo che le condizioni a priori, da rinvenire in ragione della posizione di una questione, non si danno se non alla luce di singolarità sparpagliate e non soggetti presupposti che vanno, infine, a nullificare e vanificare qualunque teoresi autenticamente ispirata al trascendentalismo.
Dell’illuminismo, oggi, vale ancora la pena rinnovare l’impulso (alla piena affermazione); ma questo è tanto più praticabile se si farà tesoro di una lezione, variamente composta, venuta dopo e presente nei nostri reciproci richiami. Così come oggi è necessario ribadire con forza che pensare è un’azione: l’ordine teoretico e l’ordine etico, pur essendo distinti, significano per momenti diversi quella stessa risposta di produzione di senso implicata nell’inizio. Necessità di un’emancipazione del soggetto dal Soggetto: del plurale dall’Unico.
Le nostrane cronache politiche (o dissimulazione del tale e quale show per ogni parte identica all’altra) sono state sature di echi di cadute e decadenze. Il pensiero come azione si prefigge un impegno, a partire dall’inizio. Questo impegno, al di là di assoggettabili militanze, non è arruolabile e non arruola. L’impegno, allora, è nel cartografare le risorse necessarie a diagnosticare quegli arroccamenti di potere che inficiano la crescita, lo sviluppo, la realizzazione di “affetti di gioia” – ci potrebbe piacere di ricordare.
Non ci placa l’abbattimento di un simbolo, così come si è orfani nell’inconscio.
Non ci placa l’ideale di una rivoluzione futuribile. Né ci soddisfa la necrofagia della violenza. Gli spiriti malati ammalano – è la loro prerogativa. Un loro bacio è morso di un vampiro. Non si alimenteranno “affetti-tristi”. Si lavora piuttosto alle più piccole svolte, alla pratica del senso da sismografi del potere e degli affetti da non arrestare ma da liberare. Si lavora per produrre orizzontalità, pluralità, perché da sempre e ovunque il Potere irreggimenta nella sua propria produzione di verità, pesando e pestando i corpi come fossero sassi, per farne un niente polverizzabile e riutilizzabile.
Sicché la vedo ardua.
Qui si vuole iniziare quello che sempre ricomincia. Si vuole istituire il pensiero sempre d’accapo, laddove viene continuamente destituito. Diciamo che si vuole rilanciare ciò che infine vuole riposare afflosciandosi su di sé, ricadendo in pose artefatte. Forse è una lotta contro se stessi: vincere le trappole del proprio particolare risentimento invalidante. Contro il proprio stesso bisogno di fermarsi e cercare riparo. Contro la propria stessa vocazione all’illibertà. Ma quando una condizione esistenziale vibra inesorabilmente, la corsa può essere arrestata solo dall’ultimo cattivo incontro – eppure, si tratterà in ogni caso di un passaggio di consegne. Seminare per contagio, dunque e ovunque, la vitalità di quel sapere aude in rima a cosa può un corpo.
ALDO PARDI: In questa deviazione che ha scomposto lo stato ci siamo dunque trovati a derivare rimbalzando dall’inizio. Un rinvenire di movimenti s’intrica stacco per stacco e segue. Questa è la parabola, è porta con le sé le impulsioni del peso che le ha condotte a sbilanciarsi insieme. La traiettoria porta la gravità dei suoi problemi. Nel nostro caso, per me, sono domande in sospensione. Questioni non occasionali né ondivaghe, ma centrate propriamente nell’in-clinazione preliminare da cui hanno mosso. La consistenza che dà loro forza sta nel dominio di cui sono parte: parliamo di pensiero e di configurazioni di pensiero. La direzione dell’intrico è data dalle problematiche che fanno la loro disposizione specifica. Faccio io da pressione movente, e ti pongo delle domande. Il pensiero e la filosofia attivano compagini avverse. Riprendendo un’asserzione spinoziana, il pensiero è estrinseco a resezioni normative, e a totalizzazioni a forma piramidale. Ancora, e soprattutto in Italia, la filosofia domina il pensiero, sia rimuovendolo, sia combattendolo. Severino e Agamben sono i portatori eccellenti di un posizionamento imperativo e dispotico del filosofare, che ha i suoi apparati di comando in schiere universitarie dalle tendenze distinte ma alla fine solidali: dal cattolicesimo heideggerista, all’agostinianesimo tomista kantiano, all’hegelismo dialettizzante e spiritualista del caleidoscopio di frazioni marxisteggianti. Potremmo discutere su come tutte queste postazioni non siano che epigone di un pervicace crocianesimo che è il vero inconscio teorico dell’accademia filosofica italiana, e non solo. Potremmo analizzarne le manovre, tra glossa anodina e commentario pedante. Ma qui ora, la questione ci porta a scorrere alla ragione del suo prodursi: negli interstizi laschi e nelle zone estranee della filosofia, si compongono segmenti di pensiero. Ma che traiettorie, e per quali modalità di costruzione, assumono? Dove avvengono secessioni, in che direzioni si tendono? Che assetti e che diagrammi tracciano?
Uno spostamento in secessione non accade senza rottura. Da circa 60 anni, a parte pochissime eccezioni, al di là del loro orientamento, e sempre pressoché emarginate dalla vulgata ufficiale – Costanzo Preve, Nicola Massimo De Feo, Gianfranco La Grassa, per non citarne che tre – la filosofia dominante esercita un potere diretto attraverso i dispositivi di gestione, controllo e riproduzione del sapere di cui possiede l’imperio. La filosofia si distende, diversa e contigua, sui poteri prevalenti nella nostra condizione socio - storica schierandosi in ordinamento di comando: filosofia è “facoltà”. Faccio chiaramente riferimento a una famosa analisi di Derrida sull’uni-versità, distorta da Rovatti. in apologia del sapere “critico” e “aperto”, nel senso liberale di potestà individualistica sul “proprio” intelletto. Ti domando, già scostato dal tuo spostarsi per la questione che ritorna anche su di me come moto d’interrogazione, dov’è che la produzione del pensare in scissione attacca e lacera l’istituto dominatore che ne governa il contesto? In che modo, secondo quali spunti offensivi, “invettive” direbbe Carlo Emilio Gadda, il concetto entra in rotta con il corpo del potere filosofico e lo colpisce uscendone per aggregarsi in complessi a – categoriali, abdicando ogni proprietà normativa giudicante e le sue “facoltà”?
ROSELLA CORDA: Ritrovandoci d’accordo sul momento asimmetrico dell’inizio, il resto non può seguire se non esplicandosi da questo “fuori del dentro”. Si tratta di intrecciare linee di fuga: avvolgere nastri di forze e svolgere nastri di potere. La questione è chiara: fare e produrre pensiero non è identico al sistema filosofia nel consolidarsi della sua istituzione. Il punto è quanto di necessario si dà, in termini di sedimentazione dei tessuti di forze in potere, nel consolidarsi di una istituzione (l’istituzione non vuole morire e neanche durare, bensì conservarsi nello stesso suo ordine prestabilito) o se c’è, nell’essenza dell’istituzione, una scintilla di quel fuoco che sposterebbe più in là il gioco della staffetta dei saperi.
Che l’immanenza della linea di fuga sia stata tradita a partire da Kant e mutata in muraglia di facoltà, producendo vuoto arbitrio autoreferenziale per parti e fazioni e non autodeterminazione creativa, questo potrebbe essere un effetto e non una causa. Bisogna fare chiarezza e soprattutto capire se e come le energie buone possono rimettersi in circolo al di là di questo tramonto - compimento di una metafisica a comparti strumentali da ancien regime. Non solo per nutrire speranze di vita ma anche per assegnare di nuovo un senso a quell’impegno di cui si diceva: l’impegno integrale di un intellettuale che rinasca dalle ceneri di un vile vassallaggio da corte (universitaria), riassumendo su di sé lo scopo di un turno di parola non orientato alla futile parcellizzazione del plurilinguismo tecnico-scientista, ma finalizzato a un dialogo aperto con il mondo. E non si tratta, qui, di prestare il fianco a scarne e pretestuose polemiche circa la presunta difficoltà di un linguaggio, quello pensato, che scoraggerebbe di per sé la partecipazione. Non c’è lingua di massa. La lingua è sempre forza sedimentata in potere. La lingua batte spesso stanca: pulsando come luce di stelle già morte. La lingua viva è differenziale, è minuta e fa la differenza. Non si avrà timore, dunque, di un linguaggio minore, pensato e forse ostico. Una profonda fiducia deve animare queste riflessioni e gli slanci che verranno. Una fiducia in una antropologia affermativa posta in quello stesso cominciamento logo-patico. Distinguendo il semplice dal facile e il sentire dal cieco soffrire , si può sfidare chi parla e chi ascolta.
Dicevamo che occorre riflettere su questo, se il contesto disciplinare della filosofia, ripartita in autorità autoreferenziali senza alcuna cogenza di reale autorevolezza intellettuale nel mondo, arroccate nelle casseforti di ricchezze già dissipate da altri, sia il destino o sia solo uno dei rigagnoli che, per falsa prospettiva, appaiono fiumi in piena. E, beninteso, non si tratterà di forzare nulla nell’ennesima prepotenza di merito – gerarchizzare, secondo una trama assiologia, un ordito di tracce, per produrre il solito canovaccio da scimmiottare (allievi come figli di un unico padre signore e padrone, per fazione). La questione è ancora e sempre: scardinare il potere. Perché se c’è un nemico del pensiero, questo è nel suo doppio di cera rappresa: il potere, il più basso grado di potenza.
Quando, allora, un soggetto istituzionale rallenta in potere? a cosa e a chi conviene questo rallentamento fino allo stallo? Si evince che dal mio punto di vista non necessariamente un’istituzione è portatrice di un negativo sottrattivo rispetto alle singolarità individuali. L’istituzione (culturale nel nostro caso), infatti, potrebbe e dovrebbe costituire un acceleratore di particelle, a partire da una ripartizione multidisciplinare, condivisa, orizzontale e interculturale dei saperi. Dovrebbe offrire, nella ridondanza della sua diversa posizione di scala rispetto al singolo (o presunto tale, parliamo sempre di “frazioni” e non di fazioni, per noi), un potenziamento delle risorse, dirigendo le forze verso la loro affermazione. Direzione delle forze è cartografia delle linee di fuga (così come si può cartografare una trama di poteri) e non immediatamente irreggimentazione statica. Più che un freno, dunque, nella sinergia che agevola mettendo in rete le energie, è un catalizzatore.
Laddove, infatti, le università funzionano, producono queste straordinarie condizioni di crescita. Dove non funzionano, invece, si continua a morire di un fading indefinito. Una costellazione di presidi di stampo feudale, dove il parlato delle lingue maggiori sussume il resto in una smorfia di scherno, ad attestare l’assoluto di posizioni la cui specificità è, invece, sempre di un peso relativo. E ci scansiamo anche da falsi movimenti come improprio terreno di confronto: non ci interessa alcun piano di scontro-confronto generazionale. Bisogna, piuttosto, intendersi sui principi e sulle dinamiche: sulle regole del gioco, aperte a tutti i concorrenti, indipendentemente dalle coordinate di provenienza. E sulle finalità responsabili di questa impresa. La crisi che viviamo, millantata, strumentalizzata in una retorica tanto sottile quanto lasciva (seduttiva fino al suicidio), è pur sempre una crisi culturale e su questo nessuno è al riparo dalla esposizione in prima linea – non ci sono seconde linee sul piano della realtà perché queste sussistono solo negli indietreggiamenti dissimulatorii di quelle metafisiche ipocrite di cui sopra: ognuno il suo orticello.
La prima linea è nell’incontro con l’altro e nella occasione di riflettere e lavorare insieme che già questo offre, nella sua piccola incidenza, come nel nostro caso.
ALDO PARDI: Non c’é una richiesta di speranza, da individui da una parte reclamanti un diritto che si fa natura prima e dall’altra latori di una esigenza di garanzia, nel domandare all’istituzione di scindersi tra gestione e controllo – come una sorta di anima decaduta o determinazione maligna - , e promozione e inclusione? Eppure, un’istituzione funziona attraverso entrambi questi snodi di accorpamento. L’università, le sue facoltà, sono dispositivi istituzionali: non solo svolgono funzioni giuridiche, ma soprattutto di governo. Da una parte l’istituzione delibera: esercita azioni di organizzazione, gestione, controllo. Dall’altra, pone le regole e i principi che ne conducono le procedure interne: stabilisce e ingiunge norme alla sua compagine e ai membri che la compongono. In entrambe queste azioni, un’istituzione si stabilisce secondo due coordinate d’attivazione: incorporazione ordinante degli elementi di cui costituisce il contesto e l’orizzonte pragmatico; totalizzazione della forma delle relazioni che ne pongono la specifica configurazione. Un’istituzione stabilisce un sistema di bisogno che chiama l’intenzione, un ventaglio di “desideri”, rendendo fine dell’applicazione la conferma e la ripetizione della sua architettura. Un’istituzione si estrinseca in facoltà, cioè ponendo e sostenendolo un dominio di possibilità, e facendone, potenzialmente all’infinito in quanto valido per ogni funzione ed elemento, il processo giudicante motivante il gesto. Per questo l’istituzione è sintesi posizionale e imperativo tetico. L’istituzione si avvale del sovrano arbitrio di dettare dati di fatto, cioè di condurre la verità ad esistere, e di farne le determinazioni a priori di una universale volontà di reale, cioè di forma e materia dell’intenzione. Se mai può esistere un’entità “desiderante”, questa è l’istituzione, poiché è sempre Soggetto che si trascende verso il mondo che si figura nelle sue devoluzioni intrinseche.
L’istituzione colloca un ordine accorpando parti per inglobamento. Questo significa esercizio di direzione e capacità di assoggettamento. Significa avere il potere di appropriarsi di parti per farne funzioni di proprietà: fattori di uso, rendimento e beneficio da cui l’organismo nel suo complesso si assicura biologicamente la sopravvivenza. Questo, secondo quanto ben definito da Deleuze, è sussistere come dispositivo. L’istituzione è un dispositivo. Dispone dei segmenti subordinati per riprodurre assoggettamento, ne conforma le declinazioni, ne uniforma le linee e i presupposti, fino ad amministrare la superficie sensibile in cui l’epidermide si elettrizza nello sfregamento con le cose. L’istituzione è regolamentazione, canone pragmatico e affabulazione dell’immaginario. L’immaginazione sogna, pensa, agisce nei suoi membri. Non lo fa come entità separata. L’istituzione non è un contenitore astratto, esterno ai suoi membri e vacuo in sé. L’ordinamento del possibile, secondo le connotazioni poste dalla diversità delle sue materie, è effetto di un potere. Il potere è la facoltà sintetica su cui s’innestano tutte le altre, nel complesso efficace di un apparato. Per questo ha come predicato essenziale la gerarchia. L’istituzione è potere, capacità sovrana di comando. Un ordine non viene dal nulla. Implica la massa severa e crudele di un braccio che prende o colpisce, e il volto altero che minaccia o corrompe. È sempre una o più parti prevalenti che, vincendo un conflitto, costituiscono una formazione sociale. Un’istituzioni non esiste senza padroni. Questa padronanza che è costituzione di un regime fa dell’istituzione un’entità statuale, corpo di Stato e organo amministrativo. “Facoltà” è dunque l’altro nome dei titoli, delle condizioni e delle potestà di un dominio: fazioni che sussumono fazioni occupandone lo spazio e sottomettendolo alla loro autorità. È vero, come dici, che la deriva della facoltà è un effetto. Ma non di una successiva degenerazione che ha corrotto una pratica prima intatta nella sua purezza. È che l’istituzione che sia la polis, o il feudo, il comune medioevale o la monarchia, la schola o l’università, si compone sulla specificità, sulla determinatezza di un incontro tra componenti sociali, che dal loro confronto vanno a disporre una determinata morfologia della dominanza. Kant non ha fatto altro che codificare, riprendendo ed estendendo un gesto cartesiano, l’infinita attitudine normativa e governamentale della soggettività, definendone gli uffici e le loro forme legislatrici: le facoltà, appunto.
Con la modernità il carattere d’ingiunzione tetica, soggettivamente dispotica della facoltà è andato estendendo la sua presa. Non è un caso che questa affermazione sia stata teorizzata agli albori dello Stato moderno, da Machiavelli, e poi pienamente definita in termini di trascendenza di una capacità d’ingiunzione prima da Hobbes, e poi, rispetto alla centralità della funzione di universale “messa a norma”, da Kant. Sono astrazioni, tutte queste, indubbiamente. Un’as-trazione sfugge il vissuto. Non lo nega, s’istalla altrove. La ricognizione dell’imporsi forzoso dell’istituzione è un movimento avverso: rifiutandosi al potere, separa un fronte e ne incide il corso, spingendo le fazioni a farsi riconoscere. In qualunque modo si sia dato, anch’esso frutto di conflitti e perciò di congiunture, questa scissione – che nulla a che fare con alcuna “riap-propriazione” o richiesta di “diritto” - , identifica un apparato nei suoi termini di dominanza. Una secessione nella teoria demarca fazioni teoriche. Nella istituzione filosofica italiana esse sono comandate da dispositivi totalitari che fanno capo al cattolicesimo liberale, al liberalismo pragmatista, all’hegelismo destinale, all’efficientismo epistemologico, al moralismo laico e all’onnipotenza desiderante. In ognuna di queste frazioni le categorie di “soggetto”, “sog- gettivazione” e legalità soggettiva stanno alla testa: la lettura trascendente - distorta - di Heidegger e l’uso della fenomenologia sono appunto il breviario filosofico che celebra le liturgie universitarie della chiesa del Soggetto. Allo stesso modo, in quanto vertici di un istituto di governo, come “facoltà” esse s’impongono ai “soggetti” governati come regime del pensiero e strumentario dell’azione. Nelle “facoltà” universitarie non s’insegna nulla, né si “ricerca”, in senso rigoroso: si applica un principio di obbedienza conforme su cui vigila la polizia del pensiero e della parola. Questo dispositivo di sussunzione è la ragione di sussistenza della facoltà. Non prevede spazi di libero pensiero nei suoi stessi presupposti. Per questo non si tratta di recuperarlo a una disponibilità alla circolazione di idee ed esperienze. Nel momento in cui il pensiero agisce come apparato istituzionale, già lì è in atto un comando e un interdetto. Ciò che nelle università si chiede è di “essere conformi”, cioè di dare prova di obbedienza e rispetto. Né basta riportare tutto questo ai “professori”, magari ordinari, distribuendo responsabilità POLITICHE secondo i gradini della gerarchia. In questo senso, come dicono molte vulgate d’impronta marxista, lo studente sarebbe la parte esterna, poiché esterno e estrinseco al potere, dell’apparato universitario: una mente vergine qualificata per questo dalla purezza dei suoi intendimenti. Non è così. Tutte le componenti prese in un organismo di comando partecipano alla sua riproduzione. Quello che si vede accadere nei dipartimenti, il servilismo, la prostituzione, l’ipocrisia, la miseria di un sapere ingurgitato come un comandamento o un decalogo, non sono altro che fenomeni di una generale pragmatica del dominio. La totalizzazione dell’istituzione detta modalità e compiti a ognuna delle sue sezioni, differenziandoli per funzione, non per finalità. E questa organizzazione non è a sua volta distinta dal contesto generale in cui l’istituzione prende posto accanto ad altre istituzioni, con i cui elementi dominanti stringe rapporti di alleanza così da instaurare i poteri in una compagine complessiva. Anche tra sezioni dominanti esistono relazioni gerarchiche, che li dividono in diverse capacità di determinazione strutturale. I contenuti totalizzanti del pensiero stanno al fianco, in questa congiuntura, della totalizzazione dominante l’università come le altre istituzioni: la prevalenza dei processi di riproduzione del capitale globalizzato. Il pensiero lavora, come pensiero, per un’università-impresa. Il pensiero, non come funzione direttamente economica, ma come teoria, agisce per sottomettere idee a un ordine di comando con a capo il Soggetto. Il termine che nel pensiero una secessione si è data, a mio parere, è quando una stringa concettuale, svincolata per una falla nell’apparato o per una rottura verificatasi in seguito a un qualsiasi urto, si connette e lavora in senso estraneo e avversativo al discorso al comando. Questo significa pensare “altro”, disporre il pensiero in un “altro” modo – che poi è un pezzo della ricerca su cui si sono confrontati Deleuze e Derrida – e, soprattutto, sfuggire alla sintesi mettendo al centro il darsi all’“altro”. Al chiacchiericcio dotto e supponente dell’istituzione, sempre assertoria e dogmatica nel suo eterno blaterare, far prevalere l’ascolto, proprio per le sue capacità svianti, squilibranti, trasformative, che spingono il concetto in basso, nel piano degli incroci tra eguali dove il pensiero costruisce deviando, invece che elevarsi in linea verticale per svettare, soggetto supremo, sulle schiere dei “soggetti”.
Restano comunque molte cose da chiarire: cosa significa, specificamente, esercitare una “scissione”? Tu parlavi di “via di fuga”: ma siamo sicuri che il semplice star fuori l’istituzione non sia in fondo un riconoscerne la potenza assoluta? Un pensiero che lavora secessione, effetto di rotture, non è di per sé una frazione combattente che avversa una forza di comando nel momento stesso in cui costruisce un organismo pensante del tutto diverso? E se questo è lo schema generico di un pensiero straniero, quali ne sono le proprietà? Sempre se possiamo dirci d’accordo, naturalmente.
Rosella Corda: Partire dall’inizio, così come si è fatto, rischiara su di un’assunzione teorica preliminare e determinante: l’empirismo radicale e la sua declinazione in empirismo tra- scendentale, proprio secondo la lezione impartita da Deleuze.
A seguito di questa assunzione, emerge una prima decisiva questione: non c’è già un soggetto, e tuttavia è falso ammettere che non ci sia niente. La grana delle potenze, la risoluzione di immagine a livello della contiguità variante degli affetti, bene rende la pseudo idea di una virtualità positiva in produzione e profusione. Il passaggio problematico, se accettiamo queste premesse, inerisce la degradazione della potenza in potere e non la resistenza a un potere dato in forza di un soggetto presupposto – ed è questo il secondo e più centrale rilievo, rispetto al nostro discorso. In questo momento viene a manifestarsi quale sia il paradigma di riferimento per pensare il problema delle istituzioni. Siamo posti di fronte un bivio teorico. Accettata questa premessa, l’alternativa di un bisogno-del-soggetto è essenzialmente esclusa, a meno che non la si voglia intendere, come a breve dirò, in quanto dissimulazione disonesta; al contrario, risulta evidente come si configuri una materia desiderante-il-soggetto. Il taglio vivente delle forze non può che delineare delle incurvature, delle piegature che segnano e consegnano delle emergenze. La virtualità precipita in soggetto: precipita più soggetti. Tanti per quanti tagli interessati si possono produrre. Questa pluralità di soggetti che tengono e tendono alla propria tenuta, al limite si identificano nella propria differenza (di potenziale) volendo vivere, sono resistenze prima di cifra eccedente-affermativa e poi, in rimando e ricezione, di cifra negativa. Si tratta, dunque, di soggetti diversi: in conflitto perché in immediata relazione differenziale. Sulla soglia della presenza si affacciano costellazioni di coaguli identitari in movimento. Identità che è l’effetto critico di una autopercezione differenziale. La chimica degli affetti, il sostrato dei vissuti, ha le sue velocità: accelerazioni e lentezze. Maggiore è l’eccitazione-eccitabilità della materia desiderante del soggetto, maggiore è la sua velocità e, al limite, la sua inafferrabilità per se stesso; viceversa, man mano che si produce un rallentamento della vitalità, si produce una degradazione della potenza in potere. Il potere vuole se stesso: conservarsi nel suo fading indefinito, vivere nella crepa della sua morte immortale. Il potere resiste di quella resistenza che la potenza non conosce. Al modo di un qualunque soggetto, l’istituzione, che è complessifizazione del desiderio di soggetto del desiderio di soggetto (individuale), partecipa a questo destino. Si percepisce luce di stelle ormai morte: così talvolta si parla (sebbene in maniera pertinente e analitica) di istituzioni da tempo consumate dal loro stesso declino. Si scarifica la luce e si misconosce una questione fondamentale: non si resiste contro un’istituzione morta, non si resiste contro il potere. Si milita, piuttosto, per la potenza: si lavora per la produzione del nuovo. Questa l’anima del costruttivismo. Resistere contro il potere comporta una dinamica sostanziale di mistificazione: farsi assorbire in quelle logiche di rallentamento e assoggettamento proprie di una traduzione del desiderio in bisogno e della ricchezza della virtualità in un nulla omogeneo, tanto mortifero quanto gestibile – dissimulazione disonesta esercitata dal potere per mantenersi saldo, dando luogo a un divenire-zombie di contagio. Il punto non è stare fisicamente dentro o fuori: il punto è il profilo di una postura etica, ovvero alimentare il massimo fuori del dentro, la linea di fuga appunto, a qualunque latitudine esistenziale ed esistentiva. Esercitare lo scardinamento interiore disciplinando quello che Borges chiamava il labirinto peggiore (in linea retta), la rima di un tempo che non ritorna, destabilizza ma certamente non annoda e strozza.
Spesso le istituzioni hanno finito da molto di corrispondere a quelle velocità desideranti da cui hanno pur tuttavia tratto origine; sicché, invece di facilitare e sollevare, esonerare dal continuo dover inventare soluzioni di soddisfacimento, diventano ostacolo. Si traduce il sollevare nella seduzione finalizzata al dominio (come l’istituzione ipostatizzata di «Uomo» è stata mortifera per l’uomo stesso). Per intenderci, potremmo concepire questi due momenti di vita e di morte delle istituzioni (tra potenza e potere) come le due modalità di lettura della volontà di potenza nietzscheana: una volta in senso deleuziano, in quanto volontà differenziale e vivente; una volta in senso heideggeriano, secondo il vessillo del negativo e della morte, in quanto volontà per lo stesso, per la ripetizione annichilente.
Il potere, dunque, va combattuto alimentando la potenza: producendo altro che, di conseguenza, distrugga l’inadeguato. Rispetto alla seduzione-trappola di un sollevarsi dall’onere della potenza alienandosi nel riconoscimento concesso dal potere (e svilirsi morendo con esso), superare questa dialettica da servi per riappropriarsi della dialettica di un superamento affermativo.
|
Note
bio-bibliografiche:
Aldo Pardi (Perugia), vive e lavora a Parigi. Attualmente collabora con il Dipartimento di italianistica della facoltà di Lingue Romanze, Slave e Orientali dell’Université de Lille III. Traduttore e saggista, ha curato, tra gli altri, la traduzione di Sulla filosofia, di Louis Althusser (Milano, Unicopli, 2001), Sui concetti fondamentali del materialismo storico, di Etienne Balibar (in Leggere il Capitale, a cura di Maria Turchetto, Milano, Mimesis 2006), Che cosa può un corpo. Lezioni su Spinoza, di Gilles Deleuze (Verona, Ombre Corte 2007), Discorso sul colonialismo. Seguito da discorso sulla negritudine, di Aimé Cèsar (Verona, Ombre Corte, 2010), Scritti su Spinoza, di Alexander Mathéron (Milano, Ghibli, 2009), Giorni di lettura (Firenze, Clinamen, 2014). Ha pubblicato, Il sintomo e la rivoluzione. Georges Politzer crocevia tra due epoche (Roma, Manifestolibri 2007), Campo di battaglia. Produzione, trasformazione e conflitto in Louis Althusser (Ombre Corte 2008), Dieci colpi di martello. Per una filosofia politica del conflitto (Ombre Corte 2009). È autore di tre raccolte poetiche. La prima, intitolata Il cervello e i nervi, è uscita nel 2000 per le edizioni Paideia di Firenze, a cui hanno fatto seguito, La forza di aspettare, Roma, Progetto Cultura 2010, e Passages, Roma, Progetto Cultura 2012. Rosella Corda (Potenza) collabora come “Cultore della materia” per la cattedra di Antropologia Filosofica dell’Unibas e ha conseguito il dottorato in Filosofia, presso l’Università degli Studi di Bari, con una tesi sul tema della libertà in Gilles Deleuze. Ha pubblicato saggi e brevi articoli inerenti la filosofia contemporanea e l’estetica.
Note:
[1] http://www.humanamente.eu/PDF/Issue12_Paper_Fadini.pdf[1] Fabio Treppiedi: http://www.psychodreamtheater.org/rivista-passparnous-x---sezione-filosofia---alphaville-ldquodifferenti-ripetizionirdquo-una-conversazione-su-deleuze-con-fabio-treppiedi---di-silverio-zanobetti---di-viviana-vacca.html [2] A. Pardi, Dieci colpi di martello, Ombre Corte, 2009, p. 177. [3] «È a questo punto che si passa dal diritto alla politica. Col Maggio ‘68, nella misura in cui prendevo contatto con problemi precisi, grazie a Guattari, a Foucault, a Elie Sambar, ho attuato per mio conto una sorta di passaggio alla politica. L’ anti-Edipo è stato, da cima a fondo, un libro di filosofia politica» in G. Deleuze, Pourparler, Quodlibet, 2000, Macerata. [4] U. Fadini, Il movimento nelle istituzioni. Una riflessione critica politica e istituzioni, Ass. Eterotopia, Milano, 2012, pp. 7-8. [5] U. Fadini, Il futuro incerto. Soggetti e istituzioni nella metamorfosi del contemporaneo, Ombre Corte, Verona, 2013. [6] C. Landolfi, Deleuze e l’interiorità interiorizzata. Ordine e obbedienze nella cornice statale, in Millepiani, Politica e istituzioni. Per una filosofia in divenire, cit. p. 42. [7] Aa.vv in Millepiani, Politica e istituzioni. Per una filosofia in divenire, cit., p. 5. |
Aldo Pardi e
Rosella Corda |
|
Le Rubriche di Alphaville
|
Scrivono nella rivista: .
Aldo Pardi, Nicola Lonzi, Marco Bachini, Daniel Montigiani, Viviana Vacca, Alessandro Rizzo, Fabio Treppiedi, Silverio Zanobetti, Sara Maddalena, Daniele Vergni, Mariella Soldo, Martina Lo Conte, Fabiana Lupo, Roberto Zanata, Bruno Maderna, Alessia Messina, Silvia Migliaccio, Alessio Mida, Natalia Anzalone, Miso Rasic, Mohamed Khayat, Pietro Camarda, Tommaso Dati, Enrico Ratti, Ilaria Palomba, Davide Faraon, Martina Tempestini, Fabio Milazzo, Rosella Corda, Marco Fioramanti, Matteo Aurelio, Enrico Pastore, Giuseppe Bonaccorso, Rossana de Masi, Francesco Panizzo.
©Le immagini di copertina hanno tutti i diritti riservati presso Edizioni Psychodream
|
LE SEZIONI di PASSPARnous:
|
Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.
Questa rivista on-line non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornata con periodicità e non è commerciale. Non può pertanto considerarsi un prodotto di commercio editoriale, ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001.
Click here to edit.
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati