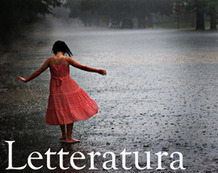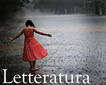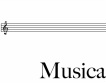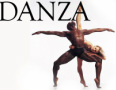Questo è ciò che lo storico e filosofo dell’arte George Didi Hubermann, sulle tracce di Walter Benjamin, sottolinea ripetutamente nei suoi libri, in particolare ne La conoscenza accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini (Bollati Boringhieri, 2011) e nel volume precedente a questo, Come le lucciole. Per una politica delle sopravvivenze (Bollati Boringhieri, 2010).
Apparire e sparire che scandiscono il ritmo di quella che, dall’essere immagine visiva - cinematografica e fotografica – come riluce da L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Benjamin, delicatamente, impercettibilmente, guizzando e scomparendo, rivela il pulsare di un’emozione condensata: che incornicia e riveste i volti e la loro memoria, quel fantasma di luce, che – benjaminianamente - appare ed emana per un breve attimo,prima di scomparire, brillando per l’ultima volta con la massima dolcezza - dai ritratti, ed il quale traspare, nella sua spettralità, dalle prime fotografie, condensandosi dentro di noi: in quanto immagine morente di un vissuto, di un’ esperienza interiore singolare e significativa – sia essa d’amore, sia essa di lutto: quell’invisibile del visibile, quel luogo di sepoltura della simultaneità cristallina di visto e vissuto: ciò che Benjamin, sempre in queste pagine, chiama “inconscio ottico”: quello spazio inconscio in cui la pupilla non coincide con l’occhio della cinepresa, lasciandoci l’estraneità del mancato incontro con noi stessi, eppure, simultaneamente, lasciandoci sprofondare in un’emozione scaturita da un campo di tensione tra interno ed esterno, emozione che, affascinandoci e sconvolgendoci contemporaneamente, non riusciamo a comunicare.
Apparire e sparire che scandiscono il ritmo di quella che, dall’essere immagine visiva - cinematografica e fotografica – come riluce da L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Benjamin, delicatamente, impercettibilmente, guizzando e scomparendo, rivela il pulsare di un’emozione condensata: che incornicia e riveste i volti e la loro memoria, quel fantasma di luce, che – benjaminianamente - appare ed emana per un breve attimo,prima di scomparire, brillando per l’ultima volta con la massima dolcezza - dai ritratti, ed il quale traspare, nella sua spettralità, dalle prime fotografie, condensandosi dentro di noi: in quanto immagine morente di un vissuto, di un’ esperienza interiore singolare e significativa – sia essa d’amore, sia essa di lutto: quell’invisibile del visibile, quel luogo di sepoltura della simultaneità cristallina di visto e vissuto: ciò che Benjamin, sempre in queste pagine, chiama “inconscio ottico”: quello spazio inconscio in cui la pupilla non coincide con l’occhio della cinepresa, lasciandoci l’estraneità del mancato incontro con noi stessi, eppure, simultaneamente, lasciandoci sprofondare in un’emozione scaturita da un campo di tensione tra interno ed esterno, emozione che, affascinandoci e sconvolgendoci contemporaneamente, non riusciamo a comunicare.
Quest’ultima sfumatura, è l’eco antropologica ed etica che risuona dalle pagine de Il Narratore di Benjamin.
Sempre in quest’opera il filosofo tedesco afferma che i più grandi narratori sono gli orientali e che un bravo narratore attinge la sua storia dal proprio vissuto.
Mi viene quindi spontaneo infilare un’altra perla a questo filo che sto cercando di seguire: i racconti dello scrittore giapponese Murakami Haruki, i cui libri sono contraddistinti da una leggerezza talmente lieve che rende l’addentrarsi nelle sue storie, il predisporsi all’attesa di un’apparizione che, fugace, andrà a perdersi quasi senza che ce ne accorgiamo nella trama del racconto: la stessa trama che costituisce il vivere di ognuno, in quanto, come scrive lo stesso Murakami nel suo ultimo capolavoro 1Q84, volume secondo: “La vita non è altro che il risultato naturale di un’assurda, e talvolta persino triviale concatenazione di eventi”.
Da ciò lo spunto per agglomerare tra loro, come fa lo stesso Benjamin nei Passages di Parigi montaggio letterario, cinematografico: cristalli di arte, poesie, letteratura, storia… dove quest’ultima non è la storia universale con la “S” maiuscola ma quella particolare, di vita, di ognuno: “l’autorità del morente”, “dell’ultimo tapino” (Benjamin, Il Narratore), quindi di colui o colei in cui rimane impressa – come in una lastra sensibile – la cenere lieve del vissuto: una perdita, una mancanza, la presenza di un assenza (direbbe Roland Barthes) che appare e scompare, la forma patetica, morente del fantasma di un vissuto che, essendo interiore, rimane dentro: emozione condensata dentro di noi come un cristallo di tempo ma che l’immagine visiva, improvvisamente – come un vortice che arresta in un fotogramma d’incanto il fluire del montaggio della vita – può far ritornare.
“Cristallo di tempo” è la poeticità con cui Gilles Deleuze nel suo libro “L’immagine-tempo” - seguito poi da “L’immagine- movimento” quale commento a “Materia e memoria” di Bergson, autore molto caro anche a Benjamin - si riferisce all’immagine cinematografica e fotografica, mostrando magistralmente come le immagini “materiali”, “esterne” dicano qualcosa delle immagini “interne” o “interiori”, rivelando così la notevolissima portata antropologica ed etica del cinema.
Dello stesso avviso è anche Didi Hubermann, il quale in Storia dell’arte e anacronismo delle immagini (Bollati Boringhieri, 2007), riguardo all’immagine dialettica benjaminiana, sottolinea come il montaggio filmico sia costituito da fotogrammi, dunque da fermo-immagini, quindi da fotografie che, antropologicamente parlando, sono quei momenti singolari e significativi, inesprimibili: il morente benjaminiano dentro di noi, la cui aura luminosa riappare e di nuovo scompare, affiora e sprofonda: apparizione che, in questo ritmo Anadiomene (se il soggetto che accompagna è Anadiomene non va la virgola tra soggetto e verbo) accompagna ogni istante della nostra vita, come il pulsare del nostro cuore e delle emozioni che esso rivela quando – amando, morendo – lo mettiamo a nudo.
Per concludere si potrebbe dire che ciò che l’immagine visiva lascia rilucere, è l’eco profondo in noi del nostro vivere: lo sprofondare nelle emozioni che fanno arrestare d’improvviso la trama di immagini della nostra vita, emozioni che cristallizzano così le tensioni del vivere, in scintille di luce singolari e significative: fotografie di attimi che andranno perdendosi dentro di noi, ma che resteranno sepolti e conservati, come cristalli estratti dalla terra, per portarli ancora grezzi alla nostra memoria, ritornando poi come prismi luminosi, ad illuminare improvvisamente, anche solo con lievi bagliori, la nostra notte di disperazione.
Sempre in quest’opera il filosofo tedesco afferma che i più grandi narratori sono gli orientali e che un bravo narratore attinge la sua storia dal proprio vissuto.
Mi viene quindi spontaneo infilare un’altra perla a questo filo che sto cercando di seguire: i racconti dello scrittore giapponese Murakami Haruki, i cui libri sono contraddistinti da una leggerezza talmente lieve che rende l’addentrarsi nelle sue storie, il predisporsi all’attesa di un’apparizione che, fugace, andrà a perdersi quasi senza che ce ne accorgiamo nella trama del racconto: la stessa trama che costituisce il vivere di ognuno, in quanto, come scrive lo stesso Murakami nel suo ultimo capolavoro 1Q84, volume secondo: “La vita non è altro che il risultato naturale di un’assurda, e talvolta persino triviale concatenazione di eventi”.
Da ciò lo spunto per agglomerare tra loro, come fa lo stesso Benjamin nei Passages di Parigi montaggio letterario, cinematografico: cristalli di arte, poesie, letteratura, storia… dove quest’ultima non è la storia universale con la “S” maiuscola ma quella particolare, di vita, di ognuno: “l’autorità del morente”, “dell’ultimo tapino” (Benjamin, Il Narratore), quindi di colui o colei in cui rimane impressa – come in una lastra sensibile – la cenere lieve del vissuto: una perdita, una mancanza, la presenza di un assenza (direbbe Roland Barthes) che appare e scompare, la forma patetica, morente del fantasma di un vissuto che, essendo interiore, rimane dentro: emozione condensata dentro di noi come un cristallo di tempo ma che l’immagine visiva, improvvisamente – come un vortice che arresta in un fotogramma d’incanto il fluire del montaggio della vita – può far ritornare.
“Cristallo di tempo” è la poeticità con cui Gilles Deleuze nel suo libro “L’immagine-tempo” - seguito poi da “L’immagine- movimento” quale commento a “Materia e memoria” di Bergson, autore molto caro anche a Benjamin - si riferisce all’immagine cinematografica e fotografica, mostrando magistralmente come le immagini “materiali”, “esterne” dicano qualcosa delle immagini “interne” o “interiori”, rivelando così la notevolissima portata antropologica ed etica del cinema.
Dello stesso avviso è anche Didi Hubermann, il quale in Storia dell’arte e anacronismo delle immagini (Bollati Boringhieri, 2007), riguardo all’immagine dialettica benjaminiana, sottolinea come il montaggio filmico sia costituito da fotogrammi, dunque da fermo-immagini, quindi da fotografie che, antropologicamente parlando, sono quei momenti singolari e significativi, inesprimibili: il morente benjaminiano dentro di noi, la cui aura luminosa riappare e di nuovo scompare, affiora e sprofonda: apparizione che, in questo ritmo Anadiomene (se il soggetto che accompagna è Anadiomene non va la virgola tra soggetto e verbo) accompagna ogni istante della nostra vita, come il pulsare del nostro cuore e delle emozioni che esso rivela quando – amando, morendo – lo mettiamo a nudo.
Per concludere si potrebbe dire che ciò che l’immagine visiva lascia rilucere, è l’eco profondo in noi del nostro vivere: lo sprofondare nelle emozioni che fanno arrestare d’improvviso la trama di immagini della nostra vita, emozioni che cristallizzano così le tensioni del vivere, in scintille di luce singolari e significative: fotografie di attimi che andranno perdendosi dentro di noi, ma che resteranno sepolti e conservati, come cristalli estratti dalla terra, per portarli ancora grezzi alla nostra memoria, ritornando poi come prismi luminosi, ad illuminare improvvisamente, anche solo con lievi bagliori, la nostra notte di disperazione.
Silvia Migliaccio
|
|
Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati