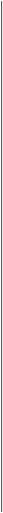|
La sua fotografia può essere definita quasi, lui stesso usa questo termine, un’indagine cartesiana, una narrazione del dato che si presenta, cosi come si rivela, agli occhi dell’autore, nella propria unicità, nella propria identità, nella propria essenzialità: stiamo parlando della produzione, varia, di Antonio Ottomanelli, ideatore della collettiva New Island, dedicata ai territori calabresi, allestita presso la Triennale di Milano. Partiamo da questo ambito per meglio comprendere la poetica e il messaggio degli scatti di Antonio, non un semplice reportage, lui prende le distanze da una categoria che rischia di essere preordinata, prefigurata, prevedibile nel percorso visivo, estetico e compositivo.
La fotografia di Antonio risulta essere ponderata, risulta avere dei tempi che non sono quelli dell’immediatezza, del cercare di carpire il momento irripetibile e unico, considerato tale, imperdibile e irripetibile: la produzione di Antonio risulta essere calibrata, attenta, riflessiva, come a riflettere sono le strutture, paesaggi e situazioni urbane, che si avvicendano, spesso in trittici o in dittici, quasi sovrapponendosi, non identificabili nel loro apparire palesandosi come soggetti non catalogabili come appartenenti a questo o a quell’altro luogo specifico, donandoci, così, un ventaglio caleidoscopico di uno sguardo e un punto di osservazione, e creazione, che va oltre all’elemento tangibile, scientifico e oggettivo. Le fotografie di Antonio parlano di architetture, lui è architetto: sono forme e linee di spazi che si connotano come parti rispondenti di un contesto, quello umano, da cui prende un significato, un alternarsi di pieni e contrappieni tali da donare, attraverso calibrate luci e ombre e attraenti tonalità chiaroscurali, elementi attinti da quel concetto di architettura che ci porta a definire una doppia lettura, temporale e culturale. Antonio narra di marginalità e lo fa accedendo a ciò che, di solito, il linguaggio ritrattistico o paesaggistico documentaristico della fotografia non riesce a garantire, non riesce a palesare, non riesce a dimostrare, non riesce a mostrare, divenendo spesso ripetitivo, molto spesso prevedibile: nella produzione dell’autore esiste una dose notevole di imprevedibilità ed è viva e vibrante in quell’inattesa visione che ci si apre in una dimensione fotografica in cui il soggetto risulta distaccato, in cui l’autore non invade e non cerca di dare letture preordinate e prestabilite ma, anzi, cerca di rimanere oggettivo, fermo nel suo obiettivo, largo campo di esposizione, aperture di diaframma e tempi utili a rendere la narrazione fotografica incisiva. In questo ambito si apre quella che lui stesso afferma essere definita come fotografia laboratorio, come continua ricerca e indagine, sociale e culturale, del dato estetico impresso: una serie lunga che ci porta a identificare i passaggi di una ripresa di questioni, che si ergono a interrogazioni rivolte all’umanità tutta, allo spettatore che si imbatte nella propria produzione artistica, una proposta compositiva a cui l’autore stesso non vuole dare delle risposte, delle soluzioni. Non sono tanto le forme architettoniche pure, quelle che non hanno un legame con il dato ‘democratico’, come lo definisce Antonio, a prevalere nelle fotografie: le strutture portano, invece, a formulare quesiti, come quei ruderi che rimangono dopo una distruzione bellica, e che diventano espressione di un vissuto e di un dato di riferimento continuo e presente nella società, inseriti in una collettività e in una comunità angariata da una tragedia come quella di un conflitto appena verificatosi. Le strutture non portano con se la visione identitaria di una documentazione fredda, di una ripresa di un’iniziativa e di un’azione, di un attacco, come quelle successioni di fotografie che ci riportano il racconto, voluto, già prefigurato, già atteso, di uno scontro a fuoco, di un confronto militare, di un attacco di fuoco: la strutture pervadono il contesto, che è contesto sociale e che solo quest’ultimo ci può dare risalto della portata sociale di forte impegno della fotografia, quel lato umano che, come filo rosso, lega e unisce un passato, un presente e ci proietta verso un futuro. L’Afghanistan è un diario umano prima che racconto di una terra lacerata: una terra che attende una trasformazione, cosi come la serie dedicata a Baghdad, una terra che è stata annullata nel suo passato, violata, offesa, ma che attende dalle ceneri, dalla distruzione, che è lato umano di un’architettura e di paesaggio, una rinascita, che può avvenire solamente cambiandosi, rigenerandosi, ripensandosi. Il pensiero di un destino proiettato su un futuro, qui la forza tutta suggestiva e il calibro di un’interrogazione che sorge, poi, a scatto ormai avvenuto, nella mente dello spettatore, cosi come in quella dell’autore, senza pretesa di esaudire il tutto con un risultato, ma lasciando aperto il lavoro di elaborazione e di riflessione su ciò che si evidenzia, si palesa, si propone con la successione delle opere. Una mappa cittadina viene rivista e rivisitata attraverso immagini che raccontano le storie e le dinamiche di una comunità, di un’umanità: il disagio, la sofferenza, la p di riscatto, la volontà di riprendere dopo una distruzione diventano espressioni visive impresse nella fotografia, dato oggettivo, ma diventano anche mappature di una nostra coscienza, comprendendo che il conflitto espresso e riportato da una terra remota, Afghanistan, Iraq, Palestina, diventa parte a noi prossima, parte di noi stessi. La dimensione umana pervade la fotografia di Antonio Ottomanelli: si pongono come emergenze certe questioni, ritratte attraverso l’impeto creativo, attraverso l’occhio oggettivo ma, non per questo, non partecipe, vigile, indagatore dell’artista, tanto da proiettarsi magicamente in una prospettiva futura, uscendo da certe categorie prestabilite. Gli spazi impressi con l’obiettivo si fanno quesiti e tramite tali interrogativi l’autore ci porta a dare una riflessione elaborativa, una sintesi linguistica e narrativa del paesaggio umano e sociale, partendo dalla distruzione, rimodellazione, ridefinizione degli spazi, ma partecipata, vissuta, avvertita come propria, come in Collateral Landscape. Alessandro Rizzo
Scrivono in PASSPARnous: k
Aldo Pardi, Nicola Lonzi, Marco Bachini, Daniel Montigiani, Viviana Vacca, Alessandro Rizzo, Fabio Treppiedi, Silverio Zanobetti, Sara Maddalena, Daniele Vergni, Mariella Soldo, Martina Lo Conte, Fabiana Lupo, Roberto Zanata, Bruno Maderna, Alessia Messina, Silvia Migliaccio, Alessio Mida, Natalia Anzalone, Miso Rasic, Mohamed Khayat, Pietro Camarda, Tommaso Dati, Enrico Ratti, Ilaria Palomba, Davide Faraon, Martina Tempestini, Fabio Milazzo, Rosella Corda, Marco Fioramanti, Matteo Aurelio, Enrico Pastore, Giuseppe Bonaccorso, Rossana De Masi, Francesco Panizzo. |
Fotografia
Un pittorialismo fotografico: l’arte di Francesco Ragno tra forme e geometrie. di Alessandro Rizzo L’art brut diventa arte grezza e
flusso di coscienza tempestoso nelle cromaticità visionarie di Marie-Claire Guyot. di Alessandro Rizzo Georg Schrimpf:
da un espressionismo di un nuovo realismo alla dimensione magica di una nuova oggettività. di Alessandro Rizzo L’immateriale nel blu immenso e universale
di Yves Klein. di Alessandro Rizzo Un esempio di architettura integrata: la Fondazione Maeght.
di Alessandro Rizzo |
|
LE ALTRE SEZIONI di PASSPARnous:
|
|
Sezione
Revue Cinema diretta da Daniel Montigiani Sezione
Trickster diretta da Alessandro Rizzo Sezione
Reportages diretta da Davide Faraon |
Sezione
Psychodream Review diretta da Enrico Pastore e Francesco Panizzo Sezione
Apparizioni diretta da Francesco Panizzo Sezione
Archivio diretta dalla redazione di PASSPARnous |
Sezione
Musikanten diretta da Roberto Zanata Sezione
Witz diretta da Sara Maddalena Sezione
Eventi diretta dalla redazione di PASSPARnous |
|
|
Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati