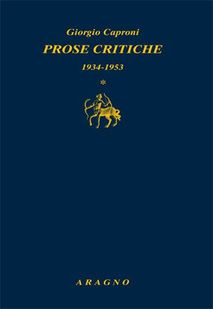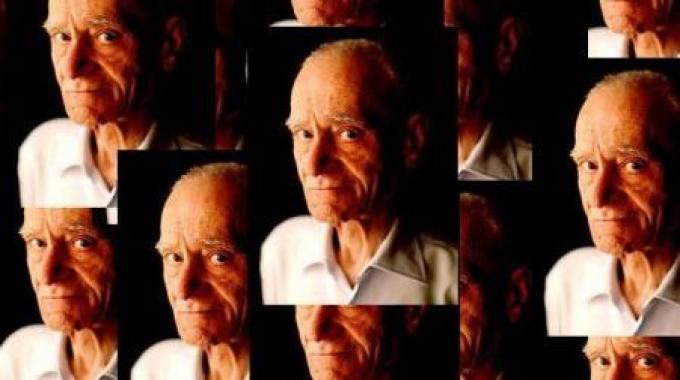Apparizioni rubrica diretta da Francesco Panizzo
|
Tra molti fiori selvaggi e pochi fiori rari Intorno a “Prose critiche” di Giorgio Caproni “Avevo salutato/ tutti, uno per uno./ Infatti non sapevo/ se sarei ritornato:/ G. Caproni, PROSE CRITICHE, 1934 –1989 (voll. 1 –4), a c. di Raffaella Scarpa; con una prefazione di Gian Luigi Beccaria, Aragno 2013.
|
Se la parola in poesia sa stare ai bordi, la scrittura diventa scarna, magra. Ai bordi del silenzio del Franco cacciatore, Il Conte di Kevenhüller e Res amissa e dell’essenziale evocazione popolare dei Versi livornesi, Giorgio Caproni rinnova lo stupore delle parole nei quattro densi volumi che raccolgono le Prose critiche, parallela vita scritta dal 1934 al 1989. Opera
dalla mole impressionante – edita da Aragno, curata da Raffaella Scarpa
e prefata da Gian Luigi Beccaria – è la storia di un poeta che scrive
di e con altri poeti. Pasolini, Montale, Gatto, Char e Salinas, il
simbolismo e le avanguardie fino a costeggiare la linea ligure
compongono la riflessione poetica di Caproni – ché di poesia, sempre, si
tratta – sospesa tra la disponibilità all’ascolto e la costruzione di
un’ecologia delle parole. Luciano Anceschi, in Specchi della poesia, ricorda
una trascurata opinione di Voltaire secondo cui una buona critica
sarebbe solo quella di un artista dotato di molta conoscenza e gusto
(«il che si dà assai di rado», sottolineava il filosofo). La critica dei
poeti è quella che più delle altre «ci aiuta a entrare nel laboratorio
del poeta proprio nel senso con cui il laboratorio stesso si
costituisce». La critica praticata dai poeti e dagli scrittori ha finito
per costituire addirittura un genere che in questi ultimi tempi sta
vivendo un suo particolare splendore, tanto che oggi la saggistica
letteraria è straordinariamente rappresentata dalle raccolte di saggi e
articoli dei nostri maggiori poeti e scrittori. Saggi e interventi di Ungaretti, Il poeta e il politico e altri saggi di Quasimodo, I viaggi e la morte e Le opere e i giorni di Gadda, Le parole preparate di Bassani, Passione e ideologia e Descrizioni di descrizioni di Pasolini, Letture preliminari di Sereni, Discorso naturale di Luzi, Fantasie di avvicinamento e Aure e disincanti di Zanzotto, Per forza e per amore di Giudici, Note in margine di Volponi. A questa lista si aggiungeva il volume garzantiano di prose critiche La scatola nera, introdotto esemplarmente da Giovanni Raboni.
La ragione di fondo risiedeva nel fatto che coloro i quali avevano potuto leggerne qualche assaggio, ne riconoscevano il grande interesse, sia per la qualità della riflessione critica sia per quella, altrettanto visibile, della prosa che viene a costituire naturaliter «gli immediati dintorni» della poesia. Quella poesia che ha il compito – difficile e rischioso – «di riscattare dal cimitero dell’abitudine, e far comprendere e amare oltre la superficie, in tutte le sue possibili corrispondenze, il reale, cioè appunto la vita veramente vissuta. Quella vita in memoria» (Le poesie sono oggetti?, in Mondo operaio, 26 marzo 1949). La “vita in memoria” della parola poetica si è rassegnata di fronte alla mancata identità tra linguaggio e realtà; e da tale rassegnazione nasce la dignità costruttiva in cui alla parola spetta il compito di generare una realtà, di esserne la prima pronuncia. Posizione concettuale questa che emerge “con la felicità sugosa e lievitante” – come vorrebbe Mario Luzi – nelle traduzioni cristalline di Caproni, a riprova dell’inesistente differenza tra il tradurre e lo scrivere poetico in quanto «se il poeta c’è senza dubbio m’aiuta, con le sue invenzioni e infedeltà, ad arrivare dove la semplice trasposizione linguistica non arriverebbe.»
Colpisce nella prosa critica di Caproni l’emergenza di uno stile della parola che contraddistingue la produzione che va da Le stanze del funicolare fino al iPassaggio di Enea del 1956: l’attenzione ritmata per il rimando e la chiusura continui – quasi a soffocare lo spazio in una forma che ritorna su se stessa – e contemporaneamente il rifiuto del viaggio inteso come costrizione in una carrozza fin troppo piccola se il movimento solitario o collettivo diventa un’ulteriore affondo verso l’ignoto. In questo frangente – nella parola poetica come nella prosa critica – al viaggiatore non resta che sottrarsi nella decorazione di uno spazio cerimonioso: il cerimoniale dell’educazione e della tolleranza sono i tratti distintivi di un lungo esercizio della sopportazione e della pazienza. “Mi piacciono i colpi a vuoto./ I soli che infallibilmente/ centrino ciò ch’enfaticamente/ viene chiamato l’Ignoto./” si legge nel testo Consolazione di Max. Ed un colpo mancato – nella selezione critica dei poeti con cui Caproni – costruisce la propria ecologia non salvifica – tradisce lo spazio libero dal bisogno – e da un soddisfacimento – e teso verso la consapevolezza di una maledizione irrinunciabile. Quella della lingua poetica e della sua incapacità mimetica di rappresentazione del Reale. La domanda heideggeriana intorno a Hoderlin – “Perché i poeti nel tempo della povertà” – non trova dignità di senso nel mondo di Caproni, poco attento, nel suo viaggio in treno fatto di istantanee solo lievemente sbiadite, ai finali e alle finalità.
“Un uomo solo,/ chiuso nella sua stanza./ Con tutte le sue ragioni./ Tutti i suoi torti./ Solo in una stanza vuota,/ a parlare. Ai morti./”. Questa la condizione del poeta e della parola nell’acido della lingua, nel dantesco “vetrone” poetico. Con Il muro della terra – raccolta del 1975 – Caproni sembra chiudere i conti con ogni possibilità di apertura. Ogni equilibrio tra ironia e elegia è risolto a favore della prima. La speranza anche solo in una risposta è mancata e sostituita dalla doppia interrogativa de Le stanze del funicolare “Che sera è mai accaduta/ Quale notte prelude?”.
La parola diventa una tagliola per orsi nella steppa siberiana: parole ghiacciate, vetrose, come nel testo la Frana: “Giorno il 14 luglio./ Anno: quello tra Il Flauto Magico,/ a Vienna, e, a Parigi, il Terrore./ In lui non il minimo errore/ di calcolo./ Anche se non esisteva,/ la Bestia c’era./ […] Ai miei occhi una frana./ La frana di un’alluvione./ La frana della ragione./” La frana era nella società, nei tempi, nelle avanguardie o neoavanguardie, sempre più rivoluzionarie e sostenute dall’ideologia dello sfondamento borghese; alla quale Caproni sin dall’inizio intimamente si sottrasse, ma di cui sin dall’inizio comprese la portata devastante e annichilente nei confronti della tradizione e della stessa possibilità di poesia. “Tra molti fiori selvaggi e pochi fiori rari” (le parole della poesia), il viaggio radiografico di Caproni nella tradizione letteraria ha i colori sbiaditi del penultimo saluto. Succede nella poesia del Congedo che dà titolo alla raccolta. Il cerimonioso viaggiatore saluta, sul treno, i suoi compagni di viaggio, si scusa per il disturbo, si rammarica di non poter godere oltre della loro ottima compagnia. Segnali sicuri avvisano il viaggiatore che l’arrivo per lui è imminente, anche se il luogo del trasferimento è del tutto ignoto. Non solo: il viaggiatore confessa persino di non conoscere “quali stazioni / precedano la mia” Prima dell’ultimo saluto (“Buon proseguimento”), a chiusura della poesia stessa, il viaggiatore proclama l’unica certezza raggiunta nel suo viaggio: “io / son giunto alla disperazione / calma, senza sgomento.” La disperazione è quella di chi si trova a vivere nello smarrimento esistenziale seguito alla violenza della guerra e al dispiegarsi alienante della modernità.
“Un uomo solo,/ chiuso nella sua stanza./ Con tutte le sue ragioni./ Tutti i suoi torti./ Solo in una stanza vuota,/ a parlare. Ai morti./”. Questa la condizione del poeta e della parola nell’acido della lingua, nel dantesco “vetrone” poetico. Con Il muro della terra – raccolta del 1975 – Caproni sembra chiudere i conti con ogni possibilità di apertura. Ogni equilibrio tra ironia e elegia è risolto a favore della prima. La speranza anche solo in una risposta è mancata e sostituita dalla doppia interrogativa de Le stanze del funicolare “Che sera è mai accaduta/ Quale notte prelude?”.
La parola diventa una tagliola per orsi nella steppa siberiana: parole ghiacciate, vetrose, come nel testo la Frana: “Giorno il 14 luglio./ Anno: quello tra Il Flauto Magico,/ a Vienna, e, a Parigi, il Terrore./ In lui non il minimo errore/ di calcolo./ Anche se non esisteva,/ la Bestia c’era./ […] Ai miei occhi una frana./ La frana di un’alluvione./ La frana della ragione./” La frana era nella società, nei tempi, nelle avanguardie o neoavanguardie, sempre più rivoluzionarie e sostenute dall’ideologia dello sfondamento borghese; alla quale Caproni sin dall’inizio intimamente si sottrasse, ma di cui sin dall’inizio comprese la portata devastante e annichilente nei confronti della tradizione e della stessa possibilità di poesia. “Tra molti fiori selvaggi e pochi fiori rari” (le parole della poesia), il viaggio radiografico di Caproni nella tradizione letteraria ha i colori sbiaditi del penultimo saluto. Succede nella poesia del Congedo che dà titolo alla raccolta. Il cerimonioso viaggiatore saluta, sul treno, i suoi compagni di viaggio, si scusa per il disturbo, si rammarica di non poter godere oltre della loro ottima compagnia. Segnali sicuri avvisano il viaggiatore che l’arrivo per lui è imminente, anche se il luogo del trasferimento è del tutto ignoto. Non solo: il viaggiatore confessa persino di non conoscere “quali stazioni / precedano la mia” Prima dell’ultimo saluto (“Buon proseguimento”), a chiusura della poesia stessa, il viaggiatore proclama l’unica certezza raggiunta nel suo viaggio: “io / son giunto alla disperazione / calma, senza sgomento.” La disperazione è quella di chi si trova a vivere nello smarrimento esistenziale seguito alla violenza della guerra e al dispiegarsi alienante della modernità.
Ma è disperazione calma, di chi non rinuncia a fare i conti con la solitudine, col deserto della vita, con la morte. A partire dal Congedo dunque, e più ancora da Il muro della terra
del 1975, che tutti concordano nel ritenere raccolte di svolte
decisive nell’opera di Caproni, il tono di fondo della voce del poeta
è, sempre più consapevolmente e con maggiore insistenza, quello di chi,
smarrite le coordinate di spazio e tempo, si trova ad essere qui e
altrove nello stesso tempo. Quella disperazione calma fa tutt’uno, con crescente lucidità, con il sentimento di disabitante del mondo. In perenne congedo.
Viviana Vacca
|
|
Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati