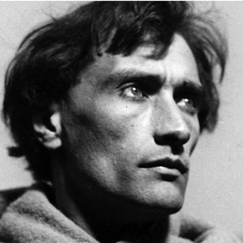|
Il teatro non è mai stato fatto per descrivere l’uomo e quello che fa, è dunque necessario risvegliare, ricostruire la vigilia di questa presunta origine del teatro occidentale. La scena teatrale è “teologica” finché resta dominata dalla parola, da una volontà di parola, dal disegno di un logos primo che non appartiene al luogo teatrale e lo dirige a distanza. |
È sempre il testo fonetico che garantisce il movimento della rappresentazione teatrale: attraverso le parole, l’Occidente, non ha mai cessato di rincorrere un movimento costante di obliterazione della scena. Se si è di fronte ad una prima volta, un arrivo dirompente, imprevisto, imprevedibile, debordante e inatteso, che spiazza, come un evento, quello della parola nell’arte, che (si) apre alle possibilità di ogni atto di creazione, si tratta di rovesciare la tirannia del testo per una “pura messa in scena”. Si configura necessaria una “levata di scena”, uno squartamento del linguaggio e del senso, fino alla sua disarticolazione e/o decomposizione, per una demolizione della finzione scenica, incrostata da identità immedesimate che, nel ruolo-attore, si precludono l’infinità dei doppi. Quando il linguaggio “viene a mancare”, muore sulla scena, sparisce, per dare e fare spazio al gesto vitale che, tra le difficoltà dei doppi e delle indefinite possibilità, entra nel ritmo della materia e del condensarsi dell’idea. Il teatro occidentale tende a non riconoscere la dignità di linguaggio se non al linguaggio articolato, grammaticalmente articolato, il linguaggio della parola, della parola scritta che, pronunciata o no, non ha più valore di quanto ne avrebbe se fosse soltanto scritta; e se ogni creazione artistica usa la parola come dimora dell’arte, la domanda da porsi è: dalla scrittura alla parola, al gesto, al pensiero, è possibile un ritorno nei limiti della lingua?
È percepibile con eccezionale intensità, fino anche a provocare un certo tipo di dolore fisico, questa fenditura che impedisce al pensiero di ritornare a sé attraverso la scrittura. Si tratta di un vero e proprio furto, paroles soufflées, credute sia proprie, espressione unica e diretta dell’interiorità profonda, sia rubate al e dal linguaggio: non c’è parola “propria”, c’è sempre più d’una parola. L’altro non ha un posto tale per cui la nostra dimora è a rischio corruzione, ma c’è sempre una capacità di ospitare una certa eccedenza! C’è sempre già più d’una lingua, nel senso non di un pluralismo linguistico, ma di un silenzio che attraversa ogni lingua come ciò che non può esserne contenuto.
È percepibile con eccezionale intensità, fino anche a provocare un certo tipo di dolore fisico, questa fenditura che impedisce al pensiero di ritornare a sé attraverso la scrittura. Si tratta di un vero e proprio furto, paroles soufflées, credute sia proprie, espressione unica e diretta dell’interiorità profonda, sia rubate al e dal linguaggio: non c’è parola “propria”, c’è sempre più d’una parola. L’altro non ha un posto tale per cui la nostra dimora è a rischio corruzione, ma c’è sempre una capacità di ospitare una certa eccedenza! C’è sempre già più d’una lingua, nel senso non di un pluralismo linguistico, ma di un silenzio che attraversa ogni lingua come ciò che non può esserne contenuto.
|
Il linguaggio ci strappa a noi stessi e ci espone all’altro!
L’esperienza della lingua, sembra articolarsi tra universalità ontologica ed empiria fenomenica, sempre in una lingua: oltre al più puro solipsismo (esprimibile nella successione: soggetto-co- scienza-io), qualcosa si erge al di là di una molteplicità ridotta ad unità, un plurisoggetto che, verificando (e depotenziando) ogni tautologia egologica (del pensiero, ect..), innesca un mec- canismo di de-identificazione a effetto domino. Facendo spazio tra sé e sé, il soggetto, trova sé stesso presso (l’)altro, la (pluri)- soggettività fa tutt’uno con un corpo senz’organi fino a rendere necessario e costituire un “soggettile” (in francese, subjectile), posto vuoto tra soggetto e oggetto che gioca la lingua non più in direzione di un senso, ma resta così tra senso e non senso, fuori senso appunto. Nell’indecisa alterità che così si impone, si affer- mano le (non)condizioni di dare forma ad un teatro della vita che, amorfo, indifferente, si declina nel darsi di tutto ciò che è, chiedendo: cosa resta? I gesti. |
Questi gesti devono essere così efficaci da fare dimenticare la necessità, tanto teorica, quanto pratica, del linguaggio parlato, che non ci suggerisce più l’idea del passaggio delle idee nelle cose, mettendo a nudo la carne della parola. La teatralità deve restaurare la carne: del teatro si dirà ciò che si dice del corpo. Il teatro afferma la vita stessa in ciò che essa ha di irrappresentabile e deve liberare la scena dall’illustrazione di un discorso, dove il suo rapporto con la parola è la sua malattia, per una messa in scena pura.
Il teatro, la sua origine, è un colpo di mano contro il detentore abusivo del logos, contro il Dio di una scena sottoposta al potere della parola. La parola ritornerà gesto: “verrà ridotta e subordinata l’intenzione ‘logica’ e dis- corsiva, attraverso la quale solitamente la parola garantisce la sua trasparenza razionale e affina il proprio corpo orientandolo verso il senso, lo lascia stranamente celare da quanto lo rende trasparente: decostruendo la trasparenza, si mette a nudo la carne della parola” (in – La scrittura e la differenza). La scrittura scenica diventa il gesto del pensiero, cominciando da sempre l’origine e sdoppiandone la sua prima volta, in una ripetizione, in un se- gno quindi. Ogni segno, infatti, non essendo mai proprio, quindi sempre sottratto al suo soggetto per sua natura, produce l’enigma originario tale per cui nulla si aggiunge ad esso ma lo costituisce. La lettera, il segno, il gesto sono sempre aperti, esposti, mai propri, confusi con il concetto, l’idea, la cosa che rappresentano: “il teatro, che non consiste in nulla, ma che si serve di tutti i linguaggi – gesti, suoni, parole, luce, grida – […] non è quale noi lo conosciamo attraverso l’aspetto esteriore dei fatti, ma il suo nucleo fragile e irrequieto, inafferrabile dalle forme” (in – Il teatro e il suo doppio). Siamo di fronte alla “chiusura della rappresentazione”, non come rappresentazione del destino ma come destino della rappresentazione: senza fine, senza fondo, in una ripetizione delle differenze che rende impossibile qualsiasi riappropriazione, aprendosi all’indefinito. Nell’iterabilità, l’alterazione, senza destina- zione certa, come una forza di rottura, permette e diviene movimento di apertura della scena stessa. Non si vuole sopprimere la parola ma cambiarne la destinazione e ridurne il suo posto, mettendone in questione le possibilità. Da lontano, ancora una volta, l’attenzione critica riservata e dovuta a tali orizzonti concettuali, non tanto per proteggere l’esistenza soggettiva, l’originalità di un opera o la singolarità del bello contro le violenze del concetto, ma, e inversamente, quando ci immettiamo in questo flusso d’analisi così profonda e sconcertante quasi, lo facciamo per spezzare ulteriormente la figura dell’unico, del completo e del perfetto che mettono le radici nelle differenze. Questo terreno, al quale ci siamo accostati anche se soltanto in forma critica, dischiude la denuncia instancabile di una esperienza di derivazione, se non di impossibilità, che non dà luogo a delle opere: l’esistenza di un artista, non è più la via o l’esperienza che danno accesso a qualcosa di diverso da sé, una avventura (ci piace designare così una totalità anteriore alla separazione della vita e dell’opera) che si rifiuta di significare, di perseguire una manifestazione di espressione e che invece si impone come una creazione pura della vita, senza mai cadere lontano dal corpo per scadere in segno o opera o oggetto.
Il teatro, la sua origine, è un colpo di mano contro il detentore abusivo del logos, contro il Dio di una scena sottoposta al potere della parola. La parola ritornerà gesto: “verrà ridotta e subordinata l’intenzione ‘logica’ e dis- corsiva, attraverso la quale solitamente la parola garantisce la sua trasparenza razionale e affina il proprio corpo orientandolo verso il senso, lo lascia stranamente celare da quanto lo rende trasparente: decostruendo la trasparenza, si mette a nudo la carne della parola” (in – La scrittura e la differenza). La scrittura scenica diventa il gesto del pensiero, cominciando da sempre l’origine e sdoppiandone la sua prima volta, in una ripetizione, in un se- gno quindi. Ogni segno, infatti, non essendo mai proprio, quindi sempre sottratto al suo soggetto per sua natura, produce l’enigma originario tale per cui nulla si aggiunge ad esso ma lo costituisce. La lettera, il segno, il gesto sono sempre aperti, esposti, mai propri, confusi con il concetto, l’idea, la cosa che rappresentano: “il teatro, che non consiste in nulla, ma che si serve di tutti i linguaggi – gesti, suoni, parole, luce, grida – […] non è quale noi lo conosciamo attraverso l’aspetto esteriore dei fatti, ma il suo nucleo fragile e irrequieto, inafferrabile dalle forme” (in – Il teatro e il suo doppio). Siamo di fronte alla “chiusura della rappresentazione”, non come rappresentazione del destino ma come destino della rappresentazione: senza fine, senza fondo, in una ripetizione delle differenze che rende impossibile qualsiasi riappropriazione, aprendosi all’indefinito. Nell’iterabilità, l’alterazione, senza destina- zione certa, come una forza di rottura, permette e diviene movimento di apertura della scena stessa. Non si vuole sopprimere la parola ma cambiarne la destinazione e ridurne il suo posto, mettendone in questione le possibilità. Da lontano, ancora una volta, l’attenzione critica riservata e dovuta a tali orizzonti concettuali, non tanto per proteggere l’esistenza soggettiva, l’originalità di un opera o la singolarità del bello contro le violenze del concetto, ma, e inversamente, quando ci immettiamo in questo flusso d’analisi così profonda e sconcertante quasi, lo facciamo per spezzare ulteriormente la figura dell’unico, del completo e del perfetto che mettono le radici nelle differenze. Questo terreno, al quale ci siamo accostati anche se soltanto in forma critica, dischiude la denuncia instancabile di una esperienza di derivazione, se non di impossibilità, che non dà luogo a delle opere: l’esistenza di un artista, non è più la via o l’esperienza che danno accesso a qualcosa di diverso da sé, una avventura (ci piace designare così una totalità anteriore alla separazione della vita e dell’opera) che si rifiuta di significare, di perseguire una manifestazione di espressione e che invece si impone come una creazione pura della vita, senza mai cadere lontano dal corpo per scadere in segno o opera o oggetto.
Pietro Camarda
|
|
Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
Click here to edit.
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati