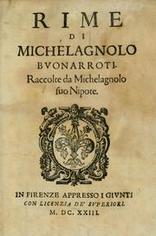Parlare dell’arte meno celebrata di Michelangelo, quella poetica, è cosa non proprio semplice, vuoi perché la grandezza dell’artista ha fatto sì che la fama dei suoi versi ne venisse oscurata; vuoi per le difficoltà intrinseche del corpus delle sue Rime[1], quasi del tutto posteriormente ordinato e che presenta complicazioni già a partire dalla datazione dei componimenti, sì da impedirne una sicura collocazione entro un orizzonte poetico pensato in senso evolutivo (come storia di un anima insomma). A ciò viene ad aggiungersi l’incompiutezza di non pochi dei progetti poetici buonarrotiani, tanto che alcuni sono stati ripensati solo recentemente sotto una luce inaspettata, come nel caso di quelle che Guglielmo Gorni ha chiamato «le ottave dei giganti», ritenute fino a qualche anno fa abbozzi indipendenti, e ripensate invece dallo studioso come membri di un incompiuto poema in ottave[2].
Certo è che nel panorama cinquecentesco le Rime di Michelangelo rifulgano per originalità e spessore nel loro ripensamento della tradizione petrarchesca, tanto da spingere l’allora antipetrarchista per eccellenza Francesco Berni a darne un giudizio entusiasta e ormai celeberrimo:
[…]
Ho visto qualche sua composizione:
sono ignorante, e pur direi d’avelle
lette tutte nel mezzo di Platone.
Sì ch’egli è nuovo Apollo e nuovo Apelle:
tacete unquanco, pallide rose
e liquidi cristalli e fiere snelle:
e’ dice cose, e voi dite parole.[3]
Questa unicità della poesia di Michelangelo nel panorama cinquecentesco è stata ricondotta da Binni alle origini della formazione buonarrotiana, in quel giro cruciale d’anni nella cultura italiana che va dai primi Novanta del Quattrocento al primo decennio del Cinquecento:
[…] una civiltà letteraria tardo-quattrocentesca, che rimane sostanzialmente (con le sue premesse dantesche e petrarchesche) la base letteraria più importante della poetica michelangiolesca, piuttosto chiusa all’eco degli sviluppi cinquecenteschi e a questi piuttosto parallela e, viceversa, anche più avanzata, ma per una via più particolare.[4]
Tanto da assegnare alle prediche savonaroliane un posto perspicuo come scaturigine linguistica e immaginativa della poetica michelangiolesca.
Ma lo specimen della poesia michelangiolesca, come fa già notare Mario Baratto[5], risiede anche nel particolarissimo statuto che l’io poetico assume, essendo il Buonarroti «il primo poeta lirico [nel Cinquecento] a isolarsi, nelle sue rime, come il soggetto di un dramma reale, cioè come un personaggio che vive una storia di uomo e di artista che egli vuole testimoniare non solo nella sua varietà, ma anche nella sua essenza contraddittoria»[6]. E questa contraddittorietà tesa e vibrante che si manifesta come dramma umano viene ribadita, in forma diversa, anche dal Residori, il quale evidenzia, anche con riferimento alla sua pittura e in particolare agli affreschi della Sistina, come
[…] per Michelangelo, la creazione è essenzialmente divisione […] l’atto creatore di Dio non dà luogo ad una esuberante abbondanza e a una variopinta molteplicità di esseri viventi: basta vedere il magro cespuglietto della Creazione delle piante per misurare la sovrana indifferenza dell’artista per la profusione del mondo naturale. La creazione produce opposizioni, polarità fondamentali. Non si tratta, naturalmente, di attribuire a Michelangelo una posizione teologica precisa e più o meno originale; si vuole solo sottolineare come egli tenda a dare un fondamento teologico ai propri schemi mentali, e in particolare alla propria sensibilità, evidente nelle Rime per “le coppie metaforiche originarie che reggono il mondo” (Contini).
Caratteristico della personalità artistica michelangiolesca sarebbe dunque la percezione di un’esistenza in qualche modo divisa tra opposte tendenze, un continuo oscillare del mondo e del soggetto tra elementi polarizzati; e se si cercasse di individuare questi movimenti oppositivi nella sua poesia non mancherebbe il materiale. Si veda un sonetto come quello sistemato sotto il numero 87, che drammatizza con altissimi risultati questa tensione dinamica:
Vorrei voler, Signor quel ch’io non voglio:
tra ’l foco ’l cor di ghiaccia un vel s’asconde
che ’l foco ammorza, onde non corrisponde
la penna all’opre, e fa bugiardo ’l foglio.
I’ t’amo con la lingua, e poi mi doglio
c’amor non giunge al cor; né so ben onde
apra l’uscio alla grazia che s’infonde nel cor, che scacci ogni spietato orgoglio.
Squarcia ’l vel tu, Signor, rompi quel muro
che con la suo durezza ne ritarda
il sol della tuo luce, al mondo spenta!
Manda ’l preditto lume a·nnoi venturo,
alla tuo bella sposa, acciò ch’io arda
il cor senz’alcun dubbio, e te sol senta.[7]
Il caso scelto è forse esemplare perché instaura una tensione sentita come drammatica dal poeta. Da una parte la sua aspirazione a una fede vissuta non come parola morta («I’ t’amo con la lingua», v. 5), ma come etica del quotidiano, dall’altra la consapevolezza dell’inadempimento di questa proposizione. Dal conflitto interiore che l’io poetico constata nel moto contraddittorio della sua volontà si giunge fino al paradosso così audacemente espresso al primo verso. Il soggetto si rende dunque conto della sua debole natura di peccatore e chiede una grazia terrena che giunga dal divino e che sciolga il gelo del cuore per aprirlo alla salvezza. Si potrebbe insomma dire che le opposizioni sono cosa tutta terrena e che il dramma umano venga dalla costrizione al mondo mortale.
Si diceva prima con Baratto che quella che si mostra nelle Rime di Michelangelo è una personalità eccezionale; eppure bisogna a mio avviso rifuggire ogni tentativo di comprimere l’io poetico delle Rime entro una classificazione che gli starebbe stretta, e che rischierebbe d’essere (come ammoniva già Binni[8]) di pericolosa ascendenza romantica. Va tenuto conto infatti della dimensione progettuale che le Rime assumono. Esse rimangono un cantiere nel quale il poeta, pur giungendo nel punto della vita «[…] ov’a render si varca / conto e ragion d’ogni opra trista e pia» (285, 3-4), rifiuta di porre un ordine definitivo (malgrado i primi progetti di sistemazione), probabilmente per il legame che questi esercizi hanno col dramma quotidiano («reale» diceva appunto Baratto) dell’artista e per il mutare della situazione socio-politica cui si assiste nella metà del Cinquecento. L’autore compie in molte di queste Rime una confes- sione che sembra non poche volte avere una effettiva valenza pratica, di chiarificazione con se stesso nella contingenza in cui è trascinato. Il corpus dei versi di Michelangelo diviene dunque, preso nella sua interezza, quasi l’esatto opposto di un canzoniere: un laboratorio di esperimenti poetici attraverso il quale il poeta cerca dapprima il suo proprio tono specifico e un’apertura sincera della sua anima. Successivamente, presa consapevolezza dei suoi strumenti poetici, la voce poetante diviene il centro propulsore del dramma umano di cui si parlava sopra e dispiega con molta più sicurezza le sue tensioni interne. Ma sarà bene a questo punto individuare almeno i temi più cari alla poesia di Michelangelo, tenendo ben presente che l’elenco non sarà esaustivo né andrà preso con troppa staticità. È ovvio che in un poeta di una simile levatura molteplici temi si intreccino in un unico componimento e si declinino anche spesso in forme disomogenee (non per questo contraddittorie).
Quello che più di ogni altro, comunque, si pone all’attenzione del lettore è certamente il tema dell’amore, sviluppato prevalentemente secondo consuetudini e moduli petrarcheschi ma riattualizzati in una chiave originale che ne fa vibrare le corde più nervose; un Petrarca letto però sotto l’insegna di Dante, tutt’altro dunque che monolinguistico; anzi, al termine peregrino si sostituisce non di rado un lessico della materialità o delle attività quotidiane (tanto che non di rado intervengono anche termini del commercio o del diritto); al verso musicalissimo si preferisce spesso la dissonanza, ricreata anche attraverso ardite allitterazioni o suoni asperrimi; alla serena eleganza del dettato si può sostituire anche la dizione più popolare. Particolarità di questi componimenti è anche un accento più drammaticamente vivo e meno letterario che nei suoi più composti contemporanei (si pensi al Bembo o al Della Casa, appartenente alla generazione successiva quest’ultimo), fatto determinato evidentemente proprio dalla sua formazione di autodidatta, che sembra spingerlo a mettere più schiettamente a nudo la sua persona, senza la mediazione libresca di altri scrittori coevi. Non mi pare un caso che misura metrica assai congeniale a Michelangelo sia il madrigale, genere poetico più aperto al sentimentalismo. E, se si vorrà tracciare una storia del madrigale, il Buonarroti sarà certo una tappa imprescindibile prima che si arrivi al Tasso.
A caratterizzare ulteriormente la poesia amorosa di Michelangelo, pur non essendo certo peculiarità esclusiva della sua poetica nel contesto letterario in cui si trovò ad operare, interviene tra l’altro la mediazione della filosofia platonica, che ha forse in Lorenzo e nel Poliziano i due massimi modelli per questo innesto. È da questo originario elemento della sensibilità del Buonarroti che probabilmente muoverà l’innalzamento spirituale cui si assiste soprattutto nelle rime senili.
Altro tema che si definisce con molta originalità nell’opera poetica del nostro scrittore, è quello dell’arte, certo fondamentale anche sul piano biografico. E non credo si esageri dicendo che nei componimenti in cui questo tema diviene nucleo generatore di poesia i risultati siano quasi sempre elevati per qualità della costruzione e intensità. Si tratta comunque per lo più di un piccolo gruppo di rime della vecchiaia (dopo il 1546), per la precisione i sonetti 151 e 236 e i madrigali 152, 153 e 241 (ma anche il sonetto caudato doppio 5, I’ ho già fatto un gozzo in questo stento, sviluppa e ne capovolge i termini nella modalità comico-realistica, un tema in certa misura consimile, concentrandosi sul sacrificio, le delusioni e la fatica che la vita quotidiana dell’artista porta con sé; là dove invece le liriche a cui qui ci si riferisce sviluppano più che altro un rapporto metaforico arte-vita o arte-amore), alle quali sarà da aggiungere per lo meno il sonetto 46. I primi due nella serie sono forse quelli che più brillano in virtù della loro architettura perfetta, della forza delle loro immagini, del loro dettato terso. Si prenda il primo, il 151:
Non ha l’ottimo artista alcun concetto
c’un marmo solo in sé non circoscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.
Il mal ch’io fuggo, e ’l ben ch’io mi prometto,
in te, donna leggiadra, altera e diva,
tal si nasconde; e perch’io più non viva,
contraria ho l’arte al disïato effetto.
Amor dunque non ha, né tua beltate
o durezza o fortuna o gran disdegno,
del mio mal colpa, o mio destino o sorte;
se dentro del tuo cor morte e pietate
porti in un tempo, e che ’l mio basso ingegno
non sappia, ardendo, trarne che morte.
Già famoso nel Cinquecento per essere stato oggetto, nel 1546, di una lezione di Benedetto Varchi all’Accademia Fiorentina; dedicato forse a Vittoria Colonna (ma Residori preferisce essere prudente su tale ipotesi poiché, pur fondandosi sull’ auctoritas della tradizione, non può contare su dati certi), il sonetto ripropone già dalla prima quartina una contrapposizione atto-intelletto dove il secondo dei due poli è connotato positivamente e perciò deve fungere da guida al primo. Ma l’exemplum dell’arte è funzionalizzato dal poeta alla rappresentazione del tormento dell’amante nella consapevolezza di non poter giungere «al disïato effetto», perché l’ardore, non moderato da intelletto, mortifica l’aspirazione “pietosa” dell’amante. Ne vien fuori una creatura femminile che porta con sé in potenza ‒ nel senso aristotelico segnalato anche dal Residori ‒ «morte e pietate» (ancora due coppie oppositive) ma dalla quale solo un’anima elevata può trarre la salvezza che il Bello e l’amore possono rappresentare. Si intuisce anche qui l’influsso che la filosofia platonica, vivissima, come si sa, nella Firenze in cui il giovane Michelangelo si era formato, esercitò sullo spirito poetico dell’artista. Il mondo, ch’è pure il luogo dove si dispiega quella bellezza primo tramite d’una possibile ascesa al divino, ha insito in sé il rischio della devianza da questa via, devianza però imputabile alla debolezza umana e all’immediato, ferino, ardore che quella bellezza suscita. Risiede in questo caso nell’intelletto, dono anch’esso divino, la possibilità di sciogliere il Bello dal suo ancoraggio terreno per innalzarlo al suo naturale statuto di ponte tra l’uomo e Dio. L’amore platonicamente inteso diviene allora la forza eminente che innalza l’anima umana. Allo stesso modo dell’artista, dunque, l’uomo deve saper fare scaturire dalla materia (nel caso specifico, dalla donna amata) la sua essenza divina, il Bello appunto.
Per continuare il nostro rilievo tematico sarà bene render conto di un altro esiguo numero di testi che hanno però rappresentato una delle più fortunate vicende antologiche di Michelangelo, forse soprattutto per la facilità con la quale si prestano a letture romantiche. Si sta parlando del celebre ciclo di sonetti notturni (101-104), fino a pochi anni fa ritenuti appartenenti al periodo 1546, oggi retrodatati grazie a brillanti rilievi testuali e biografici da parte del Residori, alla fine del 1534 o all’inizio del 1535[9]. Già la definizione di ciclo della notte (o simili) non è del tutto esatta. Fa infatti notare Residori che in questa serie (che è bene non pensare aprioristicamente come ciclo concepito da Michelangelo in tale forma, pur nelle numerose affinità che manifestano) non si ponga tanto una situazione descrittiva, quanto il problema gnoseologico del rapporto tra notte e giorno; un rapporto tutto vagliato alla luce di una logica quasi «algebrica» che tuttavia non manca di angoli oscuri e di tensioni irrisolte tanto da far concludere allo studioso che:
[…] bisogna resistere alla tentazione di leggere questi testi come un percorso intellettuale coerente. Non è da Michelangelo proporci conclusioni di sorta, né inscenare, a nostra edificazione, percorsi esemplari o fallimenti emblematici; tutto quello che egli ci chiede è di seguirlo per un po’ nei suoi futili e serenissimi esperimenti poetici.[10]
Accanto ai componimenti che sviluppano le linee tematiche sopra descritte si affiancano, in una posizione non gerarchicamente subordinata, i testi di matrice comico-burlesca, che hanno come modelli soprattutto il Burchiello e il Pulci (ma non vanno dimenticati i richiami alla Nencia di Lorenzo né, più tardi, l’apporto del Berni, con il quale lo scambio, però, è reciproco). Essi sviluppano soprattutto il tema della fatica, della bruttezza (che è topos declinato, con differenti strumenti, anche nelle liriche petrarchesche del Buonarroti), dell’irriconoscenza sia dei potenti che del volgo[11], della corruzione, della decadenza. Ma tra le Rime si trovano anche esempi curiosi (spesso d’occasione) di componimenti che si pongono in limine dell’esperienza burlesca e di quella lirica. Si potrebbero definire componi- menti “faceti” poiché, malgrado venga abbandonato lo stile più elevato, non si verifica neanche un abbassamento del tono tale da generare la risata sardonica. Viene piuttosto fatta vibrare la corda arguta dell’ironia senza che questa risuoni con troppa forza. E un esempio interessante è l’epigramma 247: «Caro m’è ’l sonno e più l’esser di sasso, / mentre che ’l danno e la vergogna dura; / non veder, non sentir m’è gran ventura; / però non mi destar, deh, parla basso». Si tratta della celebre risposta alla lode in rima che Giovanni Strozzi scrisse dopo aver ammirato la statua michelangiolesca della Notte nella Sagrestia Nuova. A parlare è la statua, che lo Strozzi aveva definito tanto vivamente realizzata da sembrare quasi possibile poterla svegliare.
Il poeta smorza il tono pedantescamente elevato del letterato fiorentino e attraverso lo scatto ironico ne mette in ridicolo la vacuità, ritraendo una statua che implora al rispetto del suo sonno. Si vede bene, dunque, come la strenua ricerca di Michelangelo sia volta non solo a sperimentare tutte le possibilità della poesia, ma anche a trovare i punti di contatto tra le divergenti esperienze per scoprire la traccia più sincera e più viva che la lingua può riservare. Non sempre i risultati sono meritevoli di lode (si pensi alla fiumana di epitaffi in morte di Cecchino Bracci, che hanno comunque un’importanza non trascurabile nella formazione di un gusto per il calembour nel nostro scrittore) ma sono comunque indicativi della volontà dell’artista di saggiare il terreno della poesia superando le costrizione cui lo potrebbero legare le convenzioni stilistiche. È forse anche in virtù di esperimenti meno sicuri o d’occasione che Michelangelo giunge a una sensibilità stilistica straordinariamente concreta, ponendosi antagonisticamente nei confronti delle consuetudini poetiche e cercando di saggiare le potenzialità della lingua e dello stile.
È anche attraverso questa mediazione dunque che si giunge ai massimi emblemi della produzione burlesca del Buonarroti, che io individuerei, malgrado la loro distanza nel tempo, nei componimenti raccolti sotto i numeri 5, 85 e 267. Il primo dei tre ci ritrae un poeta-artista stracco e deformato dalla fatica e dalle angherie e dall’insoddisfazione per gli scarsi riconoscimenti che gli vengono concessi, oltre che per la sua «pittura morta». Il poeta è costretto a lavorare così scomodamente e strenuamente che va trasformandosi in un grottesco mostro. È un componimento dalle immagini di gusto quasi rabelaisiano e d’una straordinaria comicità che ha sicure ascendenze nell’opera del Burchiello e del Pulci, ma che non si risolve (come d’altronde nei due grandi modelli) in gioco allegro e fine a se stesso; ne viene fuori infatti un’immagine amara degli stenti quotidiani, pur nella condizione eccezionale che la vita d’artista può rappresentare. Il componimento 85 è un capitolo in terza rima, in risposta all’elogio della poesia di Michelangelo che il Berni scrisse e indirizzò a Sebastiano del Piombo (1534). Qui Michelangelo prende i panni del pittore originario di Venezia e risponde all’ammiratore dichiarando di averlo raccomandato nell’ambiente dei potenti cardinali romani (come Berni aveva richiesto). Dal capitolo si ottiene un ritratto che sostituisce all’austerità e al fasto della corte papale un ambiente da scena popolare nel quale persino il Papa (Clemente VII, papa mediceo e dunque «Medico maggior de’ nostri mali»; dove fa nuovamente la sua comparsa il gusto michelangiolesco per il calembour a cui s’è già accennato) ride tanto che il naso gli si gonfia fino a spezzare in due parti gli occhiali che porta sopra. L’ultimo componimento di questa serie, anch’esso un capitolo in terza rima, è un trionfo della decadenza cui l’artista s’è ridotto a vivere, compiuto però non tanto in una nota carnevalesca e allegra,quanto piuttosto con un contrappunto malinconico (ma si badi a non leggere quel v. 25 di carattere quasi “medico” «la mia allegrezz’ è la maninconia» in chiave romantica) pur nella sua autoironia: «Fiamma d’amor nel cor non m’è rimasa; / se ’l maggior caccia sempre il minor duolo, / di penne l’alma ho ben tarpata e rasa». La produzione burlesca di Michelangelo non va perciò subordinata gerarchicamente alla linea lirica, ché quella è anzi un banco di prova essenziale perché il poeta forzi con personalità i confini della lingua manierata del suo tempo per riportare nella sua personalissima lirica uno stile originale, che tragga soprattutto dal Dante più petroso le suggestioni più forti. Si può dire quasi che l’esercizio col deforme e con la dimensione più materiale e carnale della quotidianità lo sproni a smussare gli angoli più triti della lirica del suo tempo, fungendo da impulso alla decodificazione della realtà oltre la parola consunta. Quello dell’artista sembra essere un apprendistato faticoso ma appassionato nella realtà perché questa sia riportata alla parola. Ed è così, mi pare, che nascono i componimenti più rappresentativi[12]. A metà strada tra le altezze alle quali Michelangelo assurgerà e i componimenti di stile prettamente burlesco, quasi a costituire un continuum linguistico-stilistico si potrebbe porre allora il sonetto 10, che con richiami lessicali alla poesia comico-realistica sviluppa in realtà seriamente il tema della corruzione dei tempi. Per quanto infatti l’eco linguistica al quale il testo è più vicino sia certo la poesia del Morgante (con precisi richiami) il modello è qui alto: i sonetti avignonesi del Petrarca e più ancora le invettive della Commedia. Si tratta di un testo del 1512 (o addirittura, seguendo la Bardeschi Ciulich, del più antico componimento michelangiolesco), che lascia intravedere la sicurezza che Michelangelo sempre ebbe nell’ asperità dell’invettiva. Da ciò si potrebbe dire che il percorso linguistico e poetico di Michelangelo non consista tanto nello sperimentare i molti timbri che la tradizione letteraria gli offre, quanto nel ricongiungerli tutti entro una sua misura personale perché questa diventi il suo stile e la sua propria voce.
Proprio quando questa misura è fatta propria, l’artista trova più naturale innalzarsi al di sopra della materialità che a lungo ha perseguito (ma si ricordi a questo punto l’importanza dell’incontro con Vittoria Colonna). Si sta parlando infatti della nota anelante e superna che diventa viepiù perspicua negli ultimi componimenti di Michelangelo (il periodo è approssimativamente il 1546-1560). Da qui sembra progettualizzarsi, nella successione delle liriche, una spinta ascendente, che dalla dimensione più prettamente terrena e diadica dell’amore, prima così imponente nella poetica di Michelangelo, s’innalza al di sopra dell’esperienza sensibile per assurgere ai regni celesti. Si crea così una polarità terra-trascendenza che si conclude spesso nell’interrogativo tormentoso o nella malinconica consapevolezza della propria peccaminosità. Non che la dimensione ultraterrena cui rimanda la presenza del bello in terra sia novità di tale periodo: basti prendere, per dare un solo esempio, il sonetto 42, che rappresenta un dialogo tra il poeta-aman- te e Amore nel quale il secondo esemplifica ideali di platonica religiosità. Tuttavia, a quell’ altezza, la dimensione divina o trascendente (poiché questa trascendenza alle volte può avere un carattere più platonico-intellettuale) è ancora sentita come lontana, inattinta. Nei testi tardi cui qui ci si riferisce, invece, le regioni celesti sono quasi contem- plate dall’ardore dell’anima; sono intuite, sentite con una forza nuova, non più tanto intellettuale quanto religiosa.
Bisognava dunque attendere proprio che un simile ingegno si cimentasse con il suo dramma interiore d’uomo e d’anima perché l’eco del Poeta paradisiaco risuonasse delle corde più sincere e meravigliose di un nuovo poeta:
Non è sempre di colpa aspra e mortale
d’una immensa bellezza un fero ardore,
se poi sì lascia liquefatto il core,
che ’n breve il penetri un divino strale.
Amore isveglia e desta e’mpenna l’ale,
né l’alto vol preschive al van furore;
qual primo grado c’al suo creatore,
di qual non sazia, l’alma ascende e sale.
L’amor di quel ch’i’ parlo in alto aspira;
donna è dissimil troppo, e mal conviensi
arder di quella al cor saggio e verile.
L’un tira al cielo, e l’altro in terra tira;
nell’alma l’un, l’altr’abita ne’ sensi,
e l’arco tira a cose basse e vile.
Il testo è quello del sonetto 260, di schema ABBA ABBA CDE CDE (il più usato dall’autore). Nella prima quartina della fronte si vede bene la nuova forza poetica che guida il motivo dell’amore, non più concluso nel solo canale della dimensione umana, ma innalzato e iperuranizzato. Non è questa una novità nella lirica italiana o nell’arte rinascimentale in genere; basti tener presente il ruolo già evidenziato che la cultura del platonismo fiorentino, e in ispecie del trattato Dell’amore di Ficino, rivestiva già nell’opera di Michelangelo (ma allo stesso modo in tutta la cultura ufficiale italiana). Pur tuttavia all’altezza cronologica di questo componimento (probabilmente composto dopo il 1546, come ci informa Residori) gli sviluppi poetici del verso michelangiolesco hanno già assunto un carattere distintivo, che direi vada individuato nella assoluta preminenza che assume l’anelito al cielo come luogo di salvezza spirituale, pace eterna dell’anima. La bellezza, tema ancora centrale, è sempre trascesa dalla sua terrestrità (mi si perdoni il richiamo ono- friano). Ma non è ancora nello sviluppo tematico che si riduce l’assoluta unicità della poesia di Michelangelo nel panorama cinquecentesco. Si badi a quelle immagine del cuore «liquefatto», immagine così carica di materialità, parola «quasi brutta» per dirla con Gozzano. Eppure nell’architettura così tesa del componimento è immagine perfet-tamente intonata ai moti del «fero ardore» (si tenga presente poi, come ci ricorda Residori, che si tratta di eco di Salmi, 21, 15 già ripreso dal Magnifico nella sua Rappresentazione). Si rappresenta infatti, con immagini di aspra forza immaginativa, quel conflitto tipicamente michelangiolesco di un anima furiosamente anelante al cielo eppure costretta dalle catene terrestri, sì da generare lo strazio di una mortalità consapevolmente assunta come minaccia di dannazione per l’anima peccatrice. Interviene in questo caso però un bellissimo climax ascendente – anch’esso, mi pare, di gusto dantesco ‒ («Amore isveglia e desta e’mpenna l’ale », v. 5) che ripone certi toni di amara disfatta che ca- ratterizzano altri componimenti anteriori e che innesta nella tensione dialettica tra dimensione terrestre e dimensione celeste il cardine dell’amore-speranza, quasi luterana testimonianza («il giusto vivrà per fede» secondo la lettu- ra che Lutero propone di S. Paolo, Rom. I, 16-18) della possibilità della salvezza, sì che l’amore divino manifestatosi nel sacrificio di Cristo diviene luce di grazia per il peccatore, infondendo la speranza della salvezza («Le spine e’ chio - di e l’una e l’altra palma / col tuo benigno umil pietoso volto / prometton grazia di pentirsi molto, / e speme di salute a la trist’alma» 290, 5-8; «Ma pur par nel tuo sangue si comprenda, / se per noi par non ebbe il tuo martire, / senza misura sien tuo cari doni», 294, 11-14).
Dicevo sopra che riterrei un azzardo definire con troppa rigidità le linee evolutive della poesia di Michelangelo, poiché la forma non conclusa del corpus, senza un centro né un preciso e costante disegno-guida interno, renderebbe astrazione a posteriori una simile operazione. Pur tuttavia è compito del filologo e del critico, sempre uniti da carettiana concordia si vorrebbe sperare, gettar luce sulle linee visibili di tale disegno, magari sfumandone i contorni, esaltandone il chiaroscuro, come si è cercato di fare, perché il lettore moderno possa intravedere la forza anche sotterranea che questo grande artista seppe immettere nella nostra poesia.
Certo è che nel panorama cinquecentesco le Rime di Michelangelo rifulgano per originalità e spessore nel loro ripensamento della tradizione petrarchesca, tanto da spingere l’allora antipetrarchista per eccellenza Francesco Berni a darne un giudizio entusiasta e ormai celeberrimo:
[…]
Ho visto qualche sua composizione:
sono ignorante, e pur direi d’avelle
lette tutte nel mezzo di Platone.
Sì ch’egli è nuovo Apollo e nuovo Apelle:
tacete unquanco, pallide rose
e liquidi cristalli e fiere snelle:
e’ dice cose, e voi dite parole.[3]
Questa unicità della poesia di Michelangelo nel panorama cinquecentesco è stata ricondotta da Binni alle origini della formazione buonarrotiana, in quel giro cruciale d’anni nella cultura italiana che va dai primi Novanta del Quattrocento al primo decennio del Cinquecento:
[…] una civiltà letteraria tardo-quattrocentesca, che rimane sostanzialmente (con le sue premesse dantesche e petrarchesche) la base letteraria più importante della poetica michelangiolesca, piuttosto chiusa all’eco degli sviluppi cinquecenteschi e a questi piuttosto parallela e, viceversa, anche più avanzata, ma per una via più particolare.[4]
Tanto da assegnare alle prediche savonaroliane un posto perspicuo come scaturigine linguistica e immaginativa della poetica michelangiolesca.
Ma lo specimen della poesia michelangiolesca, come fa già notare Mario Baratto[5], risiede anche nel particolarissimo statuto che l’io poetico assume, essendo il Buonarroti «il primo poeta lirico [nel Cinquecento] a isolarsi, nelle sue rime, come il soggetto di un dramma reale, cioè come un personaggio che vive una storia di uomo e di artista che egli vuole testimoniare non solo nella sua varietà, ma anche nella sua essenza contraddittoria»[6]. E questa contraddittorietà tesa e vibrante che si manifesta come dramma umano viene ribadita, in forma diversa, anche dal Residori, il quale evidenzia, anche con riferimento alla sua pittura e in particolare agli affreschi della Sistina, come
[…] per Michelangelo, la creazione è essenzialmente divisione […] l’atto creatore di Dio non dà luogo ad una esuberante abbondanza e a una variopinta molteplicità di esseri viventi: basta vedere il magro cespuglietto della Creazione delle piante per misurare la sovrana indifferenza dell’artista per la profusione del mondo naturale. La creazione produce opposizioni, polarità fondamentali. Non si tratta, naturalmente, di attribuire a Michelangelo una posizione teologica precisa e più o meno originale; si vuole solo sottolineare come egli tenda a dare un fondamento teologico ai propri schemi mentali, e in particolare alla propria sensibilità, evidente nelle Rime per “le coppie metaforiche originarie che reggono il mondo” (Contini).
Caratteristico della personalità artistica michelangiolesca sarebbe dunque la percezione di un’esistenza in qualche modo divisa tra opposte tendenze, un continuo oscillare del mondo e del soggetto tra elementi polarizzati; e se si cercasse di individuare questi movimenti oppositivi nella sua poesia non mancherebbe il materiale. Si veda un sonetto come quello sistemato sotto il numero 87, che drammatizza con altissimi risultati questa tensione dinamica:
Vorrei voler, Signor quel ch’io non voglio:
tra ’l foco ’l cor di ghiaccia un vel s’asconde
che ’l foco ammorza, onde non corrisponde
la penna all’opre, e fa bugiardo ’l foglio.
I’ t’amo con la lingua, e poi mi doglio
c’amor non giunge al cor; né so ben onde
apra l’uscio alla grazia che s’infonde nel cor, che scacci ogni spietato orgoglio.
Squarcia ’l vel tu, Signor, rompi quel muro
che con la suo durezza ne ritarda
il sol della tuo luce, al mondo spenta!
Manda ’l preditto lume a·nnoi venturo,
alla tuo bella sposa, acciò ch’io arda
il cor senz’alcun dubbio, e te sol senta.[7]
Il caso scelto è forse esemplare perché instaura una tensione sentita come drammatica dal poeta. Da una parte la sua aspirazione a una fede vissuta non come parola morta («I’ t’amo con la lingua», v. 5), ma come etica del quotidiano, dall’altra la consapevolezza dell’inadempimento di questa proposizione. Dal conflitto interiore che l’io poetico constata nel moto contraddittorio della sua volontà si giunge fino al paradosso così audacemente espresso al primo verso. Il soggetto si rende dunque conto della sua debole natura di peccatore e chiede una grazia terrena che giunga dal divino e che sciolga il gelo del cuore per aprirlo alla salvezza. Si potrebbe insomma dire che le opposizioni sono cosa tutta terrena e che il dramma umano venga dalla costrizione al mondo mortale.
Si diceva prima con Baratto che quella che si mostra nelle Rime di Michelangelo è una personalità eccezionale; eppure bisogna a mio avviso rifuggire ogni tentativo di comprimere l’io poetico delle Rime entro una classificazione che gli starebbe stretta, e che rischierebbe d’essere (come ammoniva già Binni[8]) di pericolosa ascendenza romantica. Va tenuto conto infatti della dimensione progettuale che le Rime assumono. Esse rimangono un cantiere nel quale il poeta, pur giungendo nel punto della vita «[…] ov’a render si varca / conto e ragion d’ogni opra trista e pia» (285, 3-4), rifiuta di porre un ordine definitivo (malgrado i primi progetti di sistemazione), probabilmente per il legame che questi esercizi hanno col dramma quotidiano («reale» diceva appunto Baratto) dell’artista e per il mutare della situazione socio-politica cui si assiste nella metà del Cinquecento. L’autore compie in molte di queste Rime una confes- sione che sembra non poche volte avere una effettiva valenza pratica, di chiarificazione con se stesso nella contingenza in cui è trascinato. Il corpus dei versi di Michelangelo diviene dunque, preso nella sua interezza, quasi l’esatto opposto di un canzoniere: un laboratorio di esperimenti poetici attraverso il quale il poeta cerca dapprima il suo proprio tono specifico e un’apertura sincera della sua anima. Successivamente, presa consapevolezza dei suoi strumenti poetici, la voce poetante diviene il centro propulsore del dramma umano di cui si parlava sopra e dispiega con molta più sicurezza le sue tensioni interne. Ma sarà bene a questo punto individuare almeno i temi più cari alla poesia di Michelangelo, tenendo ben presente che l’elenco non sarà esaustivo né andrà preso con troppa staticità. È ovvio che in un poeta di una simile levatura molteplici temi si intreccino in un unico componimento e si declinino anche spesso in forme disomogenee (non per questo contraddittorie).
Quello che più di ogni altro, comunque, si pone all’attenzione del lettore è certamente il tema dell’amore, sviluppato prevalentemente secondo consuetudini e moduli petrarcheschi ma riattualizzati in una chiave originale che ne fa vibrare le corde più nervose; un Petrarca letto però sotto l’insegna di Dante, tutt’altro dunque che monolinguistico; anzi, al termine peregrino si sostituisce non di rado un lessico della materialità o delle attività quotidiane (tanto che non di rado intervengono anche termini del commercio o del diritto); al verso musicalissimo si preferisce spesso la dissonanza, ricreata anche attraverso ardite allitterazioni o suoni asperrimi; alla serena eleganza del dettato si può sostituire anche la dizione più popolare. Particolarità di questi componimenti è anche un accento più drammaticamente vivo e meno letterario che nei suoi più composti contemporanei (si pensi al Bembo o al Della Casa, appartenente alla generazione successiva quest’ultimo), fatto determinato evidentemente proprio dalla sua formazione di autodidatta, che sembra spingerlo a mettere più schiettamente a nudo la sua persona, senza la mediazione libresca di altri scrittori coevi. Non mi pare un caso che misura metrica assai congeniale a Michelangelo sia il madrigale, genere poetico più aperto al sentimentalismo. E, se si vorrà tracciare una storia del madrigale, il Buonarroti sarà certo una tappa imprescindibile prima che si arrivi al Tasso.
A caratterizzare ulteriormente la poesia amorosa di Michelangelo, pur non essendo certo peculiarità esclusiva della sua poetica nel contesto letterario in cui si trovò ad operare, interviene tra l’altro la mediazione della filosofia platonica, che ha forse in Lorenzo e nel Poliziano i due massimi modelli per questo innesto. È da questo originario elemento della sensibilità del Buonarroti che probabilmente muoverà l’innalzamento spirituale cui si assiste soprattutto nelle rime senili.
Altro tema che si definisce con molta originalità nell’opera poetica del nostro scrittore, è quello dell’arte, certo fondamentale anche sul piano biografico. E non credo si esageri dicendo che nei componimenti in cui questo tema diviene nucleo generatore di poesia i risultati siano quasi sempre elevati per qualità della costruzione e intensità. Si tratta comunque per lo più di un piccolo gruppo di rime della vecchiaia (dopo il 1546), per la precisione i sonetti 151 e 236 e i madrigali 152, 153 e 241 (ma anche il sonetto caudato doppio 5, I’ ho già fatto un gozzo in questo stento, sviluppa e ne capovolge i termini nella modalità comico-realistica, un tema in certa misura consimile, concentrandosi sul sacrificio, le delusioni e la fatica che la vita quotidiana dell’artista porta con sé; là dove invece le liriche a cui qui ci si riferisce sviluppano più che altro un rapporto metaforico arte-vita o arte-amore), alle quali sarà da aggiungere per lo meno il sonetto 46. I primi due nella serie sono forse quelli che più brillano in virtù della loro architettura perfetta, della forza delle loro immagini, del loro dettato terso. Si prenda il primo, il 151:
Non ha l’ottimo artista alcun concetto
c’un marmo solo in sé non circoscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.
Il mal ch’io fuggo, e ’l ben ch’io mi prometto,
in te, donna leggiadra, altera e diva,
tal si nasconde; e perch’io più non viva,
contraria ho l’arte al disïato effetto.
Amor dunque non ha, né tua beltate
o durezza o fortuna o gran disdegno,
del mio mal colpa, o mio destino o sorte;
se dentro del tuo cor morte e pietate
porti in un tempo, e che ’l mio basso ingegno
non sappia, ardendo, trarne che morte.
Già famoso nel Cinquecento per essere stato oggetto, nel 1546, di una lezione di Benedetto Varchi all’Accademia Fiorentina; dedicato forse a Vittoria Colonna (ma Residori preferisce essere prudente su tale ipotesi poiché, pur fondandosi sull’ auctoritas della tradizione, non può contare su dati certi), il sonetto ripropone già dalla prima quartina una contrapposizione atto-intelletto dove il secondo dei due poli è connotato positivamente e perciò deve fungere da guida al primo. Ma l’exemplum dell’arte è funzionalizzato dal poeta alla rappresentazione del tormento dell’amante nella consapevolezza di non poter giungere «al disïato effetto», perché l’ardore, non moderato da intelletto, mortifica l’aspirazione “pietosa” dell’amante. Ne vien fuori una creatura femminile che porta con sé in potenza ‒ nel senso aristotelico segnalato anche dal Residori ‒ «morte e pietate» (ancora due coppie oppositive) ma dalla quale solo un’anima elevata può trarre la salvezza che il Bello e l’amore possono rappresentare. Si intuisce anche qui l’influsso che la filosofia platonica, vivissima, come si sa, nella Firenze in cui il giovane Michelangelo si era formato, esercitò sullo spirito poetico dell’artista. Il mondo, ch’è pure il luogo dove si dispiega quella bellezza primo tramite d’una possibile ascesa al divino, ha insito in sé il rischio della devianza da questa via, devianza però imputabile alla debolezza umana e all’immediato, ferino, ardore che quella bellezza suscita. Risiede in questo caso nell’intelletto, dono anch’esso divino, la possibilità di sciogliere il Bello dal suo ancoraggio terreno per innalzarlo al suo naturale statuto di ponte tra l’uomo e Dio. L’amore platonicamente inteso diviene allora la forza eminente che innalza l’anima umana. Allo stesso modo dell’artista, dunque, l’uomo deve saper fare scaturire dalla materia (nel caso specifico, dalla donna amata) la sua essenza divina, il Bello appunto.
Per continuare il nostro rilievo tematico sarà bene render conto di un altro esiguo numero di testi che hanno però rappresentato una delle più fortunate vicende antologiche di Michelangelo, forse soprattutto per la facilità con la quale si prestano a letture romantiche. Si sta parlando del celebre ciclo di sonetti notturni (101-104), fino a pochi anni fa ritenuti appartenenti al periodo 1546, oggi retrodatati grazie a brillanti rilievi testuali e biografici da parte del Residori, alla fine del 1534 o all’inizio del 1535[9]. Già la definizione di ciclo della notte (o simili) non è del tutto esatta. Fa infatti notare Residori che in questa serie (che è bene non pensare aprioristicamente come ciclo concepito da Michelangelo in tale forma, pur nelle numerose affinità che manifestano) non si ponga tanto una situazione descrittiva, quanto il problema gnoseologico del rapporto tra notte e giorno; un rapporto tutto vagliato alla luce di una logica quasi «algebrica» che tuttavia non manca di angoli oscuri e di tensioni irrisolte tanto da far concludere allo studioso che:
[…] bisogna resistere alla tentazione di leggere questi testi come un percorso intellettuale coerente. Non è da Michelangelo proporci conclusioni di sorta, né inscenare, a nostra edificazione, percorsi esemplari o fallimenti emblematici; tutto quello che egli ci chiede è di seguirlo per un po’ nei suoi futili e serenissimi esperimenti poetici.[10]
Accanto ai componimenti che sviluppano le linee tematiche sopra descritte si affiancano, in una posizione non gerarchicamente subordinata, i testi di matrice comico-burlesca, che hanno come modelli soprattutto il Burchiello e il Pulci (ma non vanno dimenticati i richiami alla Nencia di Lorenzo né, più tardi, l’apporto del Berni, con il quale lo scambio, però, è reciproco). Essi sviluppano soprattutto il tema della fatica, della bruttezza (che è topos declinato, con differenti strumenti, anche nelle liriche petrarchesche del Buonarroti), dell’irriconoscenza sia dei potenti che del volgo[11], della corruzione, della decadenza. Ma tra le Rime si trovano anche esempi curiosi (spesso d’occasione) di componimenti che si pongono in limine dell’esperienza burlesca e di quella lirica. Si potrebbero definire componi- menti “faceti” poiché, malgrado venga abbandonato lo stile più elevato, non si verifica neanche un abbassamento del tono tale da generare la risata sardonica. Viene piuttosto fatta vibrare la corda arguta dell’ironia senza che questa risuoni con troppa forza. E un esempio interessante è l’epigramma 247: «Caro m’è ’l sonno e più l’esser di sasso, / mentre che ’l danno e la vergogna dura; / non veder, non sentir m’è gran ventura; / però non mi destar, deh, parla basso». Si tratta della celebre risposta alla lode in rima che Giovanni Strozzi scrisse dopo aver ammirato la statua michelangiolesca della Notte nella Sagrestia Nuova. A parlare è la statua, che lo Strozzi aveva definito tanto vivamente realizzata da sembrare quasi possibile poterla svegliare.
Il poeta smorza il tono pedantescamente elevato del letterato fiorentino e attraverso lo scatto ironico ne mette in ridicolo la vacuità, ritraendo una statua che implora al rispetto del suo sonno. Si vede bene, dunque, come la strenua ricerca di Michelangelo sia volta non solo a sperimentare tutte le possibilità della poesia, ma anche a trovare i punti di contatto tra le divergenti esperienze per scoprire la traccia più sincera e più viva che la lingua può riservare. Non sempre i risultati sono meritevoli di lode (si pensi alla fiumana di epitaffi in morte di Cecchino Bracci, che hanno comunque un’importanza non trascurabile nella formazione di un gusto per il calembour nel nostro scrittore) ma sono comunque indicativi della volontà dell’artista di saggiare il terreno della poesia superando le costrizione cui lo potrebbero legare le convenzioni stilistiche. È forse anche in virtù di esperimenti meno sicuri o d’occasione che Michelangelo giunge a una sensibilità stilistica straordinariamente concreta, ponendosi antagonisticamente nei confronti delle consuetudini poetiche e cercando di saggiare le potenzialità della lingua e dello stile.
È anche attraverso questa mediazione dunque che si giunge ai massimi emblemi della produzione burlesca del Buonarroti, che io individuerei, malgrado la loro distanza nel tempo, nei componimenti raccolti sotto i numeri 5, 85 e 267. Il primo dei tre ci ritrae un poeta-artista stracco e deformato dalla fatica e dalle angherie e dall’insoddisfazione per gli scarsi riconoscimenti che gli vengono concessi, oltre che per la sua «pittura morta». Il poeta è costretto a lavorare così scomodamente e strenuamente che va trasformandosi in un grottesco mostro. È un componimento dalle immagini di gusto quasi rabelaisiano e d’una straordinaria comicità che ha sicure ascendenze nell’opera del Burchiello e del Pulci, ma che non si risolve (come d’altronde nei due grandi modelli) in gioco allegro e fine a se stesso; ne viene fuori infatti un’immagine amara degli stenti quotidiani, pur nella condizione eccezionale che la vita d’artista può rappresentare. Il componimento 85 è un capitolo in terza rima, in risposta all’elogio della poesia di Michelangelo che il Berni scrisse e indirizzò a Sebastiano del Piombo (1534). Qui Michelangelo prende i panni del pittore originario di Venezia e risponde all’ammiratore dichiarando di averlo raccomandato nell’ambiente dei potenti cardinali romani (come Berni aveva richiesto). Dal capitolo si ottiene un ritratto che sostituisce all’austerità e al fasto della corte papale un ambiente da scena popolare nel quale persino il Papa (Clemente VII, papa mediceo e dunque «Medico maggior de’ nostri mali»; dove fa nuovamente la sua comparsa il gusto michelangiolesco per il calembour a cui s’è già accennato) ride tanto che il naso gli si gonfia fino a spezzare in due parti gli occhiali che porta sopra. L’ultimo componimento di questa serie, anch’esso un capitolo in terza rima, è un trionfo della decadenza cui l’artista s’è ridotto a vivere, compiuto però non tanto in una nota carnevalesca e allegra,quanto piuttosto con un contrappunto malinconico (ma si badi a non leggere quel v. 25 di carattere quasi “medico” «la mia allegrezz’ è la maninconia» in chiave romantica) pur nella sua autoironia: «Fiamma d’amor nel cor non m’è rimasa; / se ’l maggior caccia sempre il minor duolo, / di penne l’alma ho ben tarpata e rasa». La produzione burlesca di Michelangelo non va perciò subordinata gerarchicamente alla linea lirica, ché quella è anzi un banco di prova essenziale perché il poeta forzi con personalità i confini della lingua manierata del suo tempo per riportare nella sua personalissima lirica uno stile originale, che tragga soprattutto dal Dante più petroso le suggestioni più forti. Si può dire quasi che l’esercizio col deforme e con la dimensione più materiale e carnale della quotidianità lo sproni a smussare gli angoli più triti della lirica del suo tempo, fungendo da impulso alla decodificazione della realtà oltre la parola consunta. Quello dell’artista sembra essere un apprendistato faticoso ma appassionato nella realtà perché questa sia riportata alla parola. Ed è così, mi pare, che nascono i componimenti più rappresentativi[12]. A metà strada tra le altezze alle quali Michelangelo assurgerà e i componimenti di stile prettamente burlesco, quasi a costituire un continuum linguistico-stilistico si potrebbe porre allora il sonetto 10, che con richiami lessicali alla poesia comico-realistica sviluppa in realtà seriamente il tema della corruzione dei tempi. Per quanto infatti l’eco linguistica al quale il testo è più vicino sia certo la poesia del Morgante (con precisi richiami) il modello è qui alto: i sonetti avignonesi del Petrarca e più ancora le invettive della Commedia. Si tratta di un testo del 1512 (o addirittura, seguendo la Bardeschi Ciulich, del più antico componimento michelangiolesco), che lascia intravedere la sicurezza che Michelangelo sempre ebbe nell’ asperità dell’invettiva. Da ciò si potrebbe dire che il percorso linguistico e poetico di Michelangelo non consista tanto nello sperimentare i molti timbri che la tradizione letteraria gli offre, quanto nel ricongiungerli tutti entro una sua misura personale perché questa diventi il suo stile e la sua propria voce.
Proprio quando questa misura è fatta propria, l’artista trova più naturale innalzarsi al di sopra della materialità che a lungo ha perseguito (ma si ricordi a questo punto l’importanza dell’incontro con Vittoria Colonna). Si sta parlando infatti della nota anelante e superna che diventa viepiù perspicua negli ultimi componimenti di Michelangelo (il periodo è approssimativamente il 1546-1560). Da qui sembra progettualizzarsi, nella successione delle liriche, una spinta ascendente, che dalla dimensione più prettamente terrena e diadica dell’amore, prima così imponente nella poetica di Michelangelo, s’innalza al di sopra dell’esperienza sensibile per assurgere ai regni celesti. Si crea così una polarità terra-trascendenza che si conclude spesso nell’interrogativo tormentoso o nella malinconica consapevolezza della propria peccaminosità. Non che la dimensione ultraterrena cui rimanda la presenza del bello in terra sia novità di tale periodo: basti prendere, per dare un solo esempio, il sonetto 42, che rappresenta un dialogo tra il poeta-aman- te e Amore nel quale il secondo esemplifica ideali di platonica religiosità. Tuttavia, a quell’ altezza, la dimensione divina o trascendente (poiché questa trascendenza alle volte può avere un carattere più platonico-intellettuale) è ancora sentita come lontana, inattinta. Nei testi tardi cui qui ci si riferisce, invece, le regioni celesti sono quasi contem- plate dall’ardore dell’anima; sono intuite, sentite con una forza nuova, non più tanto intellettuale quanto religiosa.
Bisognava dunque attendere proprio che un simile ingegno si cimentasse con il suo dramma interiore d’uomo e d’anima perché l’eco del Poeta paradisiaco risuonasse delle corde più sincere e meravigliose di un nuovo poeta:
Non è sempre di colpa aspra e mortale
d’una immensa bellezza un fero ardore,
se poi sì lascia liquefatto il core,
che ’n breve il penetri un divino strale.
Amore isveglia e desta e’mpenna l’ale,
né l’alto vol preschive al van furore;
qual primo grado c’al suo creatore,
di qual non sazia, l’alma ascende e sale.
L’amor di quel ch’i’ parlo in alto aspira;
donna è dissimil troppo, e mal conviensi
arder di quella al cor saggio e verile.
L’un tira al cielo, e l’altro in terra tira;
nell’alma l’un, l’altr’abita ne’ sensi,
e l’arco tira a cose basse e vile.
Il testo è quello del sonetto 260, di schema ABBA ABBA CDE CDE (il più usato dall’autore). Nella prima quartina della fronte si vede bene la nuova forza poetica che guida il motivo dell’amore, non più concluso nel solo canale della dimensione umana, ma innalzato e iperuranizzato. Non è questa una novità nella lirica italiana o nell’arte rinascimentale in genere; basti tener presente il ruolo già evidenziato che la cultura del platonismo fiorentino, e in ispecie del trattato Dell’amore di Ficino, rivestiva già nell’opera di Michelangelo (ma allo stesso modo in tutta la cultura ufficiale italiana). Pur tuttavia all’altezza cronologica di questo componimento (probabilmente composto dopo il 1546, come ci informa Residori) gli sviluppi poetici del verso michelangiolesco hanno già assunto un carattere distintivo, che direi vada individuato nella assoluta preminenza che assume l’anelito al cielo come luogo di salvezza spirituale, pace eterna dell’anima. La bellezza, tema ancora centrale, è sempre trascesa dalla sua terrestrità (mi si perdoni il richiamo ono- friano). Ma non è ancora nello sviluppo tematico che si riduce l’assoluta unicità della poesia di Michelangelo nel panorama cinquecentesco. Si badi a quelle immagine del cuore «liquefatto», immagine così carica di materialità, parola «quasi brutta» per dirla con Gozzano. Eppure nell’architettura così tesa del componimento è immagine perfet-tamente intonata ai moti del «fero ardore» (si tenga presente poi, come ci ricorda Residori, che si tratta di eco di Salmi, 21, 15 già ripreso dal Magnifico nella sua Rappresentazione). Si rappresenta infatti, con immagini di aspra forza immaginativa, quel conflitto tipicamente michelangiolesco di un anima furiosamente anelante al cielo eppure costretta dalle catene terrestri, sì da generare lo strazio di una mortalità consapevolmente assunta come minaccia di dannazione per l’anima peccatrice. Interviene in questo caso però un bellissimo climax ascendente – anch’esso, mi pare, di gusto dantesco ‒ («Amore isveglia e desta e’mpenna l’ale », v. 5) che ripone certi toni di amara disfatta che ca- ratterizzano altri componimenti anteriori e che innesta nella tensione dialettica tra dimensione terrestre e dimensione celeste il cardine dell’amore-speranza, quasi luterana testimonianza («il giusto vivrà per fede» secondo la lettu- ra che Lutero propone di S. Paolo, Rom. I, 16-18) della possibilità della salvezza, sì che l’amore divino manifestatosi nel sacrificio di Cristo diviene luce di grazia per il peccatore, infondendo la speranza della salvezza («Le spine e’ chio - di e l’una e l’altra palma / col tuo benigno umil pietoso volto / prometton grazia di pentirsi molto, / e speme di salute a la trist’alma» 290, 5-8; «Ma pur par nel tuo sangue si comprenda, / se per noi par non ebbe il tuo martire, / senza misura sien tuo cari doni», 294, 11-14).
Dicevo sopra che riterrei un azzardo definire con troppa rigidità le linee evolutive della poesia di Michelangelo, poiché la forma non conclusa del corpus, senza un centro né un preciso e costante disegno-guida interno, renderebbe astrazione a posteriori una simile operazione. Pur tuttavia è compito del filologo e del critico, sempre uniti da carettiana concordia si vorrebbe sperare, gettar luce sulle linee visibili di tale disegno, magari sfumandone i contorni, esaltandone il chiaroscuro, come si è cercato di fare, perché il lettore moderno possa intravedere la forza anche sotterranea che questo grande artista seppe immettere nella nostra poesia.
Mario Castelvetro
|
|
1 L’edizione alla quale qui si farà riferimento è quella a cura di Matteo Residori: Michelangelo, Rime, con un saggio introduttivo di M. Baratto e uno scritto di T. Mann, Milano, Mondadori, 1998.
2 Gorni G., “Le ottave dei giganti”, in Michelangelo poeta e artista, Atti della giornata di studi (21 gennaio, 2005), a cura di Paolo Grossi e Matteo Residori, Quaderni dell’Hôtel de Galiffet, Parigi, 2005, pp. 41-52.
3 Francesco Berni, Rime, 63, 27-31, cit. anche nel commento di Residori, nel cappello introduttivo al capitolo in terza rima 85.
4 Binni W., Michelangelo scrittore, Torino, Einaudi, 1975, p. 38.
5 M. Baratto, “La poesia di Michelangelo”, Rivista di Letteratura Italiana, II (1984), pp. 405 – 423. Il testo figura adesso come introduzione all’edizione mondadoriana delle Rime.
6 Ivi, p. IX.
7 Ma per confermare quanto esposto sopra sull’altra frequenza che le opposizioni hanno nella poesia di Michelangelo basterà pro- cedere aprendo quei versi un po’ a caso come alle volte proponeva il Contini; verranno fuori simili esemplari: «ond’a pensar di minuir mie doglia / duplicando» 82, 6-7; «Vivo al peccato, a·mme morendo vivo» 32, 1; «Né per questo mi lassa / Amor viver un’ora / fra duo perigli, ond’io mi dormo e veglio: / la speme umile e bassa / nell’un forte m’accora, e l’altro parte m’arde, stanco e veglio» 232, 7-12. Si tenga comunque presente che non poche delle opposizioni della poesia buonarrotiana sono di ascendenza tradizionale e soprattutto petrarchesca.
8 Binni W., op. cit., p. 4.
9 Residori M., “«E a me consegnaro il tempo bruno». Michelangelo e la notte”, in Michelangelo poeta e artista, Atti della giornata di studi (21 gennaio, 2005), a cura di Paolo Grossi e Matteo Residori, Quaderni dell’Hôtel de Galiffet, Parigi, 2005, pp. 103-123. Un elemento chiave è il collegamento del richiamo a Febo (sono rarissimi i richiami alla mitologia classica nelle Rime michelangiolesche) con il Febo del Poggio noto solo attraverso uno scambio epistolare romano nel periodo 1534-35.
10 Ivi, p. 123.
11 Ma il tema dell’irriconoscenza del volgo e della sua incapacità di riconoscere il genio è presente, per esempio, anche nel bellissimo sonetto in lode di Dante (248), nel quale, tra le altre cose, si accusa il popolo fiorentino per l’esilio a cui costrinse il Poeta. Ma per tale invettiva si veda soprattutto il sonetto 250.
12 Per fornire una piccola antologia personale citerei almeno: 4, 10, 15, 33, 41, 42, 62, 87, 90, 93, 272; la serie sulla notte, 101-104, pur nel loro debito verso Lorenzo de’ Medici; i componimenti sul tema-metafora della scultura (46, 151, 152, 153, 236, 241); quelli spirituali dell’ultima stagione poetica tra cui citerei almeno 259, 260, 285, 300; quelli comico-realistici e burleschi 5, 20, 71, 85, 267. Inutile dire che al di fuori di qualsiasi distinzione riconducibile alla coppia (ormai fuori moda?) poesia-non poesia non si vorrà negare l’imprescindibile valore che prove “minori” assumono nella formazione di un poeta e nel raggiungimento dei risultati più elevati.
2 Gorni G., “Le ottave dei giganti”, in Michelangelo poeta e artista, Atti della giornata di studi (21 gennaio, 2005), a cura di Paolo Grossi e Matteo Residori, Quaderni dell’Hôtel de Galiffet, Parigi, 2005, pp. 41-52.
3 Francesco Berni, Rime, 63, 27-31, cit. anche nel commento di Residori, nel cappello introduttivo al capitolo in terza rima 85.
4 Binni W., Michelangelo scrittore, Torino, Einaudi, 1975, p. 38.
5 M. Baratto, “La poesia di Michelangelo”, Rivista di Letteratura Italiana, II (1984), pp. 405 – 423. Il testo figura adesso come introduzione all’edizione mondadoriana delle Rime.
6 Ivi, p. IX.
7 Ma per confermare quanto esposto sopra sull’altra frequenza che le opposizioni hanno nella poesia di Michelangelo basterà pro- cedere aprendo quei versi un po’ a caso come alle volte proponeva il Contini; verranno fuori simili esemplari: «ond’a pensar di minuir mie doglia / duplicando» 82, 6-7; «Vivo al peccato, a·mme morendo vivo» 32, 1; «Né per questo mi lassa / Amor viver un’ora / fra duo perigli, ond’io mi dormo e veglio: / la speme umile e bassa / nell’un forte m’accora, e l’altro parte m’arde, stanco e veglio» 232, 7-12. Si tenga comunque presente che non poche delle opposizioni della poesia buonarrotiana sono di ascendenza tradizionale e soprattutto petrarchesca.
8 Binni W., op. cit., p. 4.
9 Residori M., “«E a me consegnaro il tempo bruno». Michelangelo e la notte”, in Michelangelo poeta e artista, Atti della giornata di studi (21 gennaio, 2005), a cura di Paolo Grossi e Matteo Residori, Quaderni dell’Hôtel de Galiffet, Parigi, 2005, pp. 103-123. Un elemento chiave è il collegamento del richiamo a Febo (sono rarissimi i richiami alla mitologia classica nelle Rime michelangiolesche) con il Febo del Poggio noto solo attraverso uno scambio epistolare romano nel periodo 1534-35.
10 Ivi, p. 123.
11 Ma il tema dell’irriconoscenza del volgo e della sua incapacità di riconoscere il genio è presente, per esempio, anche nel bellissimo sonetto in lode di Dante (248), nel quale, tra le altre cose, si accusa il popolo fiorentino per l’esilio a cui costrinse il Poeta. Ma per tale invettiva si veda soprattutto il sonetto 250.
12 Per fornire una piccola antologia personale citerei almeno: 4, 10, 15, 33, 41, 42, 62, 87, 90, 93, 272; la serie sulla notte, 101-104, pur nel loro debito verso Lorenzo de’ Medici; i componimenti sul tema-metafora della scultura (46, 151, 152, 153, 236, 241); quelli spirituali dell’ultima stagione poetica tra cui citerei almeno 259, 260, 285, 300; quelli comico-realistici e burleschi 5, 20, 71, 85, 267. Inutile dire che al di fuori di qualsiasi distinzione riconducibile alla coppia (ormai fuori moda?) poesia-non poesia non si vorrà negare l’imprescindibile valore che prove “minori” assumono nella formazione di un poeta e nel raggiungimento dei risultati più elevati.
|
|
|
|
Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.
Click here to edit.
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati