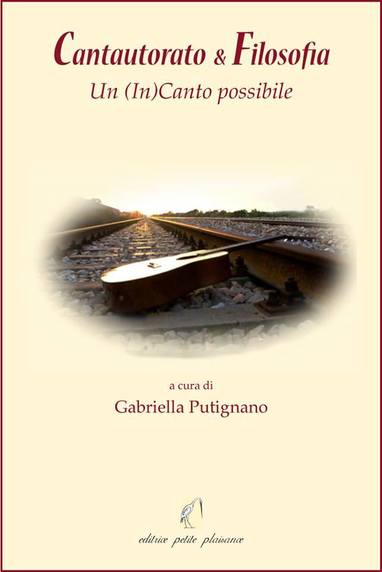|
Gabriella Putignano ci racconta Cantautorato & Filosofia – Un (In)Canto possibile, un libro edito da Petite Plaisance da lei curato, in cui il cantautorato – da Guccini e Lolli a Fiumani e i Baustelle - diventa un possibile inizio per avvicinarsi alla filosofia.
AB: Parliamo dei brani scelti come punto di partenza per fare filosofia: è stata scelta prima la tematica da trattare e poi una canzone adatta o sono stati i brani a dare il la per riflettere sulle problematiche analizzate nel testo? GP: Posso rispondere relativamente al cantautore da me analizzato: Claudio Lolli. Agli altri relatori ho concesso - com’è nel mio stile - totale libertà e non so se loro abbiano scelto prima i brani e poi il tema o viceversa. Per quanto mi riguarda, ho scelto prima l’artista su cui soffermarmi: non solo per una mera preferenza personale, ma anche e soprattutto perché trovo le canzoni di Lolli del tutto stimolanti per riflettere su certi temi cari alla filosofia: il senso o il non-senso dell’esistere, l’alienazione, il desiderio umano di felicità. In particolare, ho lavorato sull’ultimo album di Lolli, “Il grande freddo” - premiato quest’anno con la Targa Tenco quale miglior disco in assoluto del 2017 - e l’ho fatto ancor prima della pubblicazione sulla base dell’anteprima e di alcune dichiarazione rilasciate da Claudio. Ritengo che “il grande freddo” cantato da Lolli sia estremamente interessante per comprendere - sia pure da un piano artistico - l’odierna anestesia del cuore, da me poi approfondita teoreticamente attraverso autori come Cristopher Lasch, Eva Illouz, Franco Berardi. Posso aggiungere, per ritornare alla tua domanda, che - durante la mia attività di insegnamento - scatta il meccanismo inverso: sono le tematiche da trattare o i filosofi da studiare a darmi il la per un fecondo intreccio con alcuni brani musicali. AB: Spesso si parla del cantautorato di oggi, come fosse di serie B rispetto ai grandi nomi del passato. Quali sono le differenze rilevate maggiormente alla luce della considerazione dei brani del passato e attuali da un punto di vista filosofico? GP: Premetto una questione, probabilmente un mio limite: non sono molto brava nel porre gerarchie, nello specifico fra cantautorato di “serie A” e cantautorato di “serie B”. Senza dubbio oggi abbiamo una evidente diffusione di una certa musica di consumo, che è solo rumore stordente, per dirla con Rachel Bespaloff, diversione funzionale a un processo di umiliazione delle intelligenze. Eppure, io credo che questo non debba farci eludere una parte di musica che è, invece, assai significativa. Penso ad artisti italiani come Niccolò Fabi o Brunori Sas, in grado di cantare in modo splendido l’incalcolabilità dell’esistenza e la malafede, in senso sartriano, che troppo spesso ci riguarda. Una differenza fra questi cantautori e quelli del passato è che i primi non possono più essere “etichettati” rigidamente in una sfera politica - o meglio, partitica. Ho, inoltre, riscontrato - avendo a che fare con loro - che è molto ascoltata dagli adolescenti di oggi la musica rap, una musica per lo più decostruttiva, di denuncia, nella quale i ragazzi trovano espressi i loro bisogni e le loro paure. A differenza del passato, questa musica (ma è un problema chiaramente dei nostri tempi, che trascende l’orizzonte musicale) si arresta alla sola pars destruens e sembra incapace di tracciare un’estetica collettiva, di trapassare dal lamento - anche un po’ autoreferenziale - alla “locomotiva” di un sogno condiviso. AB: I paper che costituiscono il testo sono il risultato di contributi svolti oralmente: quali sono stati i feedback dei destinatari dell’operazione proposta dai contribuenti al testo? E quali quelli dei docenti di generazioni precedenti? GP: I feedback sono stati, senz’altro, positivi. Mi ha reso felice, durante gli incontri, l’entusiasmo di alcuni giovani studenti del corso di laurea in Filosofia di Bari: le loro domande e il loro autentico interesse sono aspetti, per me, indimenticabili e fonte di soddisfazione. Non abbiamo avuto una grande presenza di docenti delle generazioni precedenti, forse perché in città - a differenza dei piccoli centri - è più difficile diffondere iniziative fra le svariate che ce ne sono o farsi notare. Bari, comunque, è una città che può vantare la presenza di diversi docenti della generazione passata aperti alle innovazioni, veri maestri nella didattica della filosofia. Ambra Benvenuto
Scrivono in PASSPARnous:
Bruno Benvenuto, Ubaldo Fadini, Tiziana Villani, Claudia Landolfi, Alfonso Amendola, Mario Tirino, Vincenzo Del Gaudio, Alessandra Di Matteo, Paulo Fernando Lévano, Enrico Pastore, Francesco Demitry, Sara Maddalena, Alessandro Rizzo, Gianluigi Mangiapane, Nicola Lonzi, Marco Bachini, Daniel Montigiani, Viviana Vacca, Fabio Treppiedi, Daniele Vergni, Mariella Soldo, Martina Lo Conte, Fabiana Lupo, Roberto Zanata, Bruno Maderna, Silvia Migliaccio, Alessio Mida, Natalia Anzalone, Miso Rasic, Mohamed Khayat, Pietro Camarda, Tommaso Dati, Enrico Ratti, Ilaria Palomba, Davide Faraon, Martina Tempestini, Fabio Milazzo, Rosella Corda, Stefania Trotta, Manuel Fantoni, Marco Fioramanti, Matteo Aurelio, Giuseppe Bonaccorso, Rossana De Masi, Massimo Maria Auciello, Maria Chirico, Ambra Benvenuto, Valentina Volpi, Massimo Acciai, Gianluca de Fazio, Marco Maurizi, Daniele Guasco, Carmen Guarino, Claudio Kulesko, Fabrizio Cirillo, Francesca Izzi, Antonio Mastrogiacomo, Giulia Vencato, Alessandro Baito, Margherita Landi, Mirjana Nardelli, Stefano Oricchio, Manlio Palmieri, Maria D’Ugo, Francesco Panizzo. |
Intervista
a Valeria Cimò di Roberto Zanata WORMHOLES
Una performance audio-visiva di Roberto Zanata Processing
di Roberto Zanata |
|
PASSPARnous:
|
Torna alla Home
|
|
|
Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.
sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.
Psychodream Theater - © 2012 Tutti i
diritti riservati